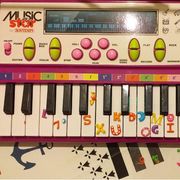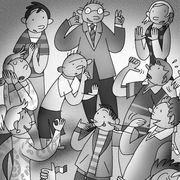Istruzioni per amare. Accettare i limiti e vivere felici
Gli psicologi Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini: nelle relazioni d’amore è normale non capirsi, soffrire, avere idee diverse. L'importante è amarsi integrando le differenze, non eliminandole

Di amore ci si riempiono pagine di libri, interminabili discussioni, articoli di cronaca. È un sentimento complesso, che travolge, può far male oppure far realizzare. Una psicologa, Elisa Veronesi, e un medico e psicologo, Paolo Maria Manzalini, si sono messi all’opera per indagare l’amore, in un testo edito da San Paolo, Stranamore, il cui titolo richiama quello di un film di Stanley Kubrick, che segue un altro lavoro a quattro mani che ha analizzato la paura.
Dopo quello sulla paura, un libro sull’amore. Che cosa vi ha spinto a indagare un argomento così complesso?
Abbiamo sentito la necessità di riabilitare l’amore. Infatti, anche se si tratta di un argomento sempre in voga, oggi a parlare dell’amore come di un sentimento positivo e pervasivo si corre il rischio di apparire ingenui buonisti. Da un lato la società dell’immagine banalizza l’amore, riducendolo alle sensazioni intense e momentanee che accompagnano le passioni; dall’altro lato le notizie di cronaca indicano l’amore come causa di omicidi o violenza. Sembra quasi non valga la pena amare, invece questo sentimento è fondante la dimensione umana. L’amore è elemento costitutivo della nostra essenza, ma anche delle nostre società, così come diceva Margaret Mead, per la quale «L’inizio della civiltà non è una scoperta, ma un gesto. Non una pietra, ma un atto d’amore». La comparsa della specie umana è segnata dal culto dei morti, cioè degli affetti scomparsi, ma anche dalla cura reciproca all’interno delle comunità.
Nel vostro libro si evince come sia difficile definire cosa sia l’amore, un sentimento che ci coinvolge totalmente. Perché amiamo?
La risposta sta nella nostra storia evolutiva, nell’eredità genetica che, come specie umana, condividiamo coi mammiferi. L’amore è quel sentimento che crea le relazioni e le mantiene attraverso tutte le piacevoli sensazioni positive che lo accompagnano. In altre parole, la sua finalità consiste nel promuovere legami utili alla nostra sopravvivenza: cura, accudimento, protezione e riproduzione sono i risultati di uno scambio d’amore. Esso quindi ci coinvolge totalmente perché è la base comune che dà origine a legami di natura diversa: fra genitori e figli, di coppia, di vera amicizia, ma anche – e questo solo per noi esseri umani – di solidale vicinanza a chiunque viva una situazione di sofferenza, disagio o dolore.
Genetica, ambiente, storia personale. Quali sono gli elementi che entrano in gioco in una relazione d’amore?
Ogni espressione umana è sempre frutto della complessità, e anche quando si parla d’amore entrano in gioco tutti i fattori elencati. La genetica spinge in direzioni prestabilite: l’innamoramento e il legame genitori-figli ne sono esempio. Il nostro temperamento declina un modo personale di approcciare le vicende dell’amore. L’ambiente (familiare, storico, socioculturale) ci condiziona nel significato che diamo all’amore, per esempio in termini di valore ed impegno. Di fronte a tanta complessità l’unica strada è quella di aumentare la consapevolezza del modo in cui vogliamo vivere l’amore dentro la nostra vita. Oggi sembra che amare sia un atteggiamento perdente, mentre la nostra storia evolutiva racconta che è instaurando relazioni di cura ed empatica vicinanza che abbiamo costruito le nostre migliori civiltà.
Amare fa bene?
Sempre! Ma a condizione che sia vero amore, cioè sia connotato da reciprocità e dalla sana cura di Sé. Gli effetti benefici dell’amore, così vissuto, travalicano lo stretto ambito della relazione a due, e divengono generativi di effetti che si estendono anche ad altri soggetti, l’esempio più naturale è l’amore di coppia, che genera amore per un terzo, che è il figlio, fino alla capacità di vivere amore prosociale, quello finalizzato a un bene comune, anche quello di chi non conosco e forse non conoscerò mai. Amare però ha un prezzo: nella fiducia si diviene vulnerabili all’altro, che può farci enormemente soffrire. E noi tutti sappiamo quanto sia doloroso essere esposti a rifiuti o persino tradimenti.
Amare, essere amati e amarsi. Nel vostro libero ponete attenzione a questo terzo flusso dell’amore. Perché è così importante l’amore verso sé stessi?
L’amore sano per sé stessi ci protegge da possibili prevaricazioni, ed è il vero antidoto al narcisismo dilagante. Quest’ultimo porta a crogiolarsi negli aspetti soddisfacenti e riusciti di Sé, svalutando gli altri al fine di essere sempre migliore o superiore, senza considerare le proprie imperfezioni. Il vero amore per sé stessi, invece, consiste nella capacità di guardare in modo autentico e tenero, senza spietatezza o disgusto, non solo ciò in cui riusciamo, ma anche tutto ciò che in cui ci sentiamo manchevoli o persino sbagliati, e di provare con semplicità e costanza a migliorarlo. La possibilità di accettarsi in tutto, anche nelle nostre incapacità e fragilità, è la base dell’interconnessione e della solidarietà: potendo accettare i miei limiti, saprò amare l’altro in quanto simile a me, cioè anch’egli portatore dei suoi propri limiti.
Non sempre va tutto bene anche nel legame d’amore tra genitori e figli. Quali sono i segnali, i comportamenti, che evidenziano un modello di attaccamento non adeguato o persino dannoso? Quanto essere amati da bambini, in famiglia, ci determina?
Tutti i genitori sono portati ad amare i propri figli, così come ogni mammifero è spinto ad accudire il proprio cucciolo. Ma, a partire da Bowlby – che ha definito la Teoria dell’Attaccamento -, sappiamo che il tipo di relazione che il bambino sviluppa col genitore diviene una sorta di “prototipo”, un modello mentale inconsapevole con cui leggerà sé stesso e l’altro in tutte le relazioni intime future. La sensazione di sentirsi “al sicuro” nel mondo, la capacità serena di chiedere aiuto in caso di difficoltà, una base sana di autostima e fiducia in sé stessi sono il lascito di una relazione accudente tendenzialmente in modo sereno (non spaventato o preoccupato) presente, costante, non invasiva. Amare un figlio oggi richiede anche molta attenzione riguardo l’utilizzo degli smartphone. Occorre stare molto attenti a stare davvero coi bambini quando… siamo coi bambini! Per uno sviluppo sano e naturale del cervello occorrono sguardi condivisi, parole e silenzi anch’essi condivisi, persino noia socialmente condivisa. L’utilizzo degli smartphone in presenza dei piccoli limita o impedisce i naturali scambi relazionali che la natura prevede, e va ancora peggio se a utilizzare i dispositivi elettronici sono i piccoli.
Ciascuno di noi vorrebbe una ricetta per imparare ad amare, per evitare di soffrire in una relazione d’amore, in un contesto amicale, per non soccombere di fronte al dolore dell’amato o alle ingiustizie. Ricetta non c’è, ma qualche suggerimento?
Occorre accettarlo: amare apre inevitabilmente alla sofferenza della perdita, basti pensare al dolore della morte, o della malattia dei nostri cari. È il prezzo del grande bene di cui abbiamo goduto.
Nelle relazioni d’amore è normale non capirsi, soffrire, avere posizioni e idee diverse: il confronto e il dialogo sono strumenti per imparare ad amarsi senza eliminare (impossibile!), ma integrando le differenze. Possiamo avere il coraggio di soffermarci periodicamente per interrogarci con l’altro su come vanno le cose, facendo una sorta di manutenzione periodica delle nostre relazioni affettive. Questa attenzione viene suggerita generalmente all’interno della coppia, ma è molto bello viverla anche coi figli, coi genitori, con gli amici. Aiuta a trovare mediazioni, a continuare a volerci bene accettando noi stessi e l’altro nelle – nostre e sue - inevitabili fragilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi