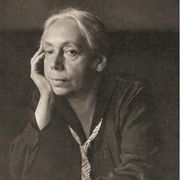Una Mappa del Nilo per collegare Vaticano e Arabia Saudita
La partecipazione della Biblioteca Apostolica Vaticana alla Biennale di Arti islamiche di Gedda, è un fatto storico. Il primo rapporto ufficiale tra Santa Sede e regno saudita passa per la cultura

Acollegare la Santa Sede e l’Arabia Saudita ora c’è una mappa del Nilo lunga sei metri. È quella compilata alla fine del XVII secolo (l’XI nel calendario islamico) su indicazioni del viaggiatore ottomano Evliya Çelebi – la vedete attraversare queste pagine – riportando graficamente gli appunti dell’itinerario da lui compiuto nel 1683 sul grande fiume, dal delta fino verso le sorgenti, perse nelle mitiche Montagne della Luna, e confluiti nel suo fondamentale Seyahatname, racconto in dieci volumi dei suoi viaggi. È un pezzo unico, uno dei tesori della Biblioteca Apostolica Vaticana dove è giunta grazie a Giuseppe Assemani, sacerdote maronita divenutone prefetto nel 1739, che nel 1736 l’aveva acquistata a Istanbul. La mappa di Çelebi è esposta fino al 25 maggio a Gedda nella seconda edizione della Islamic Arts Biennale, allestita in una vasta area a lei dedicata nello sterminato King Abdulaziz International Airport, la porta privilegiata di chi si accinge a compiere l’Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca. Con lei dalla Vaticana sono arrivati altri dieci volumi, tanto manoscritti quanto a stampa, dalle prime traduzioni – parziali o integrali – del Corano, come il codice realizzato nel 870 a Bisanzio, una polemica di Niceta che contiene frammenti in greco del libro sacro, a testi astronomici, fino al Liber Abaci in cui Leonardo Fibonacci introduce per la prima volta in Occidente lo “zero”, desumendolo dagli arabi i quali a loro volta lo avevano ricavato dalla matematica indiana. I pezzi, insieme ad altri giunti da musei e biblioteche di tutte il mondo e appartenenti a tutto l’ecumene islamico, da al-Andalus all’Indonesia, sono esposti nella sezione alMadar, dedicata alla fascinazione della teologia e della spiritualità islamiche verso i “numeri” e la sua ricaduta in un sistema culturale e cultuale che si declina attraverso astronomia, geometria, simmetria, musica, architettura. È un evento che non è riduttivo definire storico. Tra Santa Sede e Arabia Saudita, infatti, non esistono rapporti diplomatici. «Siamo stati contattati dai curatori, sono venuti a trovarci perché ci volevano a tutti i costi – racconta Angelo Vincenzo Zani, Bibliotecario di Santa Romana Chiesa – In particolare il direttore artistico Abdul Rahman Azzam ha insistito sull’importanza della cultura e della spiritualità per il dialogo». «L’arte e la cultura cercano la verità – ha detto lo stesso Azzam in una intervista a “Vatican News” – e quindi trascendono qualsiasi limitazione geografica e attraversano le frontiere: dall’India, al mondo islamico, all’Europa. Siamo convinti che collaborazioni come questa aiutino a comprendere come la cultura sia davvero un modo per unire le persone in modo armonioso». Il titolo della Biennale è “And all that is in between”, ossia “e tutto ciò che sta in mezzo (tra terra e cielo)”, versetto coranico legato alla Creazione: «Questo tema – scrive Aya Albakree, direttrice generale della Diriyah Biennale Foundation – ci invita a superare le prospettive binarie e a confrontarci con gli spazi sfumati che si trovano nel mezzo».
La società saudita sta attraversando una tangibile fase di trasformazione. Riprova ne è il fatto che monsignor Zani ha trascorso i giorni dell’inaugurazione a Gedda nei suoi abiti vescovili. Croce compresa: «Ho chiesto come sarei dovuto venire, mi hanno risposto: “Come vescovo”». Certo, la presenza della BAV si inserisce in una rete di collaborazioni di altissimo prestigio intessuta dalla Biennale, ma ha in ogni caso destato un estremo interesse. E Zani è stato continuamente oggetto di domande, fotografie, interviste: «Al di là della curiosità – commenta – ho registrato soprattutto il desiderio di capire». In Arabia Saudita (dove si stima che vivano un milione di cristiani, in larga parte filippini) non è consentito praticare pubblicamente una fede diversa da quella musulmana e gli oggetti appartenenti a religioni diverse dall’Islam sono vietati. Il contesto era sì particolare e “protetto” ma solo fino a un certo punto, perché la Biennale espone oggetti sacri per l’Islam strettamente legati alla Ka’ba – dai drappi che la coprono al “castone” della pietra nera – che per la prima volta non solo escono dalla Mecca ma sono resi accessibili a chi non è musulmano. Il cambio di prospettiva è significativo: la dimensione religiosa (c’è la cura che questi oggetti anche in mostra restino “sacri”) è forza identitaria ma non esclusivista, aprendosi così alla possibilità della condivisione.
Come spiega Delio Proverbio, Scriptor orientalis della BAV, «è stato un cammino lungo, con proposte e controproposte, che ha portato a prestiti straordinari come il commento il Niceta che, essendo antecedente all’anno Mille, in teoria non sarebbe potuto uscire dalle mura leonine. Ma il manoscritto sta benissimo, ed era importante che fosse qui». Un pezzo che condensa il senso dell’operazione è il Corano in lingua araba ma traslitterato in caratteri ebraici, un unicum dai connotati ancora poco chiari. Prodotto probabilmente in Sicilia nel XV secolo, appartenne a Flavio Mitridate, un ebreo convertito e figura fondamentale per i circoli umanistici dell’epoca, e a Pico della Mirandola e porta annotazioni di Nicolò Cusano: «Le chiose – osserva Proverbio – per altro rivelano che all’epoca circolavano traduzioni latine, a noi ignote, di importanti commenti coranici, ospitati nelle biblioteche del circolo di umanisti come, appunto, Pico ed Egidio da Viterbo. I volumi della Vaticana, dunque, raccontano l’interesse del mondo cristiano verso quello islamico. La volontà di capire, la circolarità della scienza, la ricezione delle innovazioni culturali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA