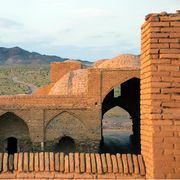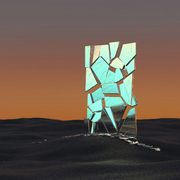Marco Erba: educare alla speranza tra i banchi di scuola
Il libro “Scintille di bellezza” rielabora le rubriche scritte da Marco Erba su “Avvenire”: una riflessione su come accendere la passione per la vita grazie alla letteratura

La letteratura - questo è uno dei suoi valori più preziosi - ha un grande potenziale educativo: apre all’immaginazione, offre sguardi alternativi sul mondo, rovescia la logica consueta, propone soluzioni utopiche ai problemi reali. Per Freud l’arte è un “sogno a occhi aperti”, capace di condurre il fruitore a uno stato emotivo e sensoriale nuovo. Una delle funzioni a cui la letteratura assolve è proprio questa: farsi interprete dei lati nascosti della psiche umana. La letteratura costituisce perciò, come si è espresso Remo Ceserani, una formidabile possibilità di «educazione dell’immaginario».
Per lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, grazie alla sua sostanza morale e al suo potere di favorire l’immedesimazione, la letteratura è in grado di produrre in chi la frequenta autentiche catarsi: «In virtù di questo fenomeno di immedesimazione la questione morale non resta al solo livello cognitivo, ma entra a far parte della personalità stessa del lettore; diventa insomma il suo problema esistenziale. Per questo l’impatto morale della letteratura, quando è buona, raggiunge, sconvolgendoli, gli strati più profondi della personalità». Il rapporto tra letteratura ed emozione, tra immaginario letterario e sfera emotiva, è perciò molto stretto. Ha scritto Ezio Raimondi: «Quando leggiamo, ci portiamo dietro le nostre origini: queste origini danno un valore, una credenza, aggiungono un significato. (...) Un libro non è soltanto i significati che comunica, ma i significati che vi aggiungiamo, garantiti, se non dalla correttezza intellettuale, dall’intensità del sentimento, dell’emozione, dell’affetto».
Sono cose che sa molto bene, per esperienza diretta, Marco Erba, firma di punta di “Avvenire” sui temi della scuola e dell’educazione. Perché Erba insegna Lettere in un liceo, dove tutto ciò accade ogni giorno. Ma la “materia letteratura” rimarrebbe lettera morta se non ci fosse una “materia umana” pronta a farsi provocare da essa. All’insegnante stanno a cuore entrambe queste “materie”. Lo diceva già don Milani: «Dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo».
Nel suo libro Scintille di bellezza. Trenta storie per educare alla speranza tra i banchi di scuola (e non solo) (Avvenire-Vita e Pensiero, pagine 176, euro 15,00), che raccoglie una serie di articoli usciti originariamente sul nostro giornale, Erba intreccia efficacemente i grandi classici con il proprio vissuto e con quello dei suoi studenti. Omero, Virgilio, Dante, Petrarca, Manzoni sanno ancora parlare ai giovani di oggi, che, interpellati da quelle pagine apparentemente lontane, riescono a confidare, in un tema o in un colloquio con il loro professore, problemi personali, familiari, relazionali, paure e insicurezze, ferite e fragilità, ma anche emozioni belle e positive che altrimenti non avrebbero trovato voce.
Un libro può trasformare il corso di una vita, come è successo a Umberto, conosciuto dall’autore all’inizio del liceo durante la sua prima supplenza, cinico e insolente, e ritrovato anni dopo completamente cambiato, attento alle problematiche sociali e impegnato nel volontariato internazionale. Perché in quarta superiore una professoressa gli ha fatto leggere I dolori del giovane Werther di Goethe: rispecchiandosi in quel romanzo, inizia il mutamento.
Questo però non succede sempre nelle aule scolastiche, dove forse si dà troppa importanza alla volontà e poca al desiderio: Elia lo comprende, ed è lui a spiegarlo al professore, leggendo il Secretum di Petrarca. «Per questo – scrive Erba – la scuola dovrebbe accendere desideri più che imporre aridi doveri. Tra i banchi, ogni studente dovrebbe essere stimolato a scoprire ciò che più profondamente desidera, perché il desiderio è la via per realizzare sé stessi».
Un bravo insegnante deve essere in grado di capire che spesso certe provocazioni degli adolescenti, che noi adulti vorremmo punire in virtù della nostra autorità e del richiamo al rispetto delle regole, sono in realtà «urla di dolore per ferite che non trovano voce». E allora è importante lavorare insieme per far cadere quelle maschere - la maschera della trasgressione, dell’indifferenza, della svogliatezza o del perfezionismo - dietro cui i ragazzi (ma anche noi adulti) molte volte ci trinceriamo.
Le varie “scintille” (i trenta capitoli in cui è articolato il volume) affrontano diversi temi: la motivazione allo studio e la sua assenza, il peso del retroterra familiare sulle vite dei ragazzi, il rapporto (che talora può rivelarsi tossico) tra i sessi, il bullismo, il problema della conciliazione tra convenzioni sociali e libertà individuale.
In uno degli ultimi capitoli l’autore ricorda la figura luminosa di don Carlo, un salesiano che era stato suo professore e preside alle scuole medie. Si impara a essere insegnanti - ma potremmo dire, più in generale, a essere uomini e donne - dagli esempi che abbiamo ricevuto. Ecco le parole, semplici e sagge, di quel prete oggi anziano, ma ancora capace di essere un punto di riferimento: «L’artigiano costruisce manufatti. L’elettricista costruisce impianti. Il meccanico costruisce automobili. Noi insegnanti accompagniamo ragazze e ragazzi che costruiscono sé stessi, per diventare le donne e gli uomini che saranno. Noi costruiamo futuro».
E sull’arte di insegnare (o, se si preferisce, sulla “vocazione” di insegnare, perché quello del docente non è un mestiere come un altro, ma una scelta di vita) scrive Marco Erba: «L’insegnamento è promessa, impegno. L’insegnamento è anche sforzo della volontà, è anche fatica. Ma è una fatica che si accetta volentieri, se ci si appassiona prima di tutto alla materia umana, mettendosi in gioco nelle relazioni: solo così si scopre che anche questa fatica, paradossalmente, è un privilegio. Bisogna desiderare di essere dentro le vite di coloro che incontriamo per accompagnarli meglio che possiamo. Bisogna, insomma, ricordare che la materia in sé è al servizio della materia umana. Bisogna amare la materia umana più che la materia in sé».
© RIPRODUZIONE RISERVATA