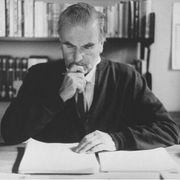William Wall: «La lettura è l’unica strada per capire l’altro»
L’autore irlandese intreccia l’innocenza dell’infanzia alla violenza della storia, scrivendo dell’Irlanda del 1969 e dei Troubles, attraverso gli occhi di due fratelli
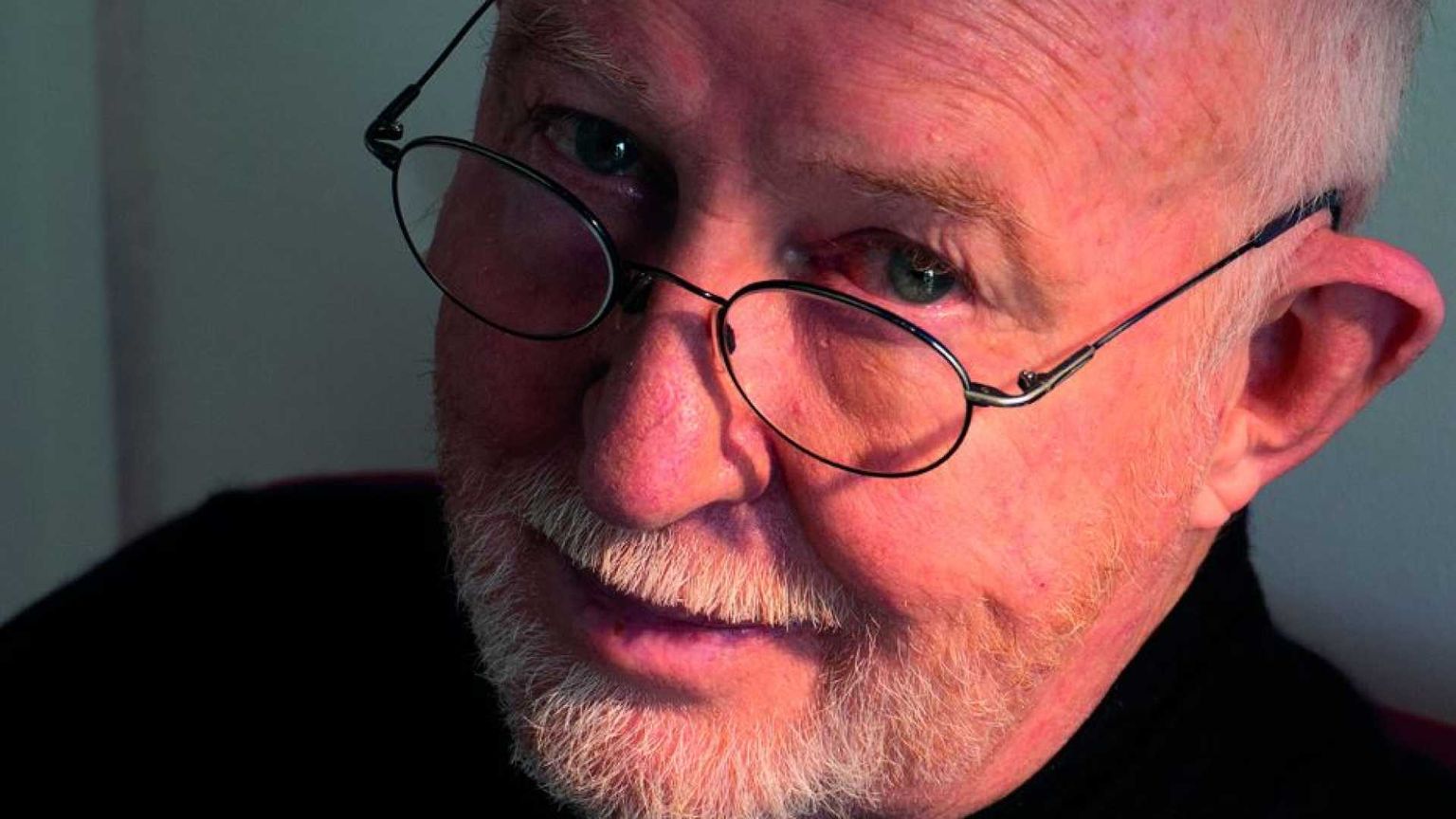
Un albero come luogo di immaginazione e rifugio, ma anche come emblema di fragilità dell’ambiente e dell’unità familiare. L’albero della libertà (Aboca, pagine 208, euro 17,00) è un romanzo generazionale, un libro che cattura il passaggio dall’innocenza dell’infanzia alla consapevolezza della complessità del mondo, intrecciando memoria storica e fantasia, con la sensibilità di un grande autore, William Wall, narratore e poeta, nato a Cork, ma da anni diviso tra l’Irlanda e la Liguria: «Si somigliano queste due terre – dice – ma in Liguria c’è anche il sole». In occasione di Pordenonelegge Wall presenterà questa mattina il suo romanzo, ambientato nel sud dell’Irlanda nel 1969, in un periodo cruciale, che anticipa l’esplosione dei Troubles (la violenza politica) nell’Irlanda del Nord. Protagonisti della storia sono due fratelli, Liam Óg e Seán, che trascorrono le giornate sulla spiaggia di Cannavee esplorando il mondo con la curiosità propria dell’infanzia. Lì scoprono un grande albero trasportato dalle maree, che diventa il fulcro delle loro fantasie e dei giochi estivi, simbolo di libertà, immaginazione e connessione con la natura. Tuttavia, il passaggio all’adolescenza li costringerà a confrontarsi con la brutalità della guerra civile, e l’incontro con Monica, una ragazza la cui casa è stata bruciata durante gli scontri settari, introduce i ragazzi alla violenza del mondo adulto.
C’è qualcosa della sua infanzia e dei suoi luoghi nell’esperienza di Liam Óg e Seán?
«Sì, in un certo senso il libro è basato sulla mia infanzia. Sono cresciuto sulla baia di Cork e, proprio come Liam Óg e Seán, passavo l’estate in spiaggia o in barca: mio padre era un pescatore. Però i personaggi sono ispirati anche ai miei nipoti, che oggi hanno 9 e 12 anni, quindi all’incirca l’età dei due protagonisti. Loro, come nel libro, passano l’estate al mare, sono curiosi, cercano sempre di fare cose belle. Naturalmente hanno anche elementi della loro epoca – guardano la tv, usano altri media – quindi nei personaggi c’è un intreccio tra la mia infanzia e la loro. Quanto alle personalità, però, direi che Liam Óg e Seán somigliano ai miei nipotini».
Questo albero che i due fratelli trovano sulla spiaggia cosa rappresenta?
«Prima di tutto la fantasia: quando avevo la loro età c’era un grande melo in giardino, che per me diventava ogni volta qualcosa di diverso: una città, un aereo, una nave. L’albero era il luogo dove poter immaginare. Ma è anche simbolo della natura e, insieme, della distruzione che l’uomo ha inflitto al pianeta: il cambiamento climatico, l’inquinamento. In questo senso è molto simbolico. Infine, in un altro senso ancora: rappresenta l’unità, l’amore, la famiglia. È quindi un simbolo complesso, con più livelli».
C’è poi il personaggio di Monica, che introduce nella vita dei ragazzi la violenza del mondo esterno. Come nasce questa figura?
«Quando avevo 15 anni, nel mio villaggio sulla costa sud dell’Irlanda arrivò una famiglia di rifugiati, fuggiti dall’Irlanda del Nord a causa dei pogrom di quel periodo. Tra loro c’era un ragazzo con cui diventai amico e che mi parlò molto della sua vita. Era il 1969, proprio l’anno in cui è ambientato il libro. Scrivendo, ho deciso di trasformare quel ricordo in un personaggio femminile. Monica porta nel paradiso dei ragazzi – la spiaggia, il loro rifugio – le notizie del mondo esterno. In un certo senso è come il serpente nell’Eden: non perché voglia rompere la perfezione, ma perché rappresenta l’irruzione della realtà».
A proposito del 1969, cosa significa, dal punto di vista storico e sociale, collocare la storia all’inizio dei Troubles?
«Molti romanzi ambientati nell’Irlanda del Nord durante i Troubles guardano agli ultimi anni, io invece volevo raccontare il 1969, che ricordo molto bene: avevo 14-15 anni. La mia famiglia fu la prima ad avere una tv nel villaggio, quindi tutti venivano da noi a guardare le notizie. Seguivamo con angoscia le manifestazioni per i diritti civili e, subito dopo, la reazione violenta del governo. Bisogna ricordare che lo Stato dell’Irlanda del Nord, nato nel 1920, era stato costruito come “uno Stato protestante per un popolo protestante”: i cattolici non avevano diritti civili, come spiego anche nelle note al libro. Per noi era uno shock. Mia zia teneva la valigia pronta perché temeva lo scoppio di una guerra civile che avrebbe coinvolto anche la Repubblica. L’esercito era stato mobilitato al confine: era un momento pericoloso, difficile, molto triste. Ho voluto raccontarlo con lo sguardo che avevo allora, quello di un ragazzo ingenuo».
Questo crea un intreccio particolare nel romanzo: da un lato l’innocenza dell’infanzia, dall’altro la brutalità della guerra civile. Come ha lavorato su questo equilibrio?
«Ho cercato di creare un certo disagio nella struttura, inserendo all’inizio di ogni capitolo brevi estratti dai giornali dell’epoca. Così, mentre la vita dei ragazzi appare spensierata, subito dopo irrompe la realtà, un attacco, una rissa, una notizia drammatica. Volevo mantenere questo ritmo destabilizzante, perché non si può guardare quel mondo solo con gli occhi dei bambini. Era un paradiso per loro, sì, ma non per i genitori. E la Repubblica stessa non era affatto un paradiso».
Secondo lei che eredità hanno lasciato i Troubles alle nuove generazioni irlandesi?
«Molto è stato dimenticato, e forse è un bene, perché vivere sempre nel ricordo delle cose brutte non aiuta. Forse ci ha lasciato una diffidenza verso la violenza, un odio per la violenza. Forse ci ha resi più vicini ad altri popoli che soffrono, come i palestinesi, molto sostenuti in Irlanda: anche noi abbiamo conosciuto colonizzazione e carestie. È un’eredità complessa».
Nei suoi romanzi c’è attenzione alla lingua, spesso ha un tono lirico. In questo libro, però, l’elemento poetico convive con un registro più realistico. Come ha lavorato su questa tensione?
«Per anni ho scritto narrativa e poesia insieme: al mattino lavoravo al romanzo, poi passavo alla poesia, e le due cose finivano per contaminarsi. Per me scrivere è scrivere: anche in narrativa è fondamentale scegliere le parole giuste, lavorare sul suono, sulla musicalità, cercare un po’ della “magia” della realtà. Questo si nota soprattutto nelle descrizioni della natura. Il mare, ad esempio, è quasi un personaggio nei miei libri».
In che modo la letteratura può avere ancora un ruolo nel raccontare le ferite storiche di un Paese?
«Leggere è fondamentale. Un libro non esiste senza un lettore: può stare in biblioteca per sempre, ma finché nessuno lo legge è come se non ci fosse. Per questo dobbiamo fidarci dei lettori. La lettura è essenziale per la vita: ci permette di entrare nel mondo dei personaggi, di capire come pensano gli altri, di metterci nei panni altrui. Solo così possiamo sviluppare solidarietà, amore, tolleranza. Senza lettura, credo sia difficile arrivare a questa conoscenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA