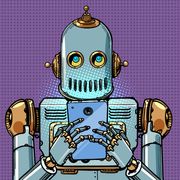L'unità di misura della pace? Sono i bambini
La continuità della sofferenza innocente attraversa i conflitti. Per questo deve diventare un criterio di giudizio la possibilità di tornare a sorridere

Nel nostro presente saturo di conflitti, ciò che colpisce con maggiore violenza non è soltanto il numero delle guerre aperte, quanto piuttosto la rapidità sconcertante con cui esse smettono di essere percepite come eventi morali, come scandali che esigono una risposta, e scivolano invece nella categoria opaca dei fatti di contesto, delle circostanze date, di ciò che semplicemente accade mentre il mondo continua a girare. Gaza, l’Ucraina, il Sudan, il Congo: nomi che scorrono nelle cronache come coordinate geografiche, come punti su una mappa del disastro, sempre più raramente come luoghi abitati da vite concrete, da corpi che sentono freddo e fame, da volti che avevano un nome prima di diventare numeri. In questo scorrimento continuo, in questa processione di immagini che si consumano l’una nell’altra senza lasciare traccia, l’infanzia occupa una posizione paradossale e rivelatrice: è ovunque evocata, quasi mai ascoltata; è costantemente mostrata, ma come superficie, come icona del dolore, non come voce capace di parola propria.
I bambini appaiono come immagini, come corpi feriti che attraversano i nostri schermi, come dati statistici che gonfiano i bollettini, ma raramente come soggetti capaci di incrinare davvero il linguaggio con cui la guerra viene raccontata e, di conseguenza, normalizzata, digerita, infine tollerata. Il discorso pubblico sulla guerra resta infatti saldamente ancorato a categorie adulte: sicurezza nazionale, alleanze strategiche, deterrenza, diritto internazionale, equilibri regionali. Tutte categorie che possiedono una loro legittimità analitica, ma che producono un effetto collaterale devastante: tendono a rendere la guerra un fenomeno “spiegabile”, inseribile in una catena di cause e conseguenze, e quindi, in una certa misura che non osiamo confessare a noi stessi, accettabile. In questo quadro concettuale, dove tutto trova una spiegazione e ogni spiegazione funziona come una forma sottile di assoluzione, la sofferenza dei bambini rischia di diventare un rumore di fondo, una tragedia prevista, il costo che si paga perché la storia faccia il suo corso. È qui, in questo punto cieco del nostro sguardo collettivo, che si misura la crisi più profonda della nostra coscienza.
Esiste però un altro modo di guardare alla guerra, un modo che non nasce oggi ma che oggi torna a essere drammaticamente necessario: è lo sguardo che si forma quando la guerra viene raccontata non da chi la governa, né da chi la analizza, ma da chi la subisce senza comprenderne le ragioni, senza condividerne le finalità, senza poterne immaginare la fine. In questa prospettiva, l’esperienza di Sarajevo negli anni Novanta continua a offrirci una chiave di lettura di bruciante attualità: non per analogia meccanica, ma per radicalità etica, per la capacità di riportarci a quella soglia dove ogni giustificazione si arresta e resta solo il fatto nudo della sofferenza.
In Sarajevo (Cacucci, 2025), libro di Franco Giuliano che raccoglie cronache, testimonianze e soprattutto lettere scritte dai bambini della città assediata, la guerra perde ogni residuo di astrattezza. Quelle lettere non spiegano il conflitto, non lo interpretano, non lo giudicano con il vocabolario della morale adulta: dicono semplicemente che cosa significa crescere mentre tutto intorno crolla, che cosa accade quando il desiderio più elementare — giocare, andare a scuola, essere felici — diventa un’eccezione improbabile. È una parola povera, priva di retorica, ma proprio per questo capace di colpire nel punto più scoperto della nostra coscienza. Una frase, in particolare, resta impressa come una soglia morale davanti alla quale ogni discorso adulto vacilla: «Per Natale vorrei tanto essere felice». In quella frase c’è tutto: la sproporzione tra ciò che dovrebbe essere normale e ciò che è diventato irraggiungibile, la trasformazione della felicità in una richiesta straordinaria, la riduzione dell’infanzia a una condizione di attesa e privazione. È una frase che rende la guerra indifendibile, non sul piano politico, ma su quello propriamente umano.
La forza della voce infantile sta proprio in questo: non si oppone alla guerra con un’argomentazione alternativa, ma la rende incompatibile con qualsiasi idea di senso. Ogni guerra costruisce un racconto che la giustifica, una trama di cause e necessità che pretende di renderla inevitabile; i bambini non abitano questo racconto, non ne conoscono la lingua, e così, parlando d’altro — di desideri, di mancanze, di paure quotidiane — ne smascherano l’insostenibilità morale. La loro parola non consola: disturba.
Se riportiamo questo sguardo sull’oggi, è impossibile non pensare ai bambini di Gaza, del Sudan, dell’Ucraina, del Congo — ovunque l’infanzia sia diventata uno dei luoghi centrali della distruzione, non come effetto collaterale, ma come esito strutturale di conflitti che colpiscono in modo sproporzionato chi non ha alcun potere di difesa. Anche lì le immagini dei bambini circolano ovunque, ma le loro voci restano mute, sommerse dal rumore delle giustificazioni, delle contronarrazioni, delle ragioni di Stato. L’esperienza di Sarajevo ci insegna che esiste una continuità nella sofferenza innocente che attraversa le guerre, e che questa continuità deve finalmente diventare criterio di giudizio: non un appello sentimentale, non una retorica dell’innocenza, ma uno spostamento radicale del baricentro nel discorso sulla pace, l’affermazione che essa non può essere valutata solo in base alla cessazione delle ostilità, ma deve essere misurata sulla possibilità concreta che i bambini tornino a vivere un’esistenza degna di questo nome.
Giuliano scrive una frase che risuona come una consegna: «Sarajevo è la prova che le guerre finiscono, e che i bambini possono tornare a sorridere. A patto che il mondo lo voglia. A patto che tutti noi uniti lo si voglia». Non è una frase consolatoria: è condizionale, chiama in causa una responsabilità collettiva, dice che la fine delle guerre non è un automatismo della storia, ma una scelta.
Ripartire dai bambini significa rifiutare l’idea che la guerra possa essere raccontata solo da chi la combatte o la amministra, significa affermare che esiste una soglia morale oltre la quale ogni argomento perde legittimità. Una guerra che non può essere spiegata ai bambini senza vergogna interroga radicalmente la nostra idea di civiltà; e una pace che non comincia da loro, che non si lascia misurare dai loro occhi, resta — comunque la si chiami — una pace incompiuta, la pace di chi ha smesso di ascoltare l’unica domanda che davvero conta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi