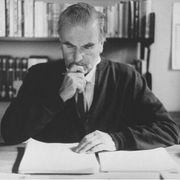Baharier: «Così la sapienza biblica parla al mondo di oggi»
Lo studioso delle Scritture: «Siamo come Giacobbe dopo la lotta con l'Angelo. Cerchiamo la verità, non la possediamo e dobbiamo aprirci all'altro». Il presente è invece polarizzato

In un tempo segnato da polarizzazioni, semplificazioni e identità contrapposte, il pensiero di Haim Baharier – filosofo, studioso di ermeneutica biblica e talmudica – offre un invito a scoprire la complessità, il dubbio fecondo, la parola che non divide ma apre. Baharier, da poco in libreria con La Genesi (Feltrinelli, pagine 156, euro 15,00), opera a quattro mani scritta con Erri De Luca, in questa conversazione riflette sulla sacralità della claudicanza, sul potenziale etico delle parole antiche e sulla possibilità di costruire un futuro condiviso a partire da un ascolto autentico nelle differenze.
Cosa possiamo imparare oggi dalla sapienza del linguaggio biblico e talmudico?
«È una domanda cruciale, perché la nostra epoca sembra affascinata dalle certezze granitiche, dalle contrapposizioni nette che semplificano il reale fino a mutilarlo. La tradizione ebraica, in particolare quella talmudica, ci offre un antidoto potente a questa deriva. Pensiamo al concetto di machloket leshem shamayim, la “disputa per amore del Cielo”. Nel Talmud, i maestri discutono animatamente, a volte con veemenza, su questioni di legge, etica, esegesi. Ma questa disputa non mira alla vittoria di una parte sull’altra, né necessariamente a un consenso appiattito. Mira piuttosto a esplorare la complessità della verità, a far emergere tutte le sfaccettature di un problema. Si riconosce che più voci, anche discordanti, possono contribuire a una comprensione più ricca».
Il linguaggio biblico resiste alle letture univoche?
«L’ebraico biblico è una lingua straordinariamente polisemica, dove una singola radice può schiudere molteplici significati, dove le parole vibrano di echi e risonanze. Pensiamo alla parola rakia, il firmamento creato nella Genesi: invertendone le lettere otteniamo ikar, l’essenziale, la radice etica. O alla parola mitzvah, spesso tradotta banalmente come “precetto”, ma che in realtà significa “comunicazione”, un legame, un invito all’interiorizzazione e non alla cieca obbedienza. La tradizione del midrash, dell’ermeneutica ebraica, è proprio questo: un lavoro incessante di interpretazione, di scavo nel testo, di attualizzazione del suo messaggio. La Bibbia non è un manuale di istruzioni, ma Mikra, qualcosa che va letto, proclamato, interrogato per diventare parola viva. Questo approccio rifiuta per sua natura ogni fondamentalismo, ogni pretesa di possedere l’unica lettura valida, perché sa che il testo è infinitamente più ricco di ogni singola interpretazione».
Parliamo di accettare l’incertezza?
«Qui entra in gioco un concetto a me caro: la claudicanza. Non è un difetto, una vergogna, ma la condizione umana fondamentale. Siamo esseri “claudicanti”, incompleti, limitati nella nostra comprensione. La Genesi stessa ci mostra come la comunicazione autentica nasca da una “costola” prelevata, da una mancanza, da un’asimmetria. Giacobbe lotta con l’angelo e ne esce claudicante, ma proprio lì riceve il nome Israele. Questa claudicanza non è segno di imperfezione, ma di perfettibilità: è proprio perché siamo incompiuti che possiamo crescere, imparare, cambiare. Accettare la nostra claudicanza significa riconoscere che non possediamo la verità assoluta, che abbiamo bisogno dell’altro, del dialogo, dell’interpretazione continua per avvicinarci faticosamente al senso. La polarizzazione è il rifiuto di questa claudicanza, è la pretesa arrogante di camminare con passo sicuro e lineare, ignorando la complessità del reale e la nostra stessa finitezza. La sapienza biblica e talmudica ci invita invece ad abbracciare questa condizione, a trovare nella pluralità delle voci la via per navigare un mondo complesso senza cedere alla tentazione delle risposte facili».
Esiste una radice etica comune alle fedi che può sostenere un futuro condiviso?
«Questa domanda tocca un nervo scoperto del nostro tempo, un desiderio profondo di unità di fronte alla frammentazione. La tradizione ebraica offre un punto di partenza potente nel racconto della Genesi: l’umanità è creata b’Tzelem Elohim, a immagine di Dio. Questa non è un’immagine fisica, ovviamente, ma una scintilla divina intrinseca a ogni essere umano, indipendentemente dalla sua fede, origine o condizione. È il fondamento della dignità inalienabile di ogni persona. Riconoscere il Tzelem Elohim nell’altro non è solo un atto teologico, ma un imperativo etico: mi obbliga a vedere nell’altro non un oggetto o un nemico, ma un volto che mi interpella, un riflesso di quella stessa immagine che porto in me. Questa idea pone le basi per un’etica universale della responsabilità».
Da questo fondamento scaturiscono principi etici che, pur con accenti e formulazioni diverse, ritroviamo in molte tradizioni religiose e filosofiche.
«Pensiamo alla Tzedek, la giustizia. Nell’ebraismo non è solo l’equità legale, ma una giustizia sociale attiva, un impegno a creare una società retta, a riparare le storture, a prendersi cura dei più vulnerabili. Pensiamo poi a Rachamim, la compassione, la misericordia. La radice ebraica rechem indica l’utero materno: Rachamim è dunque un’empatia viscerale, profonda, un sentire il dolore dell’altro come proprio, un moto di cura che nasce dalle viscere. E ancora, la responsabilità verso l’altro, che scaturisce direttamente dal riconoscimento del Tzelem Elohim e che trova eco nel pensiero di filosofi come Lévinas, mio maestro, per cui il volto dell’altro è la prima, irriducibile chiamata etica. Tuttavia, dobbiamo essere cauti. Se è vero che possiamo individuare aspirazioni etiche comuni, come la ricerca della giustizia, della pace, della compassione, è altrettanto vero che le loro interpretazioni, le loro priorità e le loro applicazioni pratiche variano enormemente tra le diverse tradizioni e anche al loro interno. La vera sfida non è trovare un minimo comune denominatore preesistente, ma costruire un futuro condiviso attraverso il dialogo. Un dialogo che non ignori le differenze teologiche, rituali, storiche, ma che le riconosca e le rispetti, cercando punti di convergenza nell’azione etica concreta, pur mantenendo le proprie identità».
Nel dialogo tra le fedi, quanto è importante saper ascoltare l’altro nelle sue differenze? E cosa significa, concretamente, accogliere un simbolo che non ci appartiene?
«Questa domanda va al cuore del dialogo tra fedi. Al centro della professione di fede ebraica c’è l’imperativo: Shema Israel, “Ascolta, Israele!”. L’ascolto (Shema) è il primo passo, l’atto etico fondamentale. Non è un semplice udire passivo, ma un fare spazio dentro di sé per la parola dell’altro, un’attenzione tesa, un impegno a comprendere. Senza ascolto autentico, non c’è dialogo, c’è solo un monologo a due voci. Ascoltare significa riconoscere che l’altro ha qualcosa da dire che io non so, che la sua prospettiva può arricchirmi, interpellarmi, persino mettermi in crisi. È un atto di umiltà e di disponibilità al cambiamento, come espresso nel “Faremo e ascolteremo” (Na’aseh ve’nishmah) con cui Israele accettò la Torah: prima l’impegno all’azione, poi l’impegno all’ascolto profondo per capire il senso di quell’azione».
Cosa significa, quindi, “accogliere” un simbolo che non appartiene alla propria tradizione?
«Certamente non significa appropriarsene indebitamente, svuotarlo del suo contesto per inserirlo nel mio, né creare un miscuglio sincretistico superficiale. Sarebbe una mancanza di rispetto profonda. Accogliere un simbolo altrui, credo, significhi piuttosto fare uno sforzo ermeneutico: cercare di comprenderne il significato profondo all’interno della sua tradizione, ascoltare cosa quel simbolo dice a chi lo vive come proprio, riconoscerne la potenza e la sacralità per l’altro. È un atto di immaginazione empatica e di rispetto intellettuale. Non si tratta di far entrare il simbolo altrui nel mio spazio vitale, ma forse di creare quello che potremmo chiamare uno “spazio in più”. Uno spazio generato dall’incontro rispettoso, dove possiamo imparare gli uni dagli altri senza annullare le nostre specificità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA