La «xenìa» e il senso del Premio Nobel (a Lampedusa)
L’ospitalità come vincolo sacro e dovere imperativo è una delle regole umane fondanti la nostra civiltà e il cantiere per la costruzione della pace
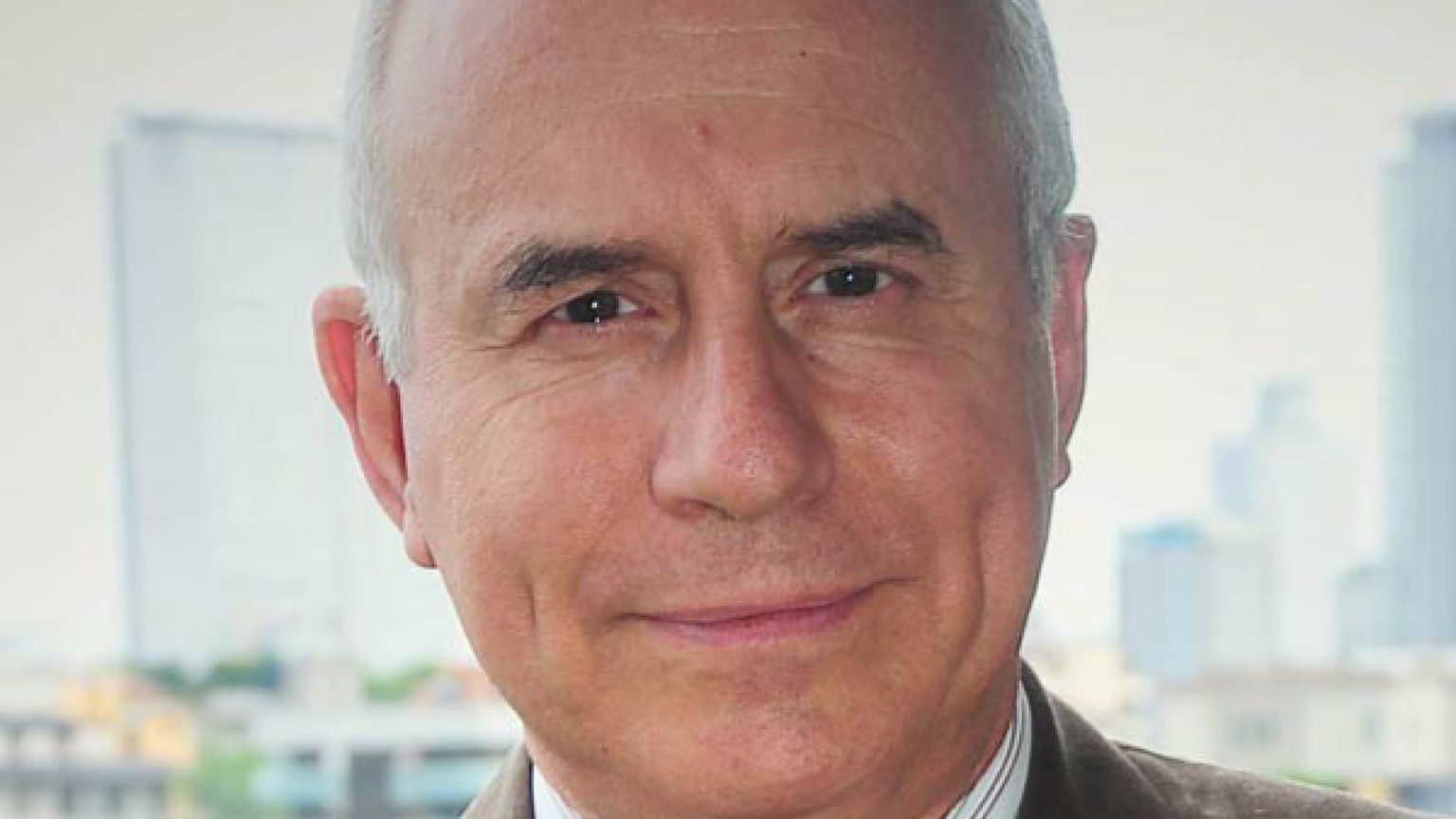
Caro Tarquinio, il concetto alla base della tragedia greca è quello di xenìa: il vincolo sacro che impone di dare ospitalità a chi la richieda. Nonostante la sua natura impositiva, la xenìa era percepita come un valore, un vincolo etico che doveva assolutamente essere rispettato. Il tema della xenìa è spesso raccontato nei poemi omerici e in altri testi che hanno sistematizzato i valori fondanti del mondo greco. Ad esempio, Odisseo approda, solo e reduce da un naufragio, sull’isola dei Feaci. L’accoglienza che riceve è esemplare: nonostante i Feaci sappiano che, così facendo, incorreranno nell’ira di Poseidone, forniscono all’eroe un’imbarcazione per rimettersi in mare. Basti poi pensare alla guerra di Troia, scoppiata anche perché una delle condizioni del patto di ospitalità era venuta meno: Paride aveva sedotto Elena, moglie del suo ospite.
Noi tutti, oggi, siamo alla ricerca di un modo per affrontare la drammatica situazione dei profughi e migranti lungo rotte irregolari di mare e di terra, ma essa è complessa e di difficile risoluzione. E io credo di non avere competenze idonee per affrontarla. Per questo ho preferito ricordare a lei e ai lettori il significato e la forza dell’antico termine xenìa, che era percepita come un valore, un vincolo che nobilitava l’uomo “mortale”. Spero che questo breve considerazioni possano stimolare riflessioni diverse da quelle ripetute ossessivamente da troppi politici e troppi media spesso con toni violenti e incuranti della questione umana. Anche tutta la nostra millenaria civiltà giudaico-cristiana contempla e suggerisce il valore dell’accoglienza. Non dimentichiamolo.
Fabio Sonzogni
Caro Tarquinio, siamo a ridosso dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2023. Le decisioni saranno già state prese, ma mi permetto ugualmente 3 proposte.
La prima: che non sia assegnato (come previsto dallo statuto) perché siamo nel pieno di un conflitto. È già accaduto in diciannove occasioni), per esempio durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, negli anni più caldi della Guerra Fredda e durante quella del Vietnam. Potrebbe essere un atto “politico” di denuncia e di invito a impegnarsi seriamente per la pace. Ma sarebbe anche un segnale di sconforto. La seconda: assegnarlo alle donne afghane che con il ritorno dei talebani hanno assistito alla privazione metodica dei loro diritti (lavoro, studio, libertà di spostamento). Un Premio che sarebbe simbolico per tenere la luce accesa (voi di “Avvenire” l’avete fatto e continuate a farlo) là dove è tornato il buio del terrore. La terza : assegnarlo a papa Francesco per la sua ostinazione nella ricerca della Pace. Sarebbe una novità: mai un Papa è stato insignito del Nobel. Mi chiedo quale altro leader politico o religioso risponda alle parole che Alfred Nobel usò per istituire il Premio: «Alla persona che più si sia prodigata ai fini della fraternità tra le nazioni, per l'abolizione o la riduzione di eserciti permanenti e per la formazione e l'incremento di congressi per la pace». Il Papa non si è mai piegato al tragico presente, ha sempre indicato una via, che è quella della speranza data dalla fede. In Dio e nell’umanità. Per questo la seconda e la terza proposta sono quelle che preferisco e auspico.
Daniele Piccinini
Noi tutti, oggi, siamo alla ricerca di un modo per affrontare la drammatica situazione dei profughi e migranti lungo rotte irregolari di mare e di terra, ma essa è complessa e di difficile risoluzione. E io credo di non avere competenze idonee per affrontarla. Per questo ho preferito ricordare a lei e ai lettori il significato e la forza dell’antico termine xenìa, che era percepita come un valore, un vincolo che nobilitava l’uomo “mortale”. Spero che questo breve considerazioni possano stimolare riflessioni diverse da quelle ripetute ossessivamente da troppi politici e troppi media spesso con toni violenti e incuranti della questione umana. Anche tutta la nostra millenaria civiltà giudaico-cristiana contempla e suggerisce il valore dell’accoglienza. Non dimentichiamolo.
Fabio Sonzogni
Caro Tarquinio, siamo a ridosso dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2023. Le decisioni saranno già state prese, ma mi permetto ugualmente 3 proposte.
La prima: che non sia assegnato (come previsto dallo statuto) perché siamo nel pieno di un conflitto. È già accaduto in diciannove occasioni), per esempio durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, negli anni più caldi della Guerra Fredda e durante quella del Vietnam. Potrebbe essere un atto “politico” di denuncia e di invito a impegnarsi seriamente per la pace. Ma sarebbe anche un segnale di sconforto. La seconda: assegnarlo alle donne afghane che con il ritorno dei talebani hanno assistito alla privazione metodica dei loro diritti (lavoro, studio, libertà di spostamento). Un Premio che sarebbe simbolico per tenere la luce accesa (voi di “Avvenire” l’avete fatto e continuate a farlo) là dove è tornato il buio del terrore. La terza : assegnarlo a papa Francesco per la sua ostinazione nella ricerca della Pace. Sarebbe una novità: mai un Papa è stato insignito del Nobel. Mi chiedo quale altro leader politico o religioso risponda alle parole che Alfred Nobel usò per istituire il Premio: «Alla persona che più si sia prodigata ai fini della fraternità tra le nazioni, per l'abolizione o la riduzione di eserciti permanenti e per la formazione e l'incremento di congressi per la pace». Il Papa non si è mai piegato al tragico presente, ha sempre indicato una via, che è quella della speranza data dalla fede. In Dio e nell’umanità. Per questo la seconda e la terza proposta sono quelle che preferisco e auspico.
Daniele Piccinini
Le nostre ancora oggi non sono società inospitali. L’antico costume dell’accoglienza, non sempre gratuita, ma sempre impegnativa e attenta, non è sparito, quel clima non è cambiato del tutto. Purtroppo, però, è indubbiamente compromesso. E sono davvero grato a Fabio Sonzogni, uomo di teatro e insegnante che i lettori di questo giornale conoscono da anni, per il suo appassionato richiamo alla forza buona e sapiente della xenìa mentre in troppi modi si alimenta il rischio devastante della xenofobia.
Già, si è come rarefatto l’ossigeno dell’ospitalità, di quel comune imperativo che germina e si radica dentro la civiltà greca, la sapienza e il realismo ebraico, l’idea romana della cittadinanza, la fraternità cristiana e ogni autentica illuminazione della ragione e dello spirito. Si è come attenuato, nelle coscienze prima che nel discorso pubblico e nelle leggi, il dovere umano di accogliente reciprocità che non considera le sconvenienze (come i Feaci con Ulisse, ricorda Sonzogni), che non è mai senza regole ma si fonda su una regola basilare, quella che mette ragionevolmente al primo posto la vita (e la fragilità, e la preziosità) delle persone in movimento. Al contrario, si è fatta più pressante e pesante l’idea della contropartita da ottenere, da lucrare, per la “porta aperta”. Si è generosi coi piccoli e grandi nababbi di ogni dove, e ci si ingegna per risultare attraenti per i turisti e per altri viaggiatori, soprattutto quelli di una stessa pelle (tendente al bianco) o comunque dello stesso reddito. Si guarda invece con diffidenza e sospetto chi emigra per bisogno, per disperazione o per speranza e si evita addirittura di guardare (e mediaticamente di far vedere) i volti di queste donne, di questi uomini, persino dei bambini. Forse per paura di un soprassalto accogliente.
Esagero? Pensateci: quando le persone hanno volto e nome, quando non sono più solo numeri racchiusi nel recinto di una dichiarata e infamante “clandestinità”, cambia tutto. E se questo riconoscimento accade, si evita magari di accumulare altri errori e orrori. Non si arriva fino al punto di non rispettare più come “minori” certi minorenni che irregolarmente provengono da determinati pezzi poveri o impoveriti di mondo dai quali un cammino regolare verso l’estero è reso non difficile, ma impossibile. Non si giunge a smarrire il senso della dignità degli «stranieri residenti» (illuminante il libro dedicato nel 2017 da Donatella Di Cesare a questa condizione umana e alla «filosofia delle migrazioni») sebbene essa sia parte integrante e, dunque, elemento costitutivo di una comunità. E, infine, ultimo esempio, se si guardano in faccia le persone e si onora il dovere dell’ospitalità, si ha vergogna di definire «armi ibride» uomini e donne spinti verso un confine chiuso e ostile come la terra da cui sono stati sradicati. È accaduto tra Bielorussia, Polonia e Lituania. Accade di nuovo tra le coste del Nord Africa o del Vicino Oriente e Italia, Malta, Spagna e Grecia. Nessuno ha osato chiamare così, «armi ibride», i profughi dall’Ucraina invasa e in guerra, ma i figli e le figlie della Siria e dell’Iraq e dell’Afghanistan e del Sahel sì…
Come lasciar assopire le coscienze dentro questo concerto stridente e disorientante, avvelenato ormai da anni da slogan odiosi, da semplificazioni ingiuste e violente, da speculazioni e calcoli politici che è persino poco dir cinici? Come rassegnarsi a dieci anni esatti – era il 3 ottobre 2013 – dalla prima grande strage davanti alle coste di Lampedusa? Come dimenticare gli almeno 27mila morti procurati e abbandonati, da allora a oggi, in quell’immenso e tragico «cimitero d’acqua», parola di papa Francesco, in cui abbiamo convertito il Mediterraneo?
Proprio Francesco, scrive il lettore Piccinini, sarebbe un Premio Nobel per la Pace perfetto in questo 2023, per lo straordinario e accogliente magistero di pace e di bene consegnatoci nei dieci anni del suo pontificato. Sì, lo sarebbe. Anche se i Papi non hanno bisogno di premi e il loro posto, lo annotò Benedetto XVI, «è la croce» come le vicende (e certe polemiche) del nostro mondo senza pace e segnato dalle ingiustizie e dalle diseguaglianze continuano a ricordarci. È comunque importante che il prossimo 6 ottobre quando a Oslo sarà annunciato il Premio, ci venga consegnato un messaggio potente, capace di interrogarci e di spronarci tutti. Sospendere il Nobel – come a volte si è deciso di fare – sarebbe un segno, ma forse ambiguo perché un pianeta sconvolto e insanguinato, oggi, da 184 conflitti bellici di differente intensità (il dossier è curato e aggiornato dall’Università di Uppsala) non è “in guerra” soltanto perché la guerra è terribilmente tornata nella sua forma più evidente in terra europea. È però vero che, oggi, i pezzi della «guerra mondiale», come avverte con dolore e forza ancora il Papa, «tendono a saldarsi». Anche assegnarlo alle donne afghane sarebbe una scelta eloquente e forte, e di volti e voci in grado di rappresentarle ne sono stati proposti diversi anche (e soprattutto, grazie a bravissime colleghe) su queste pagine.
Io tuttavia, certo fuori tempo massimo, e memore del tentativo che una dozzina di anni fa arrivò sino alla candidatura formale, ma senza coronamento finale, sarei felice se fosse assegnato alla gente di Lampedusa. L’importante è che l’idea e la candidatura tornino a camminare. Nel 2011 la proposta nacque su “Avvenire” dal dialogo tra una lettrice veneziana e il sottoscritto. La cronaca del 2023 la ripropone con decisione, visto che non abbiamo saputo cambiare la storia delle migrazioni forzate e appaltate ai trafficanti di esseri umani, a causa di norme storte e di algide e anche autolesioniste miopie. I nuovi episodi lampedusani di accoglienza e umanità scaldano il cuore e consolano le intelligenze, ci hanno ricordato con semplicità l’antica e nuova forza della civiltà della xenìa. È davvero importante, anzi è essenziale anche per costruire vera pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







