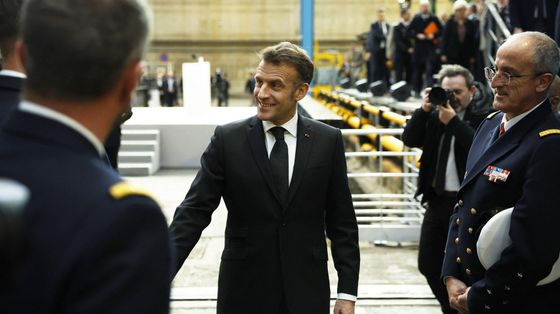Israele sta spianando Gaza. E le demolizioni sono un affare
L'abbattimento di quanto è ancora in piedi è stato appaltato a privati. Ma la selezione non è trasparente. Molte imprese vengono dalle colonie. E i compensi elevati trasformano il sistema in business

«Uno dei peggiori affari immobiliari mai fatti». Così il presidente Donald Trump ha definito Gaza appena qualche giorno fa. Una «proprietà fronte mare – ha ribadito – ceduta ad Hamas per anni. Questo doveva garantire la pace a Israele e invece ha portato all’attuale distruzione». Il presidente Usa, però, non considera – o non vuole farlo – che anche la devastazione è diventata un business. Fin da poco dopo l’avvio dell’operazione di terra, il ministero della Difesa di Tel Aviv ha contrattato imprese israeliane per realizzare demolizioni di edifici pericolanti a causa dei combattimenti, considerati di ostacolo all’offensiva nella Striscia. Questa almeno la spiegazione ufficiale. Mese dopo mese, però, con il procedere della guerra, le distruzioni di abitazioni e infrastrutture s’è fatta sistematica: 436mila case, il 92 per cento del totale, in base agli ultimi dati dell’Ufficio Onu per i diritti umani (Ocha), sono state abbattute insieme ai due terzi di quanto costruito. Al contempo è cresciuto anche il numero dei privati coinvolti in quella che è stata chiamata “la macchina delle demolizioni”.
Imprenditori israeliani si recano nell’enclave con i propri mezzi e personale, “alleggerendo” l’esercito dal lavoro. In cambio – secondo quanto confermato da una serie di fonti interne che hanno chiesto di non essere identificate per ragioni di sicurezza –, il ministero paga ogni addetto 1.200 shekel al giorno – circa 300 euro. Al proprietario delle attrezzature, inoltre, viene versato in media l’equivalente di 1.250 euro. Come rivelato da una recente inchiesta del quotidiano Haaretz – basata su fonti militari –, c’è addirittura un tariffario per tipologia delle strutture abbattute: si va dai 700 euro per una palazzina di tre piani a 1.500 per costruzioni più grandi. Qualcuno, in caso di lavori in zone particolarmente complicate, riesce a ottenere anche di più. Somme simili, sostengono le forze armate, sono una compensazione per il contesto estremamente insicuro in cui le società e il loro staff si trovano ad operare. Finora tre “demolitori” sono stati uccisi: Liron Yitzhak, 30 anni, nel maggio 2024, Jacov Avitan, 39 anni, a gennaio e David Libi, 19 anni, dilaniato dall’esplosione di una bomba a Jabalia, a maggio.
Le retribuzioni “generose”, tuttavia, rischiano di creare un incentivo agli abbattimenti non necessari, pratica più volta denunciata da organizzazioni indipendenti e da vari stessi ex soldati schierati nell’enclave. Le immagini filtrate dalla Striscia, dove i media non possono accedere per volontà di Tel Aviv, mostrano una devastazione generalizzata del territorio: intere città, da Rafah ai campi profughi del nord, sono state letteralmente cancellate. Oltretutto, il sistema di selezione e “arruolamento” dei contractor civili è poco trasparente. Secondo CivilEng, organizzazione che rappresenta il settore edile, per poter lavorare con la Difesa, le società devono ottenere l’iscrizione al centro logistico dell’esercito e a un apposito registro. I criteri di selezione, però, non sono esplicitati come i numeri dei reclutati e qualunque altre dettaglio. Il tutto è tenuto riservato per «ragioni di sicurezza». I pochi dati disponibili, tuttavia, evidenziano una significativa presenza di imprese di demolizione provenienti dalle colonie della Cisgiordania.
In questo caso, proprietari e personale agirebbero, oltre che spinti dal movente economico, per convinzione ideologica. Il defunto David Libi, ad esempio, lavorava per la Libi Constructions, di proprietà del padre Harel, da due mesi sotto sanzioni britanniche per aver contribuito alla realizzazione di avamposti illegali nei Territori nonché per minacce e aggressioni nei confronti dei palestinesi. La decisione di Londra non ha inficiato i rapporti dell’impresa con il ministero di Tel Aviv. Un altro “demolitore” conosciuto è Avraham Zarbib della colonia di Beit El che pubblica sui social i propri video accanto agli edifici sventrati dal suo bulldozer nella Striscia. «Non ci fermeremo fino a quando ogni villaggio non sarà raso al suolo», dice in uno degli ultimi filmati, accanto alle macerie di una casa a Khan Yunis.
Non è un segreto che l’ultradestra israeliana voglia ri-occupare la Striscia dopo avere “trasferito” gli abitanti. Sulla questione, sia il premier Benjamin Netanyahu sia il presidente Usa Donald Trump mantengono una posizione ambigua. Una settimana fa, il ministro della Difesa, Israel Katz, ha rilanciato l’idea con l’annuncio della costruzione di una «città umanitaria» sulle rovine di Rafah in cui ammassare i palestinesi, in primis i 600mila sfollati a al-Mawasi, in attesa dell’espatrio. Dopo un coro di critiche, il governo israeliano ha fatto marcia indietro. Lo spettro della “riconquista” della Striscia, però, aleggia sul presente dei negoziati di Doha e sul futuro dell’enclave. In quest’ottica, sostengono esperti e operatori, le demolizioni a tappeto potrebbero esserne il preludio. Nel frattempo, la macchina della devastazione va avanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA