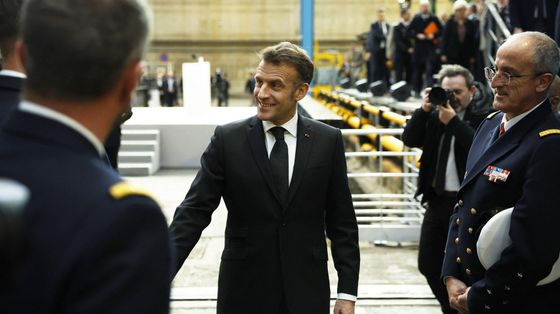Gli 80 anni di Pupi Avati: «Voglio un film su Dante»
Il regista a inizio 2019 nelle sale con “Il signor diavolo”: «Torno alle origini con l’eterna lotta tra bene e male. Wojtyla mi insegnò a non avere paura. Fra tre anni il mio film sul Sommo Poeta»

Cinquant’anni fa, nell’autunno del 1968, il primo ciak di Balsamus, l'uomo di Satana. In questi giorni il missaggio de Il signor diavolo. In mezzo l’“indemoniata” carriera, nel senso di prolifica, di Pupi Avati che dopodomani festeggerà i suoi 80 anni con il premio internazionale “Il Portico d’oro - Jacques Le Goff” che gli verrà conferito dall’Università di Bologna per i suoi studi storici, grande passione che il regista bolognese ha sovente trasfuso anche nei propri film. Compresi i prossimi, soprattutto quello con cui punta a coronare la sua multiforme carriera, «un film su Dante Alighieri per i settecento anni della morte, che conto di realizzare prima di chiudere i battenti».
Un compito da «far tremar le vene e i polsi » per dirla col Poeta...
«Mi ispirerò al Trattatello scritto da Boccaccio che nel 1350 andò a Ravenna e conobbe la figlia suora di Dante, Beatrice, per consegnarle dieci fiorini d’oro a nome dei capitani della compagnia di Orsanmichele a risarcimento del male che era stato fatto a suo padre. Lì sentì tante persone che avevano conosciuto Dante e cominciò una sorta di indagine sulla vita del Sommo Poeta. Quella biografia è già un film con una infinità di informazioni che senza il lavoro di Boccaccio non avremmo avuto. A me ora l’arduo compito per il 2021. Ho già il patrocinio del governo, dell’Accademia della Crusca e l’ok dei dantisti più illustri d’Italia. Vorrei contribuire a far conoscere un po’ di più Dante agli italiani».
Ma prima ha altro in cantiere?
«Ho in programma altri due film. Uno sull’amore “per sempre”, ispirato al libro di Giuseppe Sgarbi Lei mi parla ancora. E uno che invece mi riporta alle vecchie atmosfere gotiche degli esordi, Floating coffins. Prendo spunto dall’alluvione del Polesine del ’51. Vennero allagati paesi e cimiteri, l’acqua dissolse la terra, le bare emersero e galleggiando superarono le murate dei camposanti perdendosi nella grande piena del Po. I parenti sugli argini con biciclette, motorini e binocoli cercavano di individuarle per andarle a recuperare. Fin qui è storia. Nel paese di Lio Piccolo le bare di due fratelli non vennero più trovate e da lì cominciò una serie di efferati e misteriosi delitti».
E qui invece inizia il suo lato horror...
«Esatto. Lo stesso che ispira Il signor diavolo, nelle sale entro marzo. È il ritorno a un genere cinematografico che mi ha riportato all’euforia di quando ero sul set a girare come oggi con Capolicchio e Cavina La casa delle finestre che ridono in quel lontano 1976. Racconto quella civiltà contadina dominata dalla presenza del diavolo, come nelle favole che ci spaventavano».
Perché ha avvertito il bisogno di rappresentare il male in molti suoi film?
«Perché la presenza del male è indispensabile al bene. E poi perché io il male lo avverto davvero, soprattutto purtroppo dentro di me. Per esempio, pur frequentando i sacramenti ho smesso di confessarmi perché per decenni ero sempre recidivo con gli stessi peccati. E il più grave era l’invidia. Purtroppo non so proprio gioire del successo degli altri, anzi godo dei loro insuccessi. Certo, avverto ciò come qualcosa di negativo, sento che è male. Ma è come se la mia felicictà fosse pregiudicata da quella altrui, come se fossi in competizione. Ecco, basta questo per convincermi dell’esistenza del male: il male fine a se stesso, perché la gioia altrui non comporterebbe in fondo una minor gioia mia. Il sommo male è proprio quello gratuito».
Dal male assoluto alla paura panica, come nei suoi film.
«Sì, ma a convincermi per primo che non dobbiamo avere paura è stato papa Giovanni Paolo II con cui ho anche avuto il privilegio di pranzare. L’incontro più commovente di tutta la mia vita. I gesuiti dicevano: datemi un bambino per i primi cinque anni della sua vita e poi potete riprenderlo, ma sarà nostro per sempre. Io sono stato educato secondo i dettami tipici della Chiesa preconciliare. Un’educazione caratterizzata dal senso del peccato e dalla paura. Forse anche per questo ancora adesso alla mia età torno a raccontare certe storie. Nel mio profondo questa base non è mai stata cancellata. Ma c’era anche un altro cardine fondamentale».
E qual era?
«In quella cultura era invocata anche la coscienza come strumento discriminante tra ciò che dovevi o non dovevi fare. Oggi non si sente più parlare di coscienza, tutti si autoassolvono. Eppure ognuno di noi sa benissimo qual è la cosa giusta da fare in ogni circostanza, anche se poi spesso non la si fa per tutta una serie di altre ragioni contingenti. In ogni caso, se l’esame di coscienza come pratica è ormai in via di estinzione, la coscienza è sempre lì a inseguirci. Questa lezione in famiglia non si impartisce più ai figli, invece è fondamentale perché un essere umano diventi apprezzabile anche socialmente, oltre che a livello personale e religioso».
Avati, come vede la sua vita oggi?
«Io credo che la circolarità della vita, dalle aspettative dell’inizio fino ai titoli di coda, comporti in sé l’idea del “per sempre”. Un valore che mi aveva accompagnato soprattutto nel primo periodo della mia esistenza, ma che si sta riaffacciando adesso. Il senso sacrale della vita è dato dal fatto che diventando anziani si ha la sensazione di tornare. Tornare anche ad avere nostalgia non solo per la giovinezza, ma addirittura per la propria infanzia. Ma niente a che vedere con una sorta di regressione senile, di cui ho trattato nel film Una sconfinata giovinezza».
Che altro tipo di ritorno, allora?
«Tornare ad avere un desiderio forte di essere figlio, né nonno né padre ma figlio. Con le mani strette in quelle di mamma e papà. Forse per questo da vecchi si comunica in modo così profondo con i bambini, ci accomuna la vulnerabilità. Si piange e si ride più del normale. E si sente di più la presenza piena del prossimo. A patto che si accetti la vulnerabilità di anziano come un dono e non come una limitazione».
E lei questa condizione nuovamente filiale l’ha raggiunta?
«Direi di sì. Non voglio apparire presuntuoso, ma in virtù di questa mia vulnerabilità mi sento una persona infinitamente migliore rispetto a quando ero un sano adulto di mezza età nel pieno delle mie forze. Anche i sensi sono in qualche modo rassegnati a non avere più un ruolo così fondamentale. E si è pronti ad accogliere e ad essere accolti, sapendo che c’è un vero Padre. E che se vale la pena vivere è per l’amore. Per quel “per sempre” che mi è sempre più chiaro».
Un compito da «far tremar le vene e i polsi » per dirla col Poeta...
«Mi ispirerò al Trattatello scritto da Boccaccio che nel 1350 andò a Ravenna e conobbe la figlia suora di Dante, Beatrice, per consegnarle dieci fiorini d’oro a nome dei capitani della compagnia di Orsanmichele a risarcimento del male che era stato fatto a suo padre. Lì sentì tante persone che avevano conosciuto Dante e cominciò una sorta di indagine sulla vita del Sommo Poeta. Quella biografia è già un film con una infinità di informazioni che senza il lavoro di Boccaccio non avremmo avuto. A me ora l’arduo compito per il 2021. Ho già il patrocinio del governo, dell’Accademia della Crusca e l’ok dei dantisti più illustri d’Italia. Vorrei contribuire a far conoscere un po’ di più Dante agli italiani».
Ma prima ha altro in cantiere?
«Ho in programma altri due film. Uno sull’amore “per sempre”, ispirato al libro di Giuseppe Sgarbi Lei mi parla ancora. E uno che invece mi riporta alle vecchie atmosfere gotiche degli esordi, Floating coffins. Prendo spunto dall’alluvione del Polesine del ’51. Vennero allagati paesi e cimiteri, l’acqua dissolse la terra, le bare emersero e galleggiando superarono le murate dei camposanti perdendosi nella grande piena del Po. I parenti sugli argini con biciclette, motorini e binocoli cercavano di individuarle per andarle a recuperare. Fin qui è storia. Nel paese di Lio Piccolo le bare di due fratelli non vennero più trovate e da lì cominciò una serie di efferati e misteriosi delitti».
E qui invece inizia il suo lato horror...
«Esatto. Lo stesso che ispira Il signor diavolo, nelle sale entro marzo. È il ritorno a un genere cinematografico che mi ha riportato all’euforia di quando ero sul set a girare come oggi con Capolicchio e Cavina La casa delle finestre che ridono in quel lontano 1976. Racconto quella civiltà contadina dominata dalla presenza del diavolo, come nelle favole che ci spaventavano».
Perché ha avvertito il bisogno di rappresentare il male in molti suoi film?
«Perché la presenza del male è indispensabile al bene. E poi perché io il male lo avverto davvero, soprattutto purtroppo dentro di me. Per esempio, pur frequentando i sacramenti ho smesso di confessarmi perché per decenni ero sempre recidivo con gli stessi peccati. E il più grave era l’invidia. Purtroppo non so proprio gioire del successo degli altri, anzi godo dei loro insuccessi. Certo, avverto ciò come qualcosa di negativo, sento che è male. Ma è come se la mia felicictà fosse pregiudicata da quella altrui, come se fossi in competizione. Ecco, basta questo per convincermi dell’esistenza del male: il male fine a se stesso, perché la gioia altrui non comporterebbe in fondo una minor gioia mia. Il sommo male è proprio quello gratuito».
Dal male assoluto alla paura panica, come nei suoi film.
«Sì, ma a convincermi per primo che non dobbiamo avere paura è stato papa Giovanni Paolo II con cui ho anche avuto il privilegio di pranzare. L’incontro più commovente di tutta la mia vita. I gesuiti dicevano: datemi un bambino per i primi cinque anni della sua vita e poi potete riprenderlo, ma sarà nostro per sempre. Io sono stato educato secondo i dettami tipici della Chiesa preconciliare. Un’educazione caratterizzata dal senso del peccato e dalla paura. Forse anche per questo ancora adesso alla mia età torno a raccontare certe storie. Nel mio profondo questa base non è mai stata cancellata. Ma c’era anche un altro cardine fondamentale».
E qual era?
«In quella cultura era invocata anche la coscienza come strumento discriminante tra ciò che dovevi o non dovevi fare. Oggi non si sente più parlare di coscienza, tutti si autoassolvono. Eppure ognuno di noi sa benissimo qual è la cosa giusta da fare in ogni circostanza, anche se poi spesso non la si fa per tutta una serie di altre ragioni contingenti. In ogni caso, se l’esame di coscienza come pratica è ormai in via di estinzione, la coscienza è sempre lì a inseguirci. Questa lezione in famiglia non si impartisce più ai figli, invece è fondamentale perché un essere umano diventi apprezzabile anche socialmente, oltre che a livello personale e religioso».
Avati, come vede la sua vita oggi?
«Io credo che la circolarità della vita, dalle aspettative dell’inizio fino ai titoli di coda, comporti in sé l’idea del “per sempre”. Un valore che mi aveva accompagnato soprattutto nel primo periodo della mia esistenza, ma che si sta riaffacciando adesso. Il senso sacrale della vita è dato dal fatto che diventando anziani si ha la sensazione di tornare. Tornare anche ad avere nostalgia non solo per la giovinezza, ma addirittura per la propria infanzia. Ma niente a che vedere con una sorta di regressione senile, di cui ho trattato nel film Una sconfinata giovinezza».
Che altro tipo di ritorno, allora?
«Tornare ad avere un desiderio forte di essere figlio, né nonno né padre ma figlio. Con le mani strette in quelle di mamma e papà. Forse per questo da vecchi si comunica in modo così profondo con i bambini, ci accomuna la vulnerabilità. Si piange e si ride più del normale. E si sente di più la presenza piena del prossimo. A patto che si accetti la vulnerabilità di anziano come un dono e non come una limitazione».
E lei questa condizione nuovamente filiale l’ha raggiunta?
«Direi di sì. Non voglio apparire presuntuoso, ma in virtù di questa mia vulnerabilità mi sento una persona infinitamente migliore rispetto a quando ero un sano adulto di mezza età nel pieno delle mie forze. Anche i sensi sono in qualche modo rassegnati a non avere più un ruolo così fondamentale. E si è pronti ad accogliere e ad essere accolti, sapendo che c’è un vero Padre. E che se vale la pena vivere è per l’amore. Per quel “per sempre” che mi è sempre più chiaro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA