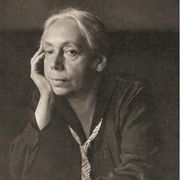Lo scrittore De Luca e il rabbino Ouaknin rileggono la Bibbia
I due intellettuali riflettono insieme su tre testi biblici: la torre di Babele,la raccolta della manna nel deserto e un passo del libro di Qohelet
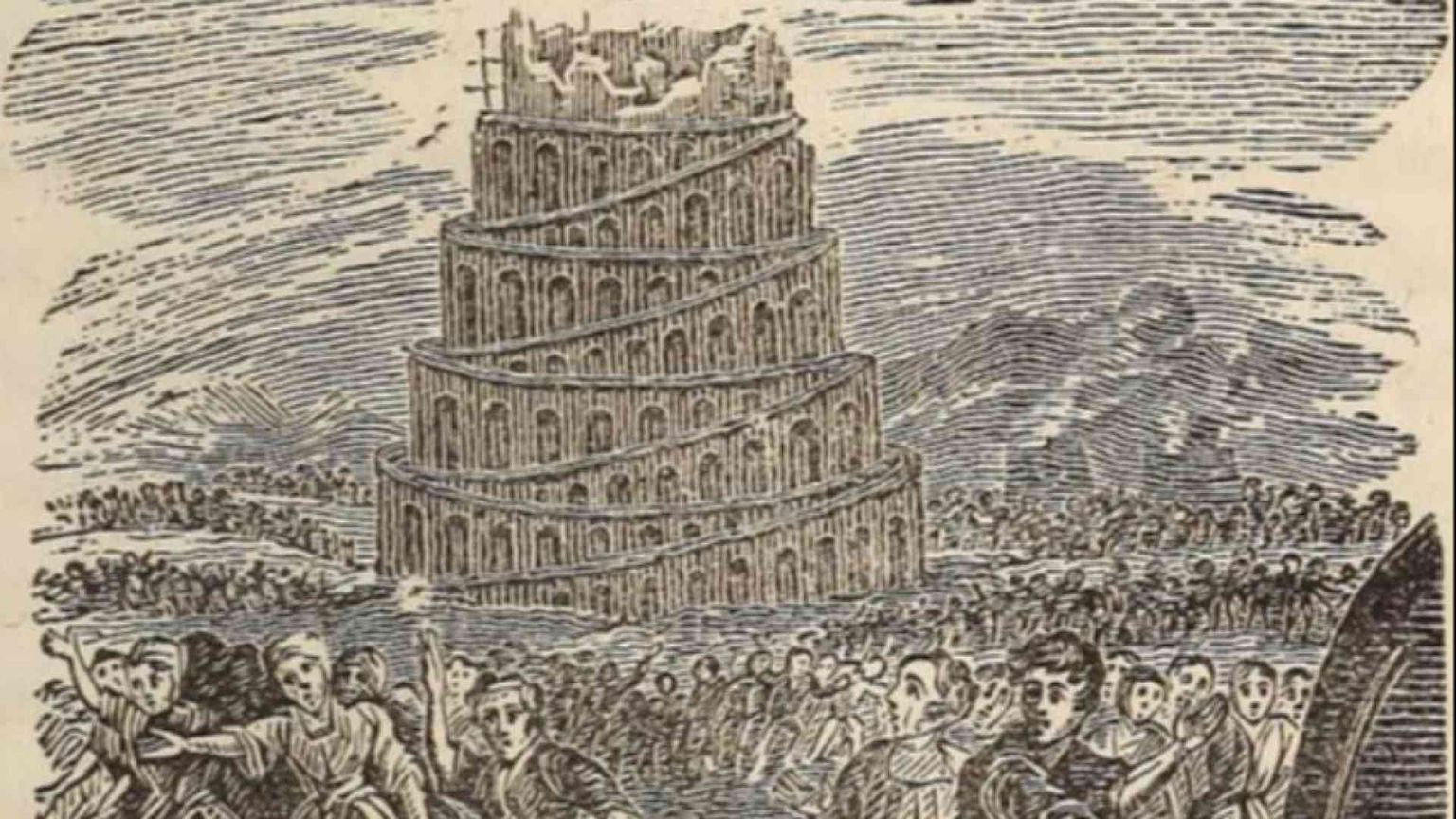
Con una punta di snobismo (ma solo una punta), sia il rabbino francese Marc-Alain Ouaknin sia lo scrittore “napoletano” Erri De Luca si dichiarano non credenti. Non atei, solo non credenti. Ma ad ascoltarli mentre dialogano su alcune pagine sacre alle fedi cristiana ed ebraica sembra piuttosto che entrambi credano moltissimo: nell’inesauribile tesoro sapienziale dei testi della Scrittura, nella polisemìa ovvero nella molteplicità di significati della lingua ebraica, nell’utilità per gli uomini scorati di oggi di riattingere forza dai racconti e dagli insegnamenti dell’antico codice o biblioteca che chiamiamo Bibbia. La loro professione di non credenza, si intuisce, allude alla convinzione che quel patrimonio letterario (dato che i testi sacri sono anche questo) è troppo grande per essere lasciato soltanto al mondo dei credenti e degli osservanti, nel tradizionale senso religioso del termine. Con questa premessa, De Luca e Ouaknin sono in piena sintonia: oltre alla passione per lo studio dell’ebraico, li accomuna il fatto di essere degli storytellers, dei cantastorie e, pertanto, degli scrittori, di successo verrebbe da dire, se successo si può avere in ambiti come le traduzioni e la divulgazione dei propri percorsi intellettuali e spirituali. Se fosse solo “legge” (nomos, come traduce la versione greca dei Settanta), la Torà dovrebbe cominciare da Esodo 12; invece comincia con un gran numero di storie. E perché Dio ha cominciato raccontando storie? Spiega il rabbino: «Affinché il popolo ebraico fosse capace di ascoltare e dialogare con gli altri popoli i quali, al di là dei loro tratti specifici, hanno in comune l’arte di raccontare storie». Del resto, anche nel più antico libro della mistica ebraica, il Sefer yetzirà ossia il Rotolo della formazione, si legge che Iddio il mondo lo creò «con il libro, con il numero e con il racconto».
Da tale idea narrativa della rivelazione biblica si dipana un intenso dialogo esegetico, che esce in questi giorni dai torchi editoriali della Giuntina con il titolo Cucire un’amicizia. Conversazioni bibliche (traduzione di Giorgio Berruto, pagine 108, euro 12,00) e che in particolare rivisita, a due voci, l’impresa della torre di Babele, il miracolo della manna nel deserto e il capitolo 11 di Qohelet. La babelica torre, che secondo un’iconografia consolidata svettava con la pretesa di raggiungere il cielo, offre il destro ad alcune precisazioni sull’alpinismo, visto che De Luca è conosciuto anche per questa sua passione naturistica. E sono note demitizzanti, per non illuderci che salire in vetta sia il massimo della spiritualità. In vero, dice De Luca, «non credo che l’alpinismo sia la porta tra cielo e terra; contro ogni legge di gravitazione, la terra spinge dal basso verso l’alto, con le montagne che continuano a sollevarsi; facendo alpinismo compio un percorso di perlustrazione degli estremi; mi allontano il più possibile dal punto di partenza ma non mi avvicino a niente, la vetta è come un vicolo cieco in cui non è più possibile andare avanti». Bisogna comunque scendere, tornare, completare il periplo. Il gusto è nel percorso, verrebbe da chiosare, non nella mèta. Al rabbino Ouaknin questa riflessione ricorda Kafka, che di porte e di salite e di discese ne ha descritte molte, nel Processo e nel Castello, e che gioca, in tedesco, con la polisemìa, anzi con l’anfibologìa in forza della quale una parola ha sempre due significati. Almeno due. In ebraico safà, lingua, significa anche riva; tiqwà significa speranza ma anche corda, e via esplorando. Per la gioia di chi traduce, e sia De Luca sia Ouaknin sono esperti traduttori.
L’arte della traduzione sta al centro delle conversazioni: vero dono divino agli esseri umani, quando Dio decise che non era bene che essi avessero un’unica e medesima lingua, da cui sarebbe derivato un pensiero omologato e un approccio in-differenziato al mondo, a se stessi e persino a Divino. Dio ama la diversità. Ma per capirla e accettarla, in un certo senso, è necessario tradurla. A Babele nasce l’arte feconda della traduzione che, da allora, accompagna l’esistenza storica dell’umanità. Tradurre e migrare (non so esattamente se prima l’una o l’altra cosa) sono i due caratteri costanti di un’umanità allergica alla staticità (che anche in questo mostra di essere imago Dei). Davar, parola in ebraico, viene da una radice che indica movimento, spiega il rabbino francese. Da essa derivano anche i termini zattera, pestilenza e persino deserto, inteso non come spazio disabitato ma come luogo della transumanza. La spigolatura può continuare.
Sulla manna poi è tutto un gioco di parole e un inseguirsi di domande. Manna, man hu, è una domanda di quelle che non abbisognano risposte. E di interrogativi retorici o inevasi è pieno il rotolo biblico di Qohelet, che De Luca definisce «non un filosofo ma un uomo tormentato dall’incapacità di godersi la vita». Ri-tradurne l’incipit, reso famoso nella Vulgata da Gerolamo con il suo vanitas vanitatum, è la sfida di ogni appassionato di lingua ebraica. Si sa che la resa delucana è «spreco di spreco»; André Chouraqui traduceva «fumo di funo»; André Neher lo rende piuttosto con «vapore e condensa» (versione condivisa da Ouaknin). Infinita traducibilità della Parola! Che sia stata creata un’equazione tra parola e manna non sorprende: quest’ultima era inviata fresca ogni giorno (tranne di shabbat), per quarant’anni interi, al solo prezzo di far la fatica di uscire dall’accampamento e di raccoglierla personalmente. Se a Babele nasce l’arte di tradurre, nel deserto con la manna nasce l’idea della fraternità, ricorda Marc-Alain Ouaknin, e ciò si evince dal fatto che in molte lingue la radice delle parole pane e fratello è identica: «Fratello è colui con cui si condivide il pane». Ach, l’ebraico per fratello, significa anche il braciere o la stufa con cui ci si scalda insieme. Potenza della polisemìa delle lingue dei popoli semiti (se solo sapessero imparare dalle loro stesse lingue...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA