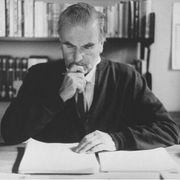Per una letteratura migliore è meglio non dare premi?
In Giappone quest’anno non sono stati dati i premi “Akutagawa” e “Naoki”: «Buoni libri ma nessuno all’altezza»

«In nome della cultura mi ritiro dallo Strega». Lo scrisse Pier Paolo Pasolini su “Il Giorno” il 24 giugno 1968. Una dichiarazione apparentemente paradossale, che però suggerisce una domanda: la cultura oggi è più un atto di presenza o di resistenza? E sottrarsi, che valore ha? O insistendo ulteriormente: è possibile sfilarsi da certe logiche editoriali e di mercato, magari restando ai margini? «L’industria del libro – proseguiva Pasolini in quell’articolo – tende a fare del libro un prodotto come un altro, di puro consumo: non ha bisogno dunque di buoni scrittori». Di cosa ha bisogno dunque? Viviamo in un mondo in cui anche altre industrie culturali si sono piegate a logiche talvolta extra-culturali in senso stretto: un esempio è la decisione dell’Academy che assegna gli Oscar di introdurre l’obbligo di includere nei film determinate categorie per poter puntare alle statuette, promuovendo in questo modo una maggiore rappresentatività di genere, diversità etnica, disabilità. Ma l’Oscar del politicamente corretto stimola un pensiero laterale o appassisce la creatività? Veniamo al nodo; pochi giorni fa è accaduto un fatto curioso, riportato da “Rivista Studio” e “The Japan Times”: mercoledì scorso il comitato di selezione dei premi letterari Akutagawa e Naoki – i maggiori riconoscimenti letterari del Giappone – ha annunciato che, per la prima volta in 27 anni, in questa edizione, nessuna opera avrebbe ricevuto il premio. Hiromi Kawakami, membro del comitato di selezione, ha commentato che, sebbene le opere candidate contenessero elementi sperimentali e prospettive innovative, la commissione ha ritenuto che non si fossero spinte abbastanza oltre da meritare il premio; questo è ciò che accade quando si prende davvero sul serio il concetto di meritocrazia. Tuttavia, come nelle pagine di quel gran romanzo ucronico che è La svastica sul sole di Philip K. Dick (nota a margine, vincitore del Premio Hugo come miglior romanzo nel 1963), immaginiamo un universo alternativo in cui questo fatto fosse accaduto in Italia, patria di centinaia di premi letterari. Una sensazione, pur chiaramente non suffragata da fatti oggettivi sarebbe: apriti cielo, titoloni sui giornali, pezzi acchiappa clic sul web con botta e risposta polemiche di esperti. Scriveva qualche anno fa “Linkiesta” che «se i premi e i concorsi funzionassero a dovere, rappresentassero una rassegna credibile delle novità, degli esordienti, dei giovani e dei giovanissimi e poi fossero diffusi coi giusti mezzi, scopriremmo forse a sorpresa che di buona letteratura abbiamo tutti bisogno». Per avere migliore letteratura, forse, servirebbe maggiore onestà, senza paura di offendere amici, senza paura di chiudersi opportunità, in poche parole essendo liberi e non schiavi di un sistema tanto veloce a portarti in cima, e altrettanto rapido a spingerti di sotto. Siamo ben lontani dai tempi in cui due grandi poeti come Ungaretti e Montale si pungolavano a distanza con rispetto, senza ipocrisie, senza false cortesie; accadde per esempio quando il primo disse del secondo, commentandone la nomina a senatore a vita nel 1967: «Montale senatore, Ungaretti fa l’amore». Oggi viene spesso da pensare che il rapporto tra cultura, mercato e potere si sia a mano a mano assottigliato, fino a confondersi. A pagarne il prezzo è la libertà intellettuale, in un tempo che aspira alla visibilità a tutti i costi, anche a costo della semplificazione. Il nocciolo è anche questo, perché far passare sempre tutto per buono non fa bene alla crescita della cultura, di chi la fa e di chi ne fruisce. Bene fanno allora i premi giapponesi a fermarsi e fare un passo indietro, rinunciando all’intrattenimento a tutti i costi, ad un marketing di fascette tutte uguali per libri «indispensabili». È chiaro, uscire dalla macchina della performance ha dei costi, può essere un percorso solitario, di margini, quasi sovversivo, contro la ruffianeria e la piacioneria, come face intuire anni David Foster Wallace in un’intervista. La ricetta potrebbe essere banalmente qualche no, qualche rifiuto in più e uno scambio di favori e strategie in meno, magari prendendosi questo ipotetico tempo di non assegnazioni per ricorrere a qualche maestro del passato: dice Onofri in Soste (Inschibboleth) che Garboli è «rimasto sempre quasi del tutto indifferente alla critica come applicazione di un’estetica, al giudizio di gusto o di valore, a tutto ciò che potesse costringerlo a pronunciarsi sulla bellezza o la bruttezza di un’opera. Illuminante, in tal senso, quanto dice a Monicelli: “Io credo che fare il critico sia misurare fino a che punto ogni libro è un libro sacro. I libri per me si dividono in due categorie: i libri sacri e profani». La critica, allora, «è un viaggio di decifrazione» di questa sacralità, o almeno dovrebbe aspirare a esserlo, se e quando di sacralità si tratta.
Questo articolo è stato ripreso anche su Radio 3 dalla puntata di Fahrenheit di oggi, 23 luglio, intitolata La premiata ditta. La letteratura al vallo dei premi e disponibile QUI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA