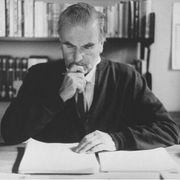Come trovare il messaggio evangelico nella nuova cultura digitale
La figura del “creator” si è imposta come nodo cruciale per il marketing, ma anche per la diffusione del sapere. Oggi chi crea contenuti plasma immaginari e orienta comportamenti

Nel paesaggio sempre più denso della comunicazione digitale, la figura del “creator” si è imposta come nodo cruciale non solo per il marketing, ma anche per la cultura. Chi crea contenuti non si limita a diffondere messaggi, ma plasma immaginari, orienta comportamenti, definisce linguaggi. In questo scenario, anche il messaggio cristiano è chiamato a confrontarsi con una realtà che non può più essere considerata semplicemente uno strumento da utilizzare, ma un ambiente culturale e antropologico da abitare in profondità.
Non si tratta più, dunque, di “usare bene i social” per evangelizzare, ma di comprendere che il digitale è un luogo teologico, un ambito nel quale si giocano oggi le grandi domande dell’esistenza. Come ha scritto Benedetto XVI nel 2013, in uno dei suoi interventi più lucidi sul tema: «L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani».
Questa affermazione impone una svolta concettuale: il web non è un “altrove” da colonizzare con il messaggio cristiano, ma un ambiente reale da vivere con autenticità e coerenza. La rete non è un canale, ma uno spazio relazionale dove prendono forma sentimenti, solitudini, ferite e speranze.
In tale contesto, la retorica dell’influenza – che per anni ha dominato il lessico della comunicazione digitale – lascia il posto a un concetto più esigente: la creazione di senso. Il termine “creator”, oggi sempre più diffuso, indica non solo chi pubblica contenuti, ma chi genera visioni del mondo. Si tratta di una svolta significativa: il valore di un contenuto non è più legato soltanto alla sua capacità di “funzionare”, ma alla sua origine e alla sua destinazione umana. Non basta più spostare opinioni: occorre attivare immaginazione collettiva, generare esperienze che trasformano.
Papa Francesco, rivolgendosi agli artisti, ha espresso con chiarezza questa esigenza: «Abbiate il coraggio di sognare nuove versioni del mondo». Questa indicazione, pur non pensata esplicitamente per i creator digitali, può essere applicata anche al loro ruolo: non limitarsi a riprodurre il già detto, ma proporre narrazioni capaci di aprire il futuro, di custodire la complessità, di resistere alla semplificazione aggressiva delle piattaforme.
Nel mondo dei social media, dove tutto è misurato, registrato, ottimizzato, emerge però un paradosso: l’algoritmo conosce tutto del comportamento, ma nulla della verità interiore. Può prevedere click e tempi di permanenza, ma non sa cogliere ciò che muove l’animo umano. Eppure, il rischio è che anche chi comunica dimentichi questa distinzione e si lasci definire solo dalle metriche. In questo senso, le parole di Papa Francesco nell’enciclica Dilexit nos costituiscono un argine fondamentale: «Nell’era dell’intelligenza artificiale, non possiamo dimenticare che per salvare l’umano sono necessari la poesia e l’amore… L’ordinario-straordinario non potrà mai stare tra gli algoritmi».
La fede, in quanto relazione viva, non si lascia ridurre a un sistema di indicatori di performance. Il contenuto realmente evangelico non nasce da un calendario editoriale, ma da un’esperienza di senso che brucia dentro e non può essere taciuta. È il fuoco – non la visibilità – il vero criterio. Un post, un video, un gesto comunicativo diventano significativi non perché virali, ma perché abitati da una verità che interroga.
A volte si corre persino il rischio di pensare che un post funziona se è muscolare o addirittura, in qualche modo sexy al maschile o al femminile, con un appeal da messa in posa. Non esiste un physique du rôle cattolico. E l’ostentazione della potenza propria dell’attrazione, in qualunque sua forma, rischia sempre di essere seduttiva e dunque di vanificare il messaggio stesso che, pur in buona fede, si intende comunicare.
A ciò si aggiunge un’altra insidia: la tendenza crescente all’iper-personalizzazione dei contenuti, che rinchiude ciascuno in una bolla algoritmica. L’informazione diventa specchio, non finestra. Si vedono solo contenuti affini, opinioni simili, visioni familiari. Il risultato è una perdita progressiva del senso dell’alterità, che diventa non interlocutore ma minaccia. E così l’avversario, nella dialettica pubblica, si trasforma in nemico. La comunicazione – anche quella religiosa – rischia allora di diventare strumento di esclusione più che di comunione.
Le parole di Francesco, pronunciate a braccio in un incontro con i vescovi del Centroamerica, suonano come un allarme culturale: «Mi preoccupa come la compassione abbia perso la sua centralità nella Chiesa. Anche i gruppi cattolici l’hanno persa, o... la stanno perdendo, per non essere pessimisti. Anche i mezzi di comunicazione cattolici: la compassione non c’è. C’è lo stigma, la condanna, la cattiveria, la denuncia dell’eresia…». La comunicazione della fede non può essere incentrata sulla sorveglianza dottrinale o sulla denuncia moralistica. Senza compassione, il messaggio cristiano rischia di diventare irriconoscibile.
In questa stessa direzione si muove anche papa Leone XIV, che nel suo primo incontro con i giornalisti ha posto con forza il tema della qualità del linguaggio e della cultura della comunicazione: «Oggi, una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di farci uscire dalla “torre di Babele” in cui talvolta ci troviamo, dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Perciò, il vostro servizio, con le parole che usate e lo stile che adottate, è importante. La comunicazione, infatti, non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto».
Il digitale, allora, non è solo questione di contenuti, ma di ambiente relazionale. L’obiettivo non è costruire fanbase, ma generare fraternità. Non servono contenuti “a effetto”, ma contenuti capaci di ferire nel senso evangelico del termine, di smuovere, di interpellare. E, in alcuni casi, anche di tacere. Perché, in un’epoca di reazioni continue, il silenzio può essere rivoluzionario.
Infine, resta una parola che sintetizza tutta la questione: fuoco. In una cultura che premia le luci artificiali, i flash e i filtri, ciò che trasforma davvero non è ciò che brilla, ma ciò che arde. Non serve apparire radiosi, ma essere capaci di generare calore, orientamento, speranza. Il fuoco, a differenza della luce artificiale, non solo illumina: scalda, consuma, purifica, guida.
La presenza cristiana nel digitale non è chiamata a brillare come un’insegna, ma a bruciare come una fiamma. Una fiamma mite e coraggiosa, che non cerca visibilità, ma verità. In un mondo che chiama “creator” chi produce contenuti per il mercato, servono oggi creatori di senso, artigiani di speranza, narratori di futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA