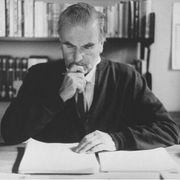Affinati e Malaguti: «Troviamo le parole giuste contro il rumore»
Per Francesco la letteratura era fondamentale perché sa aprire al prossimo. Due scrittori dialogano sul valore della narrativa a partire dalle sue parole

Nel 2024 papa Francesco riconosce alla poesia e alla letteratura una funzione essenziale: esplorare le profondità dell’animo umano per comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda. Ma cosa significa davvero «fare esperienza della realtà» attraverso le pagine di un libro? Come la letteratura può diventare palestra dello sguardo, allenandoci a vedere con gli occhi dell’altro? Se ne parlerà il 22 agosto alle 19 in un incontro del Meeting di Rimini dal titolo “Lo sguardo che allarga l’umanità: la letteratura come esperienza del reale”, con Eraldo Affinati, scrittore e docente, fondatore della Scuola Penny Wirton e Paolo Malaguti, scrittore e docente. Modererà il dialogo - che abbiamo anticipato qui in due interviste - Letizia Bardazzi, presidente dell’Associazione Italiana Centri Culturali. Il risultato è una riflessione aperta sul presente della letteratura italiana e sulla sua capacità di farci abitare la complessità.
Affinati: «La letteratura è trasformazione»

La letteratura come atto educativo, l’educazione come gesto narrativo: Eraldo Affinati, che dalla cattedra alla Scuola Penny Wirton ha fatto dell’incontro con l’altro una vocazione, intreccia due fili che attraversano tutta la sua esperienza di insegnante e scrittore: a emergere è la convinzione che la parola possa non solo formare, ma trasformare, e quindi saldare fratture, creare ponti tra lingue, culture e sensibilità, costruire relazioni e storie, perché leggere (e scrivere) non è mai atto neutro ma coinvolgimento personale, ampliamento di prospettiva.
Nella sua esperienza educativa con studenti migranti, come riesce a canalizzare il confronto con l’altro? In che modo questo sguardo “altro” amplia la sua concezione della realtà?
«Ho insegnato lettere per quarant’anni ad adolescenti degli istituti professionali. Nel 2004 sono entrato alla Città dei Ragazzi di Roma, fondata da monsignor Carroll-Abbing: lì ho incontrato molti giovani immigrati. Dal 2008, attraverso le scuole Penny Wirton, che ho fondato insieme a mia moglie Anna Luce Lenzi, anche lei professoressa, mi rivolgo ai minorenni non accompagnati provenienti da ogni parte del mondo. Questi scolari mi hanno aiutato a comprendere nel profondo lo sguardo che il Nazareno scambia coi primi pescatori che incrocia sul lago di Tiberiade. Ma ero già sulla buona strada perché il mio libro d’esordio, Veglia d’armi, pubblicato nell’ormai lontano 1992 con Mondadori, era un breviario spirituale a partire da Lev Tolstoj, il più grande scrittore-insegnante dell’epoca moderna».
Francesco ha riconosciuto alla letteratura e alla poesia una funzione essenziale nel comprendere noi stessi e il mondo. Si rispecchia in questa visione? La letteratura ha, per lei, anche una responsabilità sociale?
«La letteratura, come ha ribadito anche Edgard Morin in uno dei suoi ultimi aforismi, non è solo un’arte, ma anche una modalità conoscitiva che ci mostra l’essere umano nella sua integralità. Leggi I promessi sposi e capisci tutto: il carattere italiano, la società del tempo in cui è ambientato il romanzo, come si formano il bene e il male, cosa possiamo fare noi per trovare i valori in grado di orientarci nel cammino della vita. Oppure ti basta leggere una poesia di Montale per aprire uno squarcio dentro di te. In questo senso la letteratura a mio avviso ha una responsabilità pre-sociale, non detta le regole di comportamento, ma ti fa comprendere come nascono e perché ci sono».
Altro tema di Francesco: evidenziava il valore della letteratura nell’ampliare la sensibilità attraverso il pluralismo dei linguaggi. In che modo la scrittura può diventare strumento di apertura spirituale e culturale?
«I nostri ragazzi, spesso analfabeti nella lingua madre, nel momento in cui imparano a leggere e scrivere in italiano, saldano nella nostra lingua le fratture interiori della loro vita. La natura verbale del pensiero li aiuta a capire chi sono, da dove vengono e in quale direzione procedere. Viceversa noi che li guidiamo in questo apprendimento sentiamo la responsabilità di condurli verso la maggiore età (spirituale, prima ancora che anagrafica): è la ragione per cui tutti i nostri volontari escono arricchiti dal confronto con gli scolari, anche perché noi non abbiamo classi, ma organizziamo rapporti uno a uno. Puntiamo tutto sulla qualità della relazione umana».
Relazione, ecco un’altra parola chiave. Francesco ha detto che la letteratura contribuisce a formare il cuore e il pensiero, necessari in relazione. Lei hai sempre mostrato come l’esperienza educativa — con giovani marginalizzati, migranti, ragazzi difficili — fosse un laboratorio narrativo. Quanto sente che scrivere sia un atto pedagogico? E cosa distingue per lei l’atto educativo da quello letterario?
«La letteratura non può essere una semplice precettistica delle buone azioni da compiere. È molto di più: anche quando esplora le zone oscure. Prendiamo uno dei romanzi più importanti della letteratura moderna: I fratelli Karamazov, che papa Francesco prediligeva. Molti lo ricordano come un’opera del sottosuolo, tesa a sondare nel fondo più inquietante della natura umana. È vero perché in fondo è la storia di un parricidio, ma troppo spesso si dimentica il finale di quel capolavoro, nel quale Alëša, dopo aver partecipato al funerale di un giovane, invita i suoi piccoli amici a non dimenticarsi di lui: “Ecco, teniamoci per mano. E così per sempre, tutta la vita per mano. Un urrà per Karamazov! E ancora una volta i ragazzi fecero coro al suo grido”».
Questo fa riflettere su un altro tema: Bergoglio ha parlato della lettura come ruminatio, un processo lento e trasformativo. Come educatore e scrittore, sente che anche la scrittura debba digerire la realtà prima di restituirla?
«Bergoglio, quando parla di letteratura come ruminatio, citando Jean-Joseph Surin e Michel De Certeau, accenna al grande tema del discernimento: la letteratura va oltre la dimensione ordinaria spingendoti a scegliere in modo consapevole. Come lettore ogni romanzo mi aiuta a farlo, come autore devo capire quale è il contenuto a me congeniale. Io non sono uno scrittore d’invenzione, parto sempre da un’esperienza che trasfiguro stilisticamente. È come se cominciassi a scrivere già molto tempo prima della composizione vera e propria. Ad esempio i viaggi che ho fatto in Africa coi miei studenti, dai quali ho ricavato dei libri, erano nati in aula, scaturiti dagli sguardi che ci scambiavamo, dal patto emotivo che giorno per giorno andavamo stipulando».
In che modo l’incontro con l’altro ha cambiato il suo modo di concepire la lingua letteraria?
«Penso mi abbia spinto verso una ricerca delle origini comuni: tocchi la radice di una pianta e fai vibrare tutta la vegetazione. Gli uomini sono legati gli uni agli altri da nessi invisibili, forse imperscrutabili, ma persistenti. “Al mondo siamo tutti paesani”, diceva il mio grande amico Mario Rigoni Stern. Camminiamo insieme e ogni tanto ci fermiamo a guardarci negli occhi, scoprendo di essere molto più vicini di quanto credevamo. La letteratura può fare luce su queste piazzole di sosta».
Ha mai visto un ragazzo cambiare sguardo sul mondo grazie a una poesia o a una frase di un libro?
«Credo di aver scelto di diventare insegnante quando, durante una delle mie prime supplenze, vidi un ragazzino di seconda media, nell’estrema periferia romana, sgranare gli occhi dopo aver ascoltato l’attacco delle Ricordanze: “Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea tornar ancor per uso a contemplarvi dal paterno giardino scintillanti…”. Restò fulminato riuscendo a trasmettermi la sua emozione. Lì mi resi conto che a scuola avrei potuto portare la letteratura nella vita. È quanto, nel mio piccolo, ho cercato di fare. Anno dopo anno, un mattoncino dopo l’altro».
Come autore lavora ogni giorno con il cuore degli altri, in aula. Pensa che leggere letteratura — o scriverla — possa aiutare a conoscere meglio il cuore umano?
«Sì, anche il cuore di tenebra, purtroppo, come sapeva Joseph Conrad. È per questo che, prima di assegnare i compiti, cercavo di appassionare i ragazzi. Ad esempio compravo io i testi e glieli regalavo. Si poteva fare perché la Newton Compton pubblicava grandi classici a uno, due euro. Così nel momento in cui portavo in classe Il richiamo della foresta di Jack London, col romanzo ancora imbustato, i miei scolari, figli di operai, erano sbalorditi, quasi non credevano ai loro occhi. Pensavano: ma allora questo professore è davvero interessato a noi! Però non dicevano niente. Ma quando leggevo stavano molto più attenti. Come per dimostrarmi che rispettavano la piccola spesa che io avevo fatto. Ci siamo voluti bene per queste cose qui».
Crede che la letteratura possa fare da ponte con la parola di Dio? Specialmente per i giovani.
«Questo è un grande tema che papa Francesco aveva ben presente. Se vogliamo avvicinarci alle giovani generazioni, dobbiamo rinnovare il linguaggio religioso. La letteratura è lì per questo. Tutti i grandi educatori, del resto, da don Giovanni Bosco a san Filippo Neri, da san Giuseppe Calasanzio a Maria Montessori, di cui scrivo nel mio ultimo libro, Testa, cuore e mani. Grandi educatori a Roma (Lev, pagine 192, euro 17,00) il cui titolo riprende proprio una famosa espressione bergogliana relativa alla necessaria totalità dell’azione educativa, lo sapevano perfettamente. Il che non significa affrancarsi dalla tradizione, ma plasmarla al mondo di oggi».
C’è un verso, una pagina o una frase che per lei è diventata una sorta di guida personale?
«Dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Parole, provocatorie ma illuminanti, di don Lorenzo Milani».
Malaguti: «Il romanzo come resistenza»

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla ricerca dell’immediatezza, Paolo Malaguti, scrittore e insegnante - in questo momento in libreria con SicutErat. Il Mistero in dialetto: storia di una fede piana (Lev, pagine 144, euro 14,00) -, rivendica per la letteratura un ruolo controcorrente: presidio di lentezza, complessità, ascolto. Nei suoi romanzi – spesso attenti a voci e comunità marginali – la narrazione diventa allora uno strumento per restituire dignità a storie rimaste indietro ed esercitare un decentramento, per costruire una nuova «ampiezza di umanità», che solo le storie sanno dare.
In alcuni suoi libri affronta vicende di comunità poco ascoltate. Che ruolo ha per lei la letteratura come strumento per restituire voce a realtà altrimenti invisibili?
«Molti dei contesti comunicativi oggi più in voga sono caratterizzati dall’apparente esigenza della velocità e della semplicità di fruizione. Un post, per accalappiare tanti like, deve essere immediato, ammiccante, godibile nel giro di pochi attimi. Se accettiamo questa logica in fin dei conti superficiale ed edonistica, accettiamo di chiudere gli occhi sulla complessità della realtà e, più ancora, sulla complessità del nostro io. In questa prospettiva, la letteratura a mio avviso ricopre un ruolo vitale di presidio di lentezza e di complessità: se un romanzo è in grado di aprire le porte su storie dimenticate, difficili, censurate, o ancora su aspetti della nostra identità e del nostro tempo con i quali è difficile fare i conti, allora avrà offerto l’occasione ai lettori di non accontentarsi dell’immediatezza e della apparente facilità».
Che idea si è fatto sul ruolo della narrazione oggi, in un mondo scandito da contraddizioni geopolitiche e dalla sempre più accelerata globalizzazione? Può la letteratura – per come la concepisce – offrire strumenti per abitare la complessità del presente?
«Dal momento che nella mia vita scrivo e insegno letteratura, ovviamente sono di parte: credo che la narrazione (tanto letta quanto scritta) offra più antidoti validissimi alle complessità e alle sfide dell’oggi: in primo luogo, la narrativa implica un atto di decentramento da sé. Sia che scriva, sia che legga, incontrare una storia significa mettermi nei panni di un altro, ascoltare le sue ragioni, soffrire e gioire con lui o lei, anche se (e questo è molto bello) i suoi valori, la sua cultura e il suo orizzonte esistenziale sono diversi dai miei. In secondo luogo leggere e scrivere portano a un potenziamento linguistico, che equivale a potenziamento del pensiero. L’incapacità argomentativa di molti politici, l’aggressività che domina molti scenari comunicativi, la tentazione pericolosa di demandare la nostra creatività e il nostro pensiero a strumenti altri (penso alle IA) sono sintomi di povertà linguistica, di incapacità di dominare e plasmare il reale con strumenti verbali. In terzo luogo (ma si potrebbe continuare a lungo) leggere e scrivere significa assumere una prospettiva di verticalità storica che mi inserisce all’interno di una tradizione (letteraria, linguistica, valoriale...) rispetto alla quale sono chiamato a una presa di posizione critica, ma al contempo a un atto di umiltà: quando leggo, quando scrivo, sono l’ultimo, minimo anello di una catena di creatività artistica che impone ascolto e rispetto».
Francesco ha definito la lettura come palestra di discernimento, dove si sperimenta libertà interiore e umiltà intellettuale. Cosa significa, per lei, educare al discernimento?
«Provo a rispondere con un esempio. Da lettore mi sono innamorato delle pagine di autori (in primis Meneghello) che contaminano il linguaggio mescolando italiano, dialetti, lingue straniere... Spesso mi viene domandato se questa scelta stilistica non vada contro il lettore, e quindi contro le vendite, vista la presunta difficoltà nella lettura delle mie pagine. Ecco, io credo che uno dei grandi doni che la letteratura ci fa è proprio quello di non essere mai del tutto comprensibile. Se un testo è pienamente e univocamente comprensibile, ebbene quel testo non è letteratura: la letteratura offre ai lettori il privilegio dell’interpretazione (o, appunto, del discernimento). Un gioco antico e mai passato di moda, che è poi il motivo per cui, a distanza di secoli, c’è ancora chi trae piacere nella lettura dei poemi omerici. Questo esercizio è estremamente democratico e dà una profonda dignità al lettore: se venti persone si confrontano su quale sia il loro romanzo preferito, e (come è prevedibile) saltano fuori venti romanzi differenti, non importa chi è più giovane o più vecchio, chi ha una laurea o la terza media, chi ha letto mille libri e chi dieci… Ognuna di quelle venti persone ha ragione».
In che modo la narrazione può diventare un atto di ascolto e responsabilità verso l’umano?
«Spesso anche nel mercato editoriale si genera un po’ di confusione, perché si spacciano per “narrativa” oggetti letterari che appartengono ad altre categorie: pamphlet, riflessioni esistenziali, di costume, analisi più o meno approfondite sul mondo, sui giovani, sulla scuola... La narrativa è qualcosa d’altro, e in qualche modo di molto più semplice: si tratta di qualcuno che fa qualcosa in un determinato lasso di tempo. In pratica: la narrativa non può fare a meno dell’umano. Ne ha bisogno, è il suo materiale di costruzione. Quindi chi compra un romanzo sa o dovrebbe sapere che, al di là di generi e stili, in quelle pagine troverà la storia di una o più persone. Leggere romanzi, quindi, implica un atto di ascolto, di osservazione, di decentramento da sé, di cui oggi abbiamo un grande bisogno. In questa chiave “umanistica” della nostra letteratura trovo anche una forte radice cristiana: è interessante che i testi di base della nostra fede non siano testi regolativi, o filosofici, o elenchi di prescrizioni. I Vangeli sono testi narrativi, raccontano la storia di un uomo e dei suoi amici».
Francesco ha spesso elogiato il pluralismo dei linguaggi. Lei hai riscoperto e reinventato lingue. Qual è il valore formativo di restituire dignità a delle lingue minoritarie?
«Usare più codici significa interpellare il ruolo di interprete che ogni lettore deve giocare quando affronta un testo letterario. Ma non solo: le lingue, come ogni fenomeno storico, sono anche il riflesso di una società, dei suoi equilibri di potere. Riscoprire e rivendicare la dignità di lingue marginali o passate significa, a mio avviso, compiere anche un atto politico di resistenza contro la monocultura del linguaggio funzionale... Se di un codice uso solo ciò che “serve” a scopi economici (il che implica anche vendere tante copie!) allora accetterò implicitamente il principio che un oggetto culturale (come una lingua, o una cattedrale, o una biblioteca) possa essere distrutto, cancellato, se non è più utile, se non dà più vantaggi. Usare lingue inutili mi piace perché mi aiuta a ricordare a me stesso che la cultura, come del resto anche le relazioni, non soggiacciono (o non dovrebbero soggiacere) a logiche di consumo, ma dovrebbero vivere di un elemento che è più che mai utile tenere vivo in questi giorni: la gratuità».
A questo proposito, Francesco ha invitato a un uso della parola che sia generativo e non retorico. Come si costruisce uno sguardo narrativo che sia etico, e insieme letterario?
«Domanda difficile… Quello che provo a fare è semplicemente copiare al meglio delle mie capacità dagli autori che ho amato, anche per la loro dimensione etica e non piaciona (ho già citato Meneghello, qui aggiungo Rigoni Stern). Credo che un valido aiuto consista nel non avere la presunzione, quando si progetta un romanzo, di sapere già cosa si dirà. Se accetti la sfida di accompagnare il protagonista lungo la storia portando rispetto al suo tempo, al suo linguaggio, alle sue relazioni, allora forse sei sulla buona strada per non cadere nella facile retorica. Se al contrario progetti un romanzo a tesi, e pieghi i fatti e i personaggi alla tua volontà, allora il rischio di forzature e artificiosità è maggiore».
Francesco non usava la letteratura per erudizione, ma come spinta umana. C'è un valore formativo anche nell’utilizzo di citazioni?
«Sono convinto che la citazione sia forse l’elemento artistico più caratteristico della civiltà occidentale. Mi piace palesare le mie fonti e i miei modelli perché è un modo di dichiararmi “ultimo” in una catena di esperienze culturali, per rivendicare la natura plurale e sociale della cultura, che non fai mai da solo, da te e per te, ma con altri e, soprattutto, per altri. Le storie che scelgo ubbidiscono appunto a questa logica: cerco storie poco note, magari esplorate solo dagli specialisti di un certo settore, storie che siano prima di tutto scomode, che mettano in crisi certi modi di vedere il mondo, la Storia, o noi stessi, perché è vero, siamo figli di una tradizione, ma rispetto a questa tradizione ogni nuova generazione ha anche il compito del vaglio e della critica».
Pensa che il romanziere abbia oggi anche un compito “formativo”, non didascalico ma silenziosamente educativo?
«Oltre a scrivere insegno in un liceo, e mi rendo conto che le due cose si alimentano: quando scrivo e quando vado in giro in veste di scrittore, sento l’obbligo di assumere certi atteggiamenti (e di evitarne altri) alla luce di una funzione etica della cultura che sento viva. D’altra parte credo che ci siano artisti e artiste che hanno fatto grandissima cultura conducendo una vita agli antipodi dell’etica, con atteggiamenti di rottura e provocazione… Per cui credo che il vero sigillo di qualità non stia tanto in chi scrive, ma nel prodotto scritto. Sono fermamente convinto che ci siano in giro opere oneste e opere disoneste. Le une e le altre possono piacere o meno, ma nelle prime riconosci uno sforzo, un tentativo di spostare l’asticella della lingua, dello stile, della trama. In queste opere riconosci, percepisci il rispetto di chi scrive verso chi legge, rispetto che passa anche dal “ti do quanto di meglio so scrivere”. Nelle altre opere mi pare spesso facile individuare una piacioneria un po’ disonesta, perché cerca di intercettare le mode del momento, di blandire gusti e tendenze del pubblico, fornendo quindi testi facili, facilissimi, degli omogeneizzati linguistici e culturali. Per carità, viviamo in un paese in cui c’è libertà di scrittura e di lettura, quindi l’importante è che la gente entri in biblioteca e in libreria; meglio leggere qualsiasi cosa che non leggere affatto».
C’è un verso, una pagina o una frase che per lei è diventata una sorta di guida personale?
«Come credo sia normale ce ne sono tante che mi hanno colpito, e che mi fanno da guida. Ne scelgo una di Luigi Meneghello, tratta da Pomo pero. “Tu non puoi sfuggire alla verità del prete che ti battezza e del come; né alle feste per il tuo battesimo in quel tinello, con quei santoli, con quei brindisi. E tu non puoi predicare queste cose di te, ma di te queste cose”. Mi è sempre piaciuta, questa frase, perché mi pare che sia un invito a non metterci al centro del processo narrativo. Noi non siamo padroni della nostra storia, nemmeno quando proviamo a raccontarla. Siamo figli di incontri, di contesti, di linguaggi e relazioni, ed è a questa incredibile e complessissima somma di variabili che dobbiamo ciò che siamo, giorno per giorno. Partire da lì, da ciò che è noi pur essendo altro da noi, diventa a mio avviso narrativamente interessante, e umanamente utile, perché azzeri il narcisismo e ti metti a disposizione delle storie e dei lettori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA