Ma l'unità d'Italia ha bisogno delle Regioni (ben governate)
Il bilancio del regionalismo non è sempre positivo, e il virus ha mostrato nuovi limiti Ma un indebolimento dell’autonomia è un rischio per la tenuta della nazione
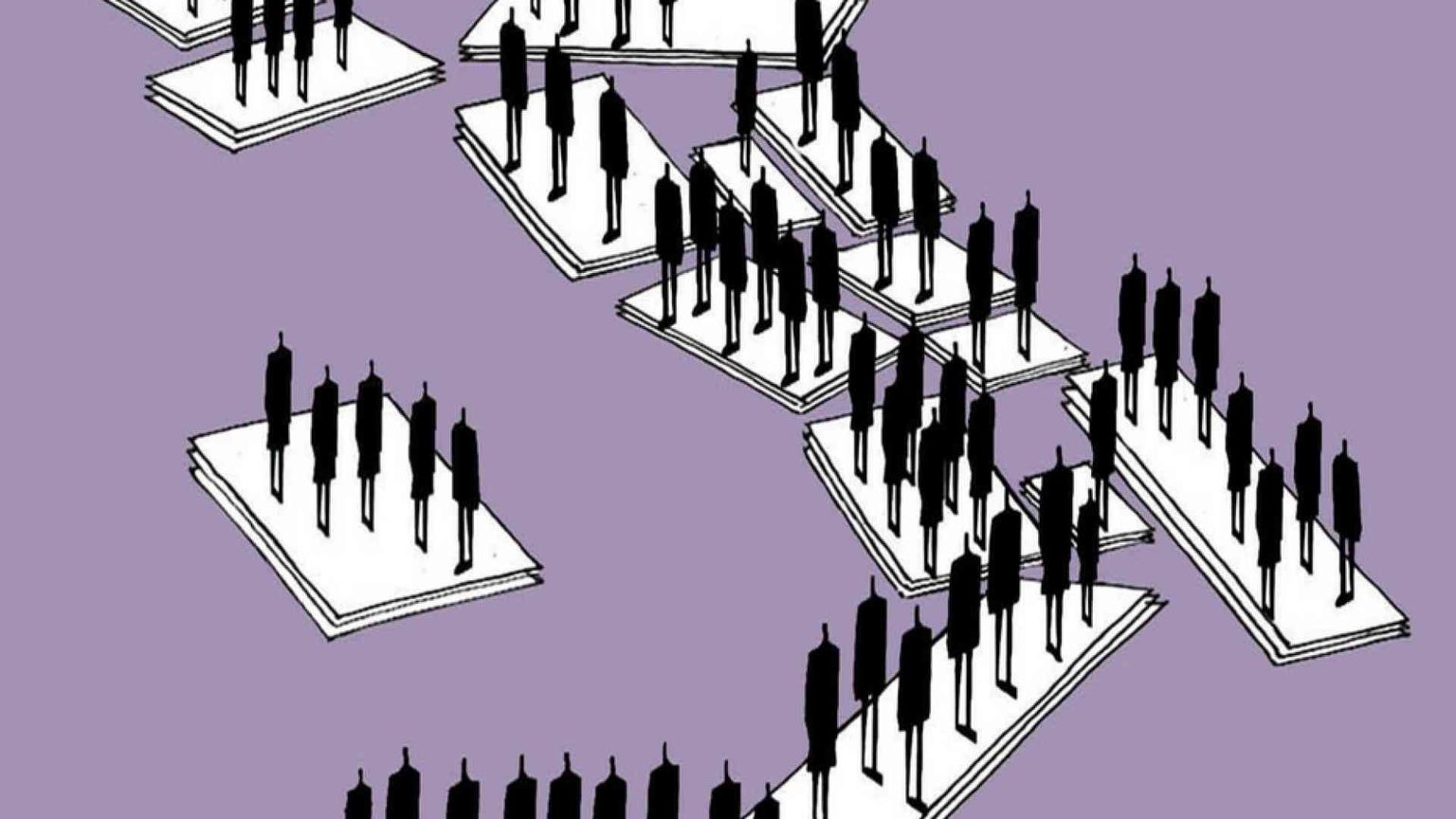
E' ormai passato mezzo secolo dalla entrata in funzione delle 15 Regioni ordinarie, che nella tarda primavera del 1970 si affiancarono finalmente alle cinque Regioni speciali non più solo sulla carta (ove esistevano dal 1947), ma anche nella realtà effettiva. La data dell’ultima legge ordinaria necessaria a implementarle è il 16 maggio, mentre quella dell’elezione dei primi Consigli regionali – che dotò le nascenti Regioni dei loro organi rappresentativi, consentendo loro di emettere i primi vagiti – è il 7 e 8 giugno successivi, in un anno gravido di leggi di rilievo costituzionale (referendum, divorzio, Statuto dei lavoratori...).
Ma sarebbe stata necessaria ancora l’adozione da parte delle Regioni stesse dei rispettivi Statuti, poi approvati dal Parlamento nel 1971, perché i nuovi Enti territoriali definissero la loro organizzazione. E sarebbero trascorsi quasi tutti gli anni Settanta perché lo Stato trasferisse (dapprima in modo assai taccagno, nel 1972, poi in maniera più generosa, con i decreti Giannini del 1977) le funzioni amministrative, che avrebbero permesso alle Regioni di operare. E solo alla fine del ’78 la grande riforma che creò il Servizio sanitario nazionale, individuando nella Regione l’ente titolare delle funzioni di tutela della Salute, diede loro la principale competenza, che oggi assorbe oltre quattro quinti del loro bilancio. Infine, negli anni Novanta le riforme Bassanini avrebbero ulteriormente rafforzato le autonomie e la riforma del ’99, che introdusse l’elezione popolare e diretta dei presidenti regionali, creò il sistema di governo che ora le caratterizza.
Che sia una aitante ventenne (frutto, in fondo, delle riforme degli anni Novanta), una brillante quarantenne (in virtù della materia salute) o una più attempata cinquantenne, la Regione italiana sollecita oggi la domanda sul suo stato di salute. Che bilancio si può delineare dell’attivazione del regionalismo, voluta dai costituenti nel 1946-47, ma realizzata solo un quarto di secolo più tardi (fra l’altro il quarto di secolo che più profondamente trasformò l’Italia, da Paese ancora agricolo a grande potenza economica dell’Occidente)? E siccome un bilancio risente anche del momento in cui è fatto, che prova hanno dato le Regioni di fronte al più radicale scossone subito dalle istituzioni italiane negli ultimi 70 anni, vale a dire l’emergenza coronavirus?
Il bilancio si può tracciare alla luce degli obiettivi che il Costituente aveva in mente istituendo le Regioni: a) rafforzare la democrazia, creando un nuovo livello di governo, più vicino ai cittadini; b) rafforzare il pluralismo, consentendo a partiti minoritari a livello nazionale di governare in ampie parti del territorio; c) migliorare la qualità della legislazione, lasciando allo Stato solo le norme generali e decentrando scelte minori; d) migliorare la qualità dell’amministrazione, con servizi più efficienti e più vicini ai cittadini. Manca da questi obiettivi quello di riconoscere identità politiche e culturali diverse dalla nazione, che invece aveva una certa importanza a fronte di alcune domande di autonomia provenienti dalle periferie alloglotte (Alto Adige, Venezia Giulia, Valle d’Aosta), cui si era già dato risposta con le Regioni speciali. Così come manca in questo elenco la grande questione irrisolta dall’unità italiana, vale a dire il divario Nord-Sud. Del resto un dato va stabilito con certezza: il regionalismo - nelle sue stesse radici - non ha nulla a che fare con la messa in discussione dell’unità nazionale, serve anzi a consolidarla, rileggendola in chiave pluralista.
Degli obiettivi ora indicati alcuni sono sicuramente falliti: è il caso della riforma del modo di legiferare, che è diventato più confuso e caotico che 50 o 70 anni fa, anche per l’apparizione di un nuovo attore, l’Unione Europea, che ha attratto a sé competenze in materie che il Costituente voleva spostare in parte alle Regioni (si pensi all’agricoltura). Le Regioni hanno in generale fallito come legislatori, malgrado che la riforma costituzionale del 2001 abbia aperto loro ampi spazi in questo campo. Ma il fallimento è dovuto in buona misura al centralismo praticato dal Parlamento nazionale, oltre che dall’opinione pubblica e dalla società civile organizzata, che formulano problemi e cercano soluzioni a livello nazionale. E da una Corte costituzionale che ha quasi sempre arbitrato in favore dello Stato i conflitti legislativi con le Regioni. Il bilancio non è entusiasmante neppure sul piano del 'nuovo modo di amministrare'. Ma qui deve essere più sfumato e, soprattutto, differenziato. Alcune Regioni, soprattutto al Nord, hanno prodotto una buona cultura amministrativa, altre sono diventate una copia deteriore dell’amministrazione statale. Del resto anche lo Stato, nei suoi servizi decentrati, funziona diversamente nelle diverse aree del Paese. Ma, soprattutto, chi oggi pensasse a riaccentrare a livello statale vari processi decisionali in cui le Regioni sono attori chiave, rischierebbe solo di renderli ancora più lontani e opachi.
Sul piano politico, il bilancio è anch’esso articolato. Le Regioni sono certamente diventate un ulteriore anello della complessa democrazia italiana. Quando sono governate da partiti che sono all’opposizione a livello nazionale, esse offrono spazi di rappresentanza e di pluralismo: si pensi al Pci negli anni Ottanta e Novanta e al centrodestra oggi. La principale deformazione, da questo punto di vista, è il protagonismo dei governatori, che ha rivelato la sua cacofonia proprio nelle settimane tragiche della lotta al Covid-19: spesso è legittimo chiedersi se l’azione dei capi dei governi regionali risponda davvero a esigenze specifiche dei loro territori o solo alla loro esigenza di visibilità. L’emergenza coronavirus, intrecciata con l’anniversario del regionalismo, ha generato reazioni opposte. Alcuni hanno risolutamente invocato politiche nazionali, con l’esercizio del potere sostitutivo e l’avocazione a livello statale della gestione della salute (solo per ora o definitivamente, secondo i casi). Ma oltre a rivelarsi poco pratico, questo approccio sembra basato su una illusione: quella che lo Stato funzioni meglio delle Regioni nei servizi che gestisce nelle diverse aree del Paese. Il che è davvero tutto da dimostrare.
All’opposto, si è vista nell’emergenza tuttora in corso la prova che le Regioni sarebbero finalmente entrate nell’era della maturità. Anche qui, forse, si corre troppo veloce. Una valutazione equilibrata del modo in cui le Regioni hanno operato in questa vicenda sarà possibile solo dopo la sua conclusione, e richiederà un’analisi assai approfondita, da condursi senza verità preconfezionate. Per ora l’impressione è che alcuni abbiano fatto meglio di altri e che la diversità del Paese richieda ancor oggi, come nel 1948, nel 1970 e nel 1999-2001, un livello di governo collocato fra lo Stato e gli enti locali. L’Italia è troppo complessa per essere governata solo dai Ministeri romani e la sua stessa unità potrebbe essere messa in pericolo indebolendo o addirittura eliminando le Regioni ordinarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA






