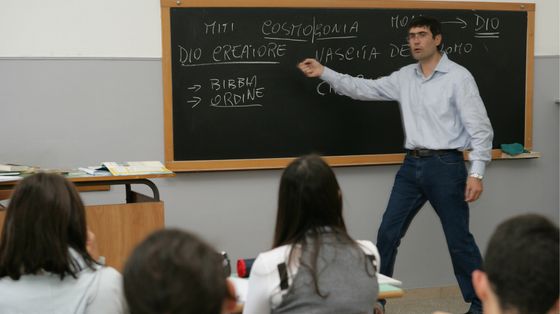Il Papa propone una mediazione della fraternità
Di fronte alla sfide sociali legate al progresso tecnologico, Leone XIV richiamandosi al padre dell'enciclica "Rerum novarum" traccia una strada affascinante

«Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, però principalmente perché il Papa Leone XIII, con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro».
È stato lo stesso cardinal Prevost, nuovo pontefice, a spiegarci all’inizio del suo pontificato la scelta del suo nome. L’ultimo Leone (XIII) aveva avviato di fatto con la Rerum novarum la riflessione della dottrina sociale della chiesa sulla rivoluzione industriale, scendendo in campo con la logica della fraternità nello scontro tra libertà di mercato ed eguaglianza propugnata (allora con la violenza) dal movimento socialista. Il nuovo papa, abituato come Francesco per la sua storia di missione a vedere il mondo dalla prospettiva degli ultimi, sceglie il nome di Leone XIV perché ritiene che la dottrina sociale della chiesa debba riflettere delle Rerum novarum dei nostri tempi legate al terremoto della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale.
Leone XIII era stato sensibile al grido di dolore e aveva riconosciuto le condizioni difficili del proletariato del tempo e il suo sfruttamento che generava salari ben distanti da una “giusta mercede”. Ma aveva voluto chiarire subito che la violenza, la lotta di classe e l’abolizione della proprietà privata non erano il rimedio giusto. Piuttosto, nella logica della fraternità e dell’intelligenza relazionale, ammoniva, era importante ricostruire il filo del dialogo tra capitale e lavoro e favorire alleanze orizzontali dei lavoratori nelle associazioni sindacali.
Leone XIV con tutta probabilità applicherà alle nuove questioni sul tappeto gli stessi principi e la stessa strategia, fondata sulla mediazione della fraternità. Il problema della “giusta mercede” è e resta oggi di strettissima attualità per il fenomeno del lavoro povero e della “piena sottoccupazione”. La sfida più temibile è quella dell’intelligenza artificiale che non è solo un aumento della velocità di circolazione delle conoscenze come quello prodotto dall’avvento dei motori di ricerca sulla rete, ma bensì un’accelerazione impressionante della capacità di rielaborazione delle conoscenze grazie al lavoro degli assistenti digitali. Siamo entrati dentro una grande rivoluzione di non riusciamo a calcolare tutte le conseguenze. Quello che già sappiamo è che la produttività è aumentata in modo impressionante e si è in parte tradotta in benessere digitale fatto di “merci senza peso” per tutti, ma i divari tra lavoratori con alte e basse competenze tendono ad aumentare ancora di più. La politica sarà fondamentale per evitare che queste diseguaglianze interne a ciascun paese alimentino ancor più populismi, complottismi e sfiducia nelle istituzioni minando la coesione sociale e la democrazia. L’appello del pontefice e della comunità credente alla sensibilità delle coscienze degli attori in gioco e di tutti noi sarà decisivo. Nel migliore degli scenari possibili questo aumento di produttività può generare più benessere diffuso e riduzione dell’orario di lavoro (gli esperimenti di successo di settimane corte di quattro giorni di lavoro in aziende di punta sono ormai numerosi). Ci sono tutte le potenzialità per puntare decisamente con questo di più di potenza alla qualità del lavoro (libero, creativo, partecipativo e solidale come chiedeva papa Francesco) aprendo spazi importanti alla domanda di benessere di chi arriva da paesi lontani e molto più poveri (e ci risolve il problema della mancanza di lavoro nella crisi demografica).
Il lavoro sul campo della comunità credente lascia intravedere le coordinate di una nuova sintesi di intelligenza relazionale alle sfide delle cose nuove. C’è spazio per una rivalutazione del lavoro di cura, la cui domanda è sempre più pressante di fronte al crescere del problema della non autosufficienza e degli anni di vita non in buona salute. Del diritto soggettivo alla formazione per cittadini e lavoratori di tutte le età come vera cura contro la trappola del lavoro povero nell’era dell’intelligenza artificiale. Di forme di reddito di base di formazione e partecipazione che aiutano chi è scartato o espulso da processi sempre più veloci di distruzione e creazione di posti di lavoro a reinserirsi e ritrovare la dignità perduta. C’è bisogno di potenziare i canali dei flussi di migrazioni legali che devono collegare in modo efficiente l’eccesso di domanda di lavoro nei paesi in crisi demografica con l’eccesso di offerta di lavoro (e di domanda di riscatto dalla povertà) dai paesi a basso reddito. C’è bisogno, sempre nella chiave dell’intelligenza relazionale, di percorsi discernimento e di accompagnamento di mentori e tutori per rendere efficaci orientamento e politiche attive.
Un papa americano che viene da Chicago (la patria dell’economia mainstream) ma è missionario e conosce bene il mondo dal punto di vista degli ultimi è la guida migliore è più autorevole per guidare un processo che tenga assieme progresso tecnologico e sfide sociali in questa fase così affascinante e difficile, piena di sfide per la democrazia e la pace.
È stato lo stesso cardinal Prevost, nuovo pontefice, a spiegarci all’inizio del suo pontificato la scelta del suo nome. L’ultimo Leone (XIII) aveva avviato di fatto con la Rerum novarum la riflessione della dottrina sociale della chiesa sulla rivoluzione industriale, scendendo in campo con la logica della fraternità nello scontro tra libertà di mercato ed eguaglianza propugnata (allora con la violenza) dal movimento socialista. Il nuovo papa, abituato come Francesco per la sua storia di missione a vedere il mondo dalla prospettiva degli ultimi, sceglie il nome di Leone XIV perché ritiene che la dottrina sociale della chiesa debba riflettere delle Rerum novarum dei nostri tempi legate al terremoto della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale.
Leone XIII era stato sensibile al grido di dolore e aveva riconosciuto le condizioni difficili del proletariato del tempo e il suo sfruttamento che generava salari ben distanti da una “giusta mercede”. Ma aveva voluto chiarire subito che la violenza, la lotta di classe e l’abolizione della proprietà privata non erano il rimedio giusto. Piuttosto, nella logica della fraternità e dell’intelligenza relazionale, ammoniva, era importante ricostruire il filo del dialogo tra capitale e lavoro e favorire alleanze orizzontali dei lavoratori nelle associazioni sindacali.
Leone XIV con tutta probabilità applicherà alle nuove questioni sul tappeto gli stessi principi e la stessa strategia, fondata sulla mediazione della fraternità. Il problema della “giusta mercede” è e resta oggi di strettissima attualità per il fenomeno del lavoro povero e della “piena sottoccupazione”. La sfida più temibile è quella dell’intelligenza artificiale che non è solo un aumento della velocità di circolazione delle conoscenze come quello prodotto dall’avvento dei motori di ricerca sulla rete, ma bensì un’accelerazione impressionante della capacità di rielaborazione delle conoscenze grazie al lavoro degli assistenti digitali. Siamo entrati dentro una grande rivoluzione di non riusciamo a calcolare tutte le conseguenze. Quello che già sappiamo è che la produttività è aumentata in modo impressionante e si è in parte tradotta in benessere digitale fatto di “merci senza peso” per tutti, ma i divari tra lavoratori con alte e basse competenze tendono ad aumentare ancora di più. La politica sarà fondamentale per evitare che queste diseguaglianze interne a ciascun paese alimentino ancor più populismi, complottismi e sfiducia nelle istituzioni minando la coesione sociale e la democrazia. L’appello del pontefice e della comunità credente alla sensibilità delle coscienze degli attori in gioco e di tutti noi sarà decisivo. Nel migliore degli scenari possibili questo aumento di produttività può generare più benessere diffuso e riduzione dell’orario di lavoro (gli esperimenti di successo di settimane corte di quattro giorni di lavoro in aziende di punta sono ormai numerosi). Ci sono tutte le potenzialità per puntare decisamente con questo di più di potenza alla qualità del lavoro (libero, creativo, partecipativo e solidale come chiedeva papa Francesco) aprendo spazi importanti alla domanda di benessere di chi arriva da paesi lontani e molto più poveri (e ci risolve il problema della mancanza di lavoro nella crisi demografica).
Il lavoro sul campo della comunità credente lascia intravedere le coordinate di una nuova sintesi di intelligenza relazionale alle sfide delle cose nuove. C’è spazio per una rivalutazione del lavoro di cura, la cui domanda è sempre più pressante di fronte al crescere del problema della non autosufficienza e degli anni di vita non in buona salute. Del diritto soggettivo alla formazione per cittadini e lavoratori di tutte le età come vera cura contro la trappola del lavoro povero nell’era dell’intelligenza artificiale. Di forme di reddito di base di formazione e partecipazione che aiutano chi è scartato o espulso da processi sempre più veloci di distruzione e creazione di posti di lavoro a reinserirsi e ritrovare la dignità perduta. C’è bisogno di potenziare i canali dei flussi di migrazioni legali che devono collegare in modo efficiente l’eccesso di domanda di lavoro nei paesi in crisi demografica con l’eccesso di offerta di lavoro (e di domanda di riscatto dalla povertà) dai paesi a basso reddito. C’è bisogno, sempre nella chiave dell’intelligenza relazionale, di percorsi discernimento e di accompagnamento di mentori e tutori per rendere efficaci orientamento e politiche attive.
Un papa americano che viene da Chicago (la patria dell’economia mainstream) ma è missionario e conosce bene il mondo dal punto di vista degli ultimi è la guida migliore è più autorevole per guidare un processo che tenga assieme progresso tecnologico e sfide sociali in questa fase così affascinante e difficile, piena di sfide per la democrazia e la pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA