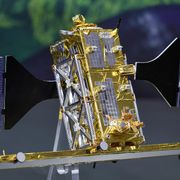Capitali stranieri sfruttare non subire
Un simbolo dell’industria italiana come Pirelli – anno di fondazione 1872 – parlerà dunque cinese. Ai giapponesi di Hitachi, invece, Finmeccanica ha ceduto AnsaldoBreda e Ansaldo Sts. Recenti sono pure il passaggio di Indesit all’americana Whirpool e il cambio di pilota in Alitalia con gli emiri di Etihad. Nel futuro dell’Ilva, infine, si stagliano anche colossi d’acciaio orientali, mentre a Telecom potrebbe arrivare presto lo squillo dell’azionista francese Vivendi. Uno sguardo preoccupato – quello prospettico di Luciano Gallino, ad esempio – legge in questa pioggia di capitali stranieri che si abbatte sullo Stivale da ogni angolo del mondo «la fine dell’Italia industriale». E se i miliardi esteri non garantiranno – come per altro promesso in tutti i casi citati – mantenimento della capacità produttiva, livelli occupazionali adeguati e, soprattutto, investimenti in ricerca e sviluppo, la funesta profezia potrebbe avverarsi. Non è tuttavia ingiustificato considerare anche l’altra faccia della medaglia: dopo anni di vacche magre, un bel po’ di dollari, yuan e yen varcano i confini italiani e raggiungono le imprese di casa. La conferma di un’inversione di tendenza arriva pure dal private equity internazionale, che ha ripreso a puntare sul capitale di rischio italiano. Il governo ha del resto indicato come un obiettivo di politica industriale quello di rendere l’Italia "attrattiva". Ed è piuttosto evidente che senza queste risorse sarebbe impossibile per molte aziende della seconda potenza manifatturiera europea crescere e restare competitive in un mercato globale. Pochi grandi gruppi, oggi, potrebbero addirittura indossare i panni del cacciatore e non quelli della preda: Eni, Enel, Finmeccanica e Fincantieri, praticamente tutti colossi (ancora) statali. Fiat lo ha già fatto, sfruttando però al meglio i fondi messi a disposizione da Obama. Tra i privati solo una manciata di imprese a partire da Ferrero, Luxottica e Prada sono in grado finanziare la crescita anche attraverso acquisizioni all’estero. A livello domestico, infatti, grandi risorse su cui far leva non ce ne sono, tutt’altro. Figurarsi per la media impresa. L’implosione del sistema-Mediobanca, su cui si è retto troppo a lungo un rischioso equilibrio tra capitalismo delle grandi famiglie, capitalismo finanziario e capitalismo statale, ha rappresentato in tal senso per l’Italia un passaggio epocale di cui s’iniziano ad avvertire gli effetti.Ecco perché alzare barriere protezionistiche sarebbe oggi azzardato. Ed è probabilmente la ragione per cui Palazzo Chigi ha scelto di non ostacolare e anzi incoraggiare tutte queste operazioni, prendendo a modello il successo del Nuovo Pignone rilanciato da General Electric. La semplificazione del mercato del lavoro e i primi passi per lo snellimento burocratico sono stati concepiti quali interventi di politica industriale anche nella misura in cui rendono più morbido il tessuto produttivo per i capitali esteri. È una scommessa per certi versi coraggiosa, restando sempre sottile il confine fra "vendita" e "svendita" di pezzi pregiati dell’industria domestica. E che comporta per questo una grande assunzione di responsabilità: un conto, infatti, è favorire l’arrivo di risorse straniere, altro è essere capaci di farle restare.L’abbandono di un’impronta dirigistica in materia d’imprese non si dovrebbe cioè tradurre, tout court, nella rinuncia a una visione di politica industriale. Perché i flussi di denaro forestiero in Italia possano fermentare, è necessario investire soprattutto in infrastrutture, a partire, oggi, dalla grande Rete in fibra ottica. E qui lo Stato non dovrebbe accontentarsi di attirare i quattrini del mercato globale – diventato un Impero di capitali finanziari spesso privi di responsabilità, dove fondi sovrani o speculativi possono anche smembrare imprese e divorarsele senza ancoraggio e rispetto alcuno a produzione e lavoratori – ma mettercene di propri. Il sistema amministrativo e la giustizia civile sono le altre due leve sulle quali la politica può e deve agire per favorire un aumento della competitività oramai irrinunciabile a ogni livello.Solo se verranno plasmate le condizioni per cui dollari, yuan o yen attecchiscano, l’Italia riuscirà magari ad attrarre altrettanti capitali per aprire fabbriche e non solo per far crescere quelle che già ci sono; per finanziare la ricerca, valorizzare la nostra perizia artigianale e il talento riconosciuto nel design. E per creare finalmente tanti nuovi posti di lavoro. Solo allora non ci ritroveremmo più di fronte alla domanda se il nostro sia davvero un Paese in declino industriale che svende i suoi gioielli, potendo parlare invece di un’Italia foss’anche «capta», che però «cepit Imperium». Cresce, e anche di potere effettivo e buono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA