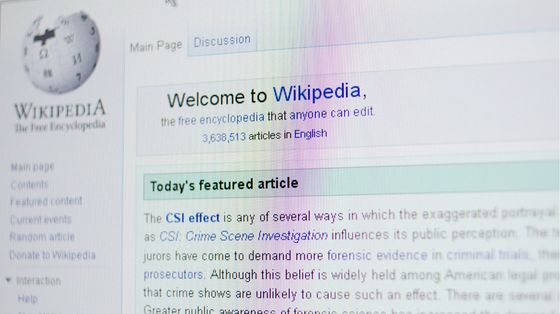Diavolo di un Dickens, preso tra arte e denaro
In due romanzi il parallelo tra l’autore inglese e lo scrittore americano Edward Eggleston, pioniere del realismo regionale, che guarda all'etica dell'economia

Ho qui davanti due libri pubblicati da un editore coraggioso e raffinato come Mattioli 1885: il romanzo Martin Chuzzlewit (pagine 1.046, euro 33,00) di Charles Dickens - a cura dei prefatori Livio Crescenzi, Mattia Maglione (autore pure di un “Glossario”), Marta Viazzoli - e la raccolta di racconti Il Club di Natale (pagine 120, euro 10,00) di Edward Eggleston, con un’introduzione di Gaia Stocchi e Chiara Voltini. L’incipit del racconto eponimo ci fa sospettare che l’apparizione congiunta di questi due volumi non sia una coincidenza: «“Diavolickens!” Furono proprio queste le parole che disse Charley Vanderhuyn quella Vigilia di Natale, e da storico fedele riporto le parole esatte». Come ci viene spiegato in nota, il curioso temine Diavolickens «sfrutta la somiglianza fonetica tra il cognome di Charles Dickens e devilkin, diminutivo di devil (diavolo)». Tutto il racconto si fonderà proprio su tale «doppia valenza» del gioco di parole, se è vero che «l’esclamazione può riferirsi sia al diavolo che al famoso romanziere», nel segno di un’«ambiguità che il narratore svilupperà ironicamente definendo entrambi come “autori” - uno del male, l’altro di storie».
Se le cose stanno così, varrà la pena approfondire quel sospetto e chiedersi che rapporto possa darsi tra l’autore di bestseller come Oliver Twist, David Copperfield e il Canto di Natale (nato a Portsmouth nel 1812 e morto a Londra nel 1870), e il «pioniere del realismo regionale americano», predicatore metodista itinerante e poi editore morto nel 1902 a 65 anni. Che romanzo è, in effetti, La vita e le avventure di Martin Chuzzlewit apparso in diciannove fascicoli mensili tra il gennaio 1843 e il luglio 1844? Dickens, a quanto si legge in una lettera inviata il 2 novembre 1843 a John Forster, lo ritiene «sotto molti aspetti la migliore» delle sue storie: e ciò in contraddizione con quella che era stata, sin dalle prime puntate, la reazione dei lettori, di «molto inferiore rispetto a quella raggiunta con i clamorosi successi di Barnaby Rudge e La bottega dell’antiquario». Di certo abbiamo davanti un romanzo frondoso, folto di colpi di scena, formicolante di personaggi, alcuni dei quali aprono, dentro la storia principale, ulteriori ipotesi di racconto.
Ma veniamo al punto importante: lo scrittore si rendeva perfettamente conto del nesso tra estetica e mercato - davvero cruciale, come sappiamo, per la letteratura del futuro - tanto è vero che, per rimediare all’insuccesso di quelle prime puntate, Dickens spedì il suo protagonista negli Stati Uniti, «raccontando, attraverso gli occhi dei suoi personaggi, del suo primo viaggio», lì effettuato nel 1842. Quel che ci viene restituito è un mondo che non mantiene le promesse di democrazia e libertà, ma si rivela una terra corrotta e violenta, «in cui l’interesse per il profitto spinge gli abitanti a utilizzare i mezzi più gretti per approfittarsi del prossimo». Romanzo dalla trama complessa e assai difficile da riassumere, la vicenda muove da un’ulteriore complicazione. I Martin del titolo sono infatti due: un nonno ricchissimo e un nipote che dal nonno viene cacciato di casa, quando - e non staremo a spiegare il perché - gli viene il sospetto che, attraverso il possibile matrimonio con Mary (l’orfana di fatto adottata di cui Martin il vecchio si fida ciecamente), il nipote voglia impossessarsi del suo patrimonio. È da questo momento che cominciano il lungo viaggio e le tante peripezie del giovane secondo un modello già sperimentato da Dickens, là dove il termine peripezia non significa soltanto avventura, ma anche spunto di riflessione sui vizi e le virtù degli uomini. È così che il romanzo ci mette di fronte alle «molteplici facce dell’egoismo umano», scrutato non solo nel suo verso di «deformazione del carattere», ma anche nei suoi effetti di «pericolosità sociale». Dovremo aspettare pagina 818, a che il nonno e il nipote si incontrino di nuovo profondamente mutati, smussati nei reciproci eccessi caratteriali: il nonno ormai sprofondato in una decrepitezza senza redenzione, il nipote sottratto finalmente al suo egotismo originario. Un incontro commovente già dalle parole del vecchio: «Lasciatemi vedere com’è ora chi un tempo ho amato così tanto».
Per tornare a Eggleston, ricordiamo che il racconto eponimo è ricalcato sul modello del Canto di Natale dickensiano, spostando però «l’accento sulla microeconomia etica della provincia» americana e sull’importante ruolo nella nuova società degli «spazi associativi urbani», il club appunto, là dove il protagonista da «principe dei salotti» si fa anche «organizzatore sociale» e filantropo. Non sarà inutile aggiungere che Il Club di Natale è, a tutti gli effetti, una ghost story, seppure di «architettura civica»: connubio, questo, che rimarca senz’altro l’originalità di Eggleston. Ma veniamo agli altri due racconti. Il primo, Huldah, la domestica, è una storia d’amore nel giorno del Ringraziamento, ma, soprattutto, un atto d’accusa contro i pregiudizi di classe: là dove, grazie a questa donna paziente e operosa, ci viene mostrato come la democrazia possa cominciare in cucina, col cibo. Il secondo, invece, s’intitola Il bastone da passeggio di Mr Blake, ove questo oggetto, che diventa improvvisamente «parlante», rappresenta un «feticcio del rango», ma anche uno «strumento di prossimità (appoggiarsi per far appoggiare gli altri)». Quali sono i «temi cardine» di questi racconti? Stocchi e Voltini non hanno dubbi: «L’educazione come elevatore sociale e palestra di democrazia; il denaro come test morale e strumento comunitario; la lingua come identità», se è vero che -e questo è un dato cruciale- «il dialetto non è semplice colore ma logica, un modo di pensare il mondo». Meno abbagliante di quella di Henry James e Twain, l’opera di Eggleston anche in questi racconti sa contribuire al tentativo di «fondare una letteratura peculiarmente statunitense, capace di celebrare la diversità regionale e, insieme, riconoscere un’esperienza condivisa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA