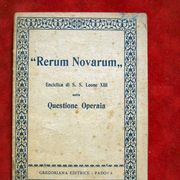La pena e la speranza. Oltre la condanna dello stigma
L’attuale modello penitenziario italiano riflette uno squilibrio strutturale originario: la maggior parte delle risorse economiche e del personale è destinata alla custodia e alla sicurezza interna degli istituti, mentre una quota significativamente inferiore è investita in istruzione, formazione professionale e supporto psicologico. Serve un ribilanciamento

L’articolo 27 della nostra Costituzione indica una rotta chiara: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non limitarsi alla sola custodia. Eppure, questa bussola sembra spesso smarrire il nord. Lo squilibrio tra sicurezza e rieducazione nelle carceri italiane, unito allo stigma sociale, rappresenta oggi il principale freno al reinserimento delle persone con trascorsi penali. È in questa tensione irrisolta che si annidano gli ostacoli più profondi alla piena attuazione del dettato costituzionale. Il primo nodo da sciogliere riguarda la necessità di superare la contrapposizione ideologica tra sicurezza e rieducazione. Nel dibattito pubblico su carcere e sicurezza, infatti, tutela dell’ordine pubblico e reinserimento sociale sono spesso presentati come obiettivi opposti, antitetici. Da un lato si invoca sicurezza, controllo e custodia; dall’altro rieducazione e reinserimento per chi esce dal carcere. Questa dicotomia è fuorviante: la sicurezza non si garantisce solo chiudendo le porte, ma si costruisce anche – e soprattutto - aprendo percorsi di reinserimento. Dove questi funzionano, la criminalità diminuisce e la società diventa più sicura; dove falliscono, ogni misura di controllo risulta fragile e inefficace.
L’attuale modello penitenziario italiano riflette uno squilibrio strutturale originario. La maggior parte delle risorse economiche e del personale, infatti, è destinata alla custodia e alla sicurezza interna degli istituti, mentre una quota significativamente inferiore è investita in istruzione, formazione professionale e supporto psicologico. Le statistiche 2024 del Consiglio d’Europa evidenziano che l’Italia presenta una delle più alte percentuali di personale all’interno degli istituti di pena dedicato alla sicurezza (il custodial staff), pari al 91% del totale, contro una media Ue di poco superiore al 50%. In Spagna e in Inghilterra, contesti comparabili per dimensioni al nostro sistema penitenziario, la quota si attesta rispettivamente al 74% e al 70%. Il problema non riguarda, tuttavia, solo la quantità di operatori, ma in egual misura la qualità degli interventi e delle competenze disponibili. Le carceri italiane richiedono professionalità in grado di affrontare efficacemente sfide complesse, quali l’integrazione della popolazione detenuta straniera, la gestione delle dipendenze e il supporto ai soggetti con disagio psichico. È, dunque, essenziale potenziare la presenza di operatori specializzati, garantendo loro adeguato spazio di azione. L’ampliamento delle piante organiche dei funzionari giuridico-pedagogici, negli ultimi anni, è un passo nella giusta direzione, ma non è ancora sufficiente.
Serve un ribilanciamento culturale e di risorse. Investire in sicurezza significa garantire l’esecuzione della pena, ma solo investimenti orientati a un’uscita positiva dal carcere trasformano la pena in uno strumento di prevenzione. La missione dell’articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve “tendere alla rieducazione del condannato”, non può realizzarsi senza programmi strutturati di istruzione, lavoro e formazione, dentro e fuori dal carcere. Lo ribadiamo, l’attuale organizzazione della spesa penitenziaria conferma questo squilibrio. In molti istituti, le attività rieducative dipendono in larga misura dall’iniziativa di volontari, che colmano una carenza strutturale di investimenti. Un attivismo prezioso, ma insufficiente, rispetto al fabbisogno reale: solo una parte ristretta della popolazione detenuta accede a tali interventi, spesso limitati nella quantità e nella qualità. I dati parlano chiaro: circa il 70% delle persone che escono dal carcere vi fa ritorno negli anni successivi, a causa della recidiva. Al contrario, dove si attivano percorsi autentici di istruzione, formazione e lavoro, la recidiva scende sotto il 10%, toccando in progetti specifici quote vicine allo zero. Questo dimostra che investire nel capitale umano non è solo un principio etico, ma una scelta strategica che genera sicurezza reale e riduce i costi per la collettività.
Ribilanciare le risorse tra sicurezza e rieducazione non è, dunque, un’astratta concessione ideologica, ma una scelta di razionalità concreta. Significa offrire alle persone detenute la possibilità di scegliere tra i benefici di un percorso di inclusione socio-lavorativa e il richiamo dell’economia criminale. Se è vero che le pene debbano tendere alla rieducazione – e che dunque non esista un obbligo a “farsi rieducare”, né la certezza del cambiamento – è altrettanto vero che lo Stato abbia il dovere di creare le condizioni perché ciascun individuo possa ricostruire il proprio rapporto con la società e nutrire la speranza di una vita migliore. Lavoro e formazione, dentro e fuori dal carcere, sono fattori cruciali per ridurre la recidiva e favorire un reinserimento stabile. Ma non bastano. Il vero nodo, spesso trascurato, è la capacità del nostro sistema socioeconomico di accogliere chi esce dal circuito penale. La ricerca condotta dal Cnel sui fruitori della legge Smuraglia dimostra che, più dell’incentivo fiscale, conta la disponibilità reale del mondo imprenditoriale e la dimensione etica dell’agire manageriale.
Qui emerge un fattore di difficile soluzione: lo stigma sociale, che si istituzionalizza nella "fedina penale". Il termine deriva dal latino fides (fiducia, reputazione), ma l’uso di un linguaggio moralizzante – "pulita" o "sporca" – trasforma la storia giudiziaria del condannato in un marchio sociale permanente, ben oltre la fine della pena. Richieste generalizzate di certificati penali, spesso non giustificate, rendono il reinserimento occupazionale un percorso a ostacoli quasi insormontabile, dove il passato giudiziario diventa criterio di esclusione automatica, più vicino a un giudizio morale che a una valutazione proporzionata del rischio effettivo. Si impone, con urgenza, un cambio di paradigma e una revisione profonda del modo in cui la società considera l’errore e la possibilità di ricominciare. Serve coraggio politico per rivedere norme e consuetudini radicate, con una nuova grammatica capace di bilanciare sicurezza e reinserimento senza contrapporli. Bisogna superare l’idea - rassicurante ma falsa - che la sicurezza coincida con la chiusura, e non con la responsabilità.
In Paesi come Germania e Francia esistono strumenti di limitazione dell’accessibilità dei “precedenti” non più rilevanti, e le informazioni sul passato penale possono essere rese invisibili ai privati quando non pertinenti. In diversi contesti, inoltre, si scoraggia la richiesta di precedenti nelle prime fasi di selezione, per concentrare la valutazione iniziale sulle competenze e, solo successivamente - se necessario - sulla storia giudiziaria. È un approccio che non minimizza la sicurezza ma la rafforza, perché riduce la marginalizzazione e la probabilità di ricaduta nel crimine. Certo, in Italia esistono la “non menzione” nel certificato del casellario giudiziale e la possibilità di ottenere la riabilitazione. Tutto questo, però, non basta. Se vogliamo ridurre davvero la recidiva dobbiamo disinnescare lo stigma, restituendo alla pena un inizio e una fine, senza che il passato diventi un destino immutabile. Dobbiamo intervenire sulle condizioni strutturali che impediscono la piena attuazione dell’art. 27 della Costituzione, bilanciando le risorse tra sicurezza e rieducazione e riducendo lo stigma attraverso iniziative concrete che contrastino pregiudizio ed esclusione.
Questo è il cuore del percorso rieducativo: l’investimento in un progetto di vita diverso e la speranza che lo sostiene, giorno dopo giorno. La speranza è l’elemento più potente per resistere alle tentazioni della devianza, dentro e fuori dal carcere. È ciò che riduce la recidiva e genera sicurezza reale già durante la detenzione. Accanto alla speranza, la premialità assume un ruolo decisivo. Collegare l’esecuzione della pena a meccanismi certi e trasparenti permette di valutare e rafforzare progressivamente la bontà della propria scelta. La premialità diventa così un termometro della volontà di cambiare e un modo concreto per misurare e riconoscere l’impegno quotidiano. Senza incentivi concreti, resistere alle sirene della devianza è estremamente difficile. Serve un vero idem sentire tra tutti i soggetti coinvolti: detenuti, operatori penitenziari, carceri rispettose dell’umanità, continuità educativa e reale volontà istituzionale di rieducazione. Solo attraverso uno sforzo congiunto cresce la probabilità di successo, coniugando così la sicurezza e il reinserimento. Non obiettivi confliggenti, ma due facce della stessa medaglia. Quando questi elementi si rafforzano reciprocamente, si realizza la vera sinergia, incarnando pienamente lo spirito costituzionale: una pena che non si limita a punire, ma educa, previene e costruisce futuro. La rieducazione è un percorso collettivo, sostenuto dalla speranza, dalla premialità e dalla fiducia reciproca. Ed è conveniente per tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA