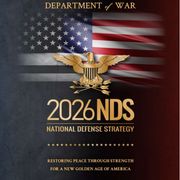La dignità del lavoro e la speranza chiusa in un armadio
Si lavora perché si spera di migliorare la propria condizione. Ma è altrettanto vero il contrario, che si spera perché si lavora: si prevede un futuro migliore e ci si impegna per costruirlo. Cosa resta di questo Giubileo

Aperta l’anta dell’armadio, la scorsa settimana in una soffitta di Prato (Italia, 2025), è caduto un cuscino e spuntato un braccio. Quello di un uomo, che non ha strillato, ha cercato solo di richiudere la porta per continuare a dormire e a sperare. Sperare in una libertà futura seppure da conquistare al prezzo della semi-schiavitù attuale: 12 ore alla macchina per cucire, 2 ore per mangiare e come giaciglio, appunto, un guardaroba. Nei dizionari non lo si trova, ma se ci si guarda dentro, appare lampante una verità: il vero sinonimo della parola speranza è lavoro. Si lavora perché si spera: di migliorare la propria condizione, di ottenere dei risultati, di realizzare sé stessi. Ma è altrettanto vero l’inverso. Si spera perché si lavora: si prevede un futuro migliore quanto più ci si impegna per costruirlo, si immaginano grandi risultati se si investono i propri talenti, se si mettono all’opera mani e testa. Speranza e lavoro sono due fili ritorti che si sostengono a vicenda: l’uno senza l’altra non resistono alle tensioni, intrecciati sono come il cordame robusto che regge grandi pesi e strappi improvvisi. Di questo Giubileo della speranza che cosa resta, allora, per il mondo del lavoro? Certo le parole pronunciate da Leone XIV: «Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene». La Dottrina sociale della Chiesa – che va dalla Rerum novarum di Leone XIII alla Laborem excercens di Giovanni Paolo II, fino all’Evangelii gaudium di Francesco – ha infatti via via meglio definito il legame decisivo tra lavoro e dignità umana. Caratterizzato da quattro condizioni: «Che il lavoro sia libero, creativo, partecipato e solidale», come sintetizzò efficacemente papa Francesco. Ed è proprio a questo quadrivio che la strada verso il futuro del lavoro si fa più incerta, qui che la luce della speranza oggi rischia di baluginare e non illuminare abbastanza la via.
La concentrazione dei mezzi finanziari nelle mani di pochi soggetti, infatti, amplia le diseguaglianze. Finisce per mortificare la libertà di enormi masse di popolazione. In combinazione con il rapidissimo progresso tecnologico, anch’esso appannaggio solo di alcuni colossi “over the top”, si fa assai concreto il rischio di una definitiva polarizzazione tra addetti a mansioni manuali non specializzate da una parte e alte professionalità dall’altra. Con i primi sempre più sfruttati e i secondi unici soggetti in grado di governare i nuovi mezzi di produzione di beni e servizi. Ancora, la rivoluzione dell’Intelligenza artificiale – oltre a cancellare una serie di funzioni e professioni intermedie – se non governata potrebbe abilitare le capacità di pochi e disabilitare fino a distruggere quelle di molti, già a partire dalla fase dell’istruzione. Proprio quelle capacità creative che caratterizzano l’apporto umano al lavoro e lo rendono mezzo di espressione della persona. È lo strumento principe non solo per vivere e realizzare sé stessi, ma soprattutto per concorrere al bene della società tutta.
Di fronte a pericoli di tale portata, su cosa riporre la nostra fiducia e il nostro impegno? Per il credente la speranza è Cristo, che tutto rinnova e che “in questi giorni” si fa persona accanto a noi, condividendo interamente la nostra condizione, la nostra umanità. E proprio questa scelta preferenziale per l’umanità può rappresentare, anche per i non credenti, la chiave per guardare al futuro del lavoro con l’ottimismo della volontà. Coltivando la speranza anzitutto come responsabilità verso gli altri e i più deboli in particolare. Spalancando le porte di quell’armadio a Prato come di tanti altri luoghi dove i lavoratori vengono sfruttati. Evitando con le leggi e le scelte imprenditoriali di ridurre il lavoro a mero costo, la transizione tecnologica solo a un mezzo per ampliare i profitti e non per favorire uno sviluppo condiviso. Rimettendo invece ogni volta al centro delle valutazioni la persona e non l’algoritmo, il bene comune e non la concentrazione di ricchezza e potere. Quanti licenziamenti di impiegati, ad esempio, potremmo evitare con un grande piano di formazione all’uso dell’Intelligenza artificiale: educando i dipendenti perché siano protagonisti attivi e non vittime passive del cambiamento? Quanto progresso economico e sociale potremmo ottenere contrastando lo sfruttamento e con una più equa distribuzione della ricchezza lungo tutta la filiera della produzione di beni e servizi? Senza lavoro non può esserci speranza. Ma senza una speranza condivisa qualsiasi lavoro, più che vano, diventa dannoso. Non lasciamo la nostra speranza chiusa in un armadio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA