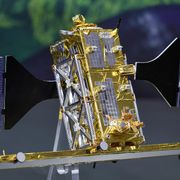Il caso De Maria, i detenuti che invece cambiano e quelle 50 vittime in meno
I progetti di riabilitazione e di reinserimento sociale funzionano nella stragrande maggioranza dei casi e fanno crollare la recidiva dei reati. Non è successo a Milano, ma generalizzare è un errore

La drammatica vicenda del condannato De Maria che, affidato da due anni al lavoro all’esterno, si è reso autore di un turpe omicidio e di una efferata aggressione, ha riacceso comprensibilmente un aspro confronto sulla opportunità di mantenere un sistema normativo che offre al condannato meritevole occasioni di graduale reinserimento sociale e lavorativo. A chi ricorda che ogni prognosi sconta purtroppo un inevitabile margine di fallibilità e che l’opportunità di progressivo rientro in società abbatte sensibilmente l’indice di recidiva, si obietta che queste considerazioni non leniscono naturalmente in nulla lo strazio delle vittime e dei loro cari. Ineccepibile, ma poco pertinente considerazione.
Partiamo da un’ovvietà troppo spesso trascurata: fatta eccezione per coloro che scontano un ergastolo c.d. ostativo, i condannati prima o poi, espiata la pena, escono dal carcere. Sovente per tornare a delinquere. L’indice di recidiva si aggira intorno al 70% (in Italia, il 68%), con qualche sensibile oscillazione da Paese a Paese (ad es., in Brasile più dell’80%, in Inghilterra intorno al 50%); questa inclinazione a ri-delinquere scema fortemente (in Italia intorno al 17%) qualora il condannato sconti la pena in un regime carcerario che ne rispetti la dignità, lo responsabilizzi e gli offra la possibilità di guadagnarsi un progressivo e controllato reinserimento sociale. Pure in tal caso gli indici statistici oscillano sino a registrare ancor più vistosi e significativi abbattimenti della recidiva a seguito di particolari iniziative pilota.
Sarebbe intellettualmente poco onesto non riconoscere che si tratta di percentuali non certo affidabili al decimale, essendo spesso frutto di metodiche diverse di rilevazione e di calcolo. Ma sarebbe intellettualmente disonesto negare l’esistenza di una forbice molto significativa tra i crimini commessi da ex condannati a seconda che questi abbiano subito una pena ciecamente segregativa, orfana di ogni speranza, o una pena pur severa, ma non insensibile alla loro effettiva partecipazione ad un progetto di riabilitazione che li abbia preparati a rientrare nella società civile, con l’intento e la capacità di viverci come avrebbero dovuto. Pertanto, quando lo Stato sa offrire una tale opportunità e il condannato sa meritarla, la collettività ne trae un beneficio molto significativo. Da un lato, perché recupera energie sociali: tornano in libertà soggetti in grado di svolgere un positivo ruolo nella collettività e, soprattutto, nelle loro famiglie, quasi sempre “condannate” di riflesso a condurre un’esistenza di precarietà economica e di stigmatizzazione sociale. Dall’altro, perché, modulando gradualmente la pena detentiva in impegnative misure da eseguire in comunità, la società sarà esposta a un minor numero di crimini.
Ciò non significa, ovviamente, che la pena non debba conservare anche una funzione retributiva: per i reati più gravi non saranno comunque evitabili lunghi periodi di detenzione, quand’anche il condannato sin dall’inizio s’adoperi in un serio e fattivo percorso di riabilitazione. Profondi conoscitori dell’animo umano hanno da tempo spiegato che «Il carcere come camicia di forza, come immobilità per non far del male è pura follia, è antieducativo. Non appena viene tolto il gesso, c’è subito una voglia di correre e di correre contro la legge» (Vittorino Andreoli). Una verità che sembrerebbe non abbisognare di ulteriori dimostrazioni; eppure, come il tanto venerato, purtroppo soltanto a parole, Papa Francesco avvertiva, il compito di difendere «la sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative» è «particolarmente difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere la loro mansione sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società».
Riprendendo le considerazioni di apertura, allora, il problema va impostato diversamente. Se approssimiamo a venti su cento il numero di coloro che, pur avendo avuto opportunità di anticipato reinserimento sociale, tornano a delinquere e a settanta su cento il numero di coloro che, senza tale opportunità, recidivano nel delitto, la profonda partecipazione al dolore della vittima dei primi non va confrontata con un’astratta proficuità del sistema, ma con le cinquanta vittime in meno che si saranno registrate offrendo quelle opportunità (che in pochi, ma certo non meno dolorosi casi, non hanno sortito l’effetto sperato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA