.jpg?width=1024)
Ansa
L’agricoltura rigenerativa non esiste ma si fa. Le pratiche sono quelle comuni a tutta l’agricoltura prima della rivoluzione verde, quando il contadino sapeva che sarebbe morto di fame se avesse sfruttato il terreno fino all’osso e, pertanto, cercava di conservarne la fertilità, evitando ad esempio le arature profonde. Da questa preoccupazione, nacque l’agricoltura conservativa, che per anni è stata la scelta di pochi eletti, finanziati dall’Europa. Dall’attenzione a ciò che sta sopra il suolo nacque invece l’agricoltura biologica, finanziata dal consumatore e soprattutto dalla Politica agricola comunitaria (Pac). Storicamente, solo quest’ultima filiera ha saputo legare al cibo un sentimento ecologico e identitario, ritagliandosi uno spazio importante nel mercato di massa.
E l’agricoltura rigenerativa? Sicuramente è figlia della conservativa, ma è anche imparentata con la biologica, perché si basa sul cambio di paradigma che sposta il sistema agroalimentare dagli obiettivi di autosufficienza produttiva del Dopoguerra a quelli di responsabilità ambientale e sociale emersi con prepotenza con la globalizzazione e come critica ad essa. Rispetto al mondo bio – il quale ha coniato una propria agricoltura rigenerativa, volta «ad aumentare la fertilità dei suoli, quantificabile dall’aumento di carbonio organico, dalla maggiore dotazione e disponibilità di elementi minerali e dall’aumentata diversità microbiologica» (“Agricoltura organica e rigenerativa”, Matteo Mancini, Terra Nuova 2018) – l’approccio di cui tanto si parla in questo periodo considera con attenzione anche la produttività e utilizza gli strumenti più recenti offerti dalle innovazioni tecnologiche, a partire da agrofarmaci e fertilizzanti chimici. Come per il bio, il metodo di lavoro è quindi improntato alla sostenibilità, ma diversamente da quello l’obiettivo resta la produttività.
Il problema di questa forma di agricoltura (ma forse è la sua fortuna) è che non è ancora stata codificata. Va più veloce nella pratica che nella scienza. Corre, perché da anni l’Unione Europea finanzia chi coltiva la terra rispettando il suolo, minimizzandovi le operazioni meccaniche – cioè sostituendo l’aratura con operazioni meno invasive, come la discissura, l’aratura superficiale, il vertical e lo strip tillage e la semina su sodo – e tenendolo coperto, con colture che oltre a nutrire il terreno, incamerando l’azoto atmosferico che poi viene sotterrato nel momento in cui queste cover crop vengono sovesciate, concorrono allo stoccaggio di carbonio organico. La minima lavorazione è tipica dell’approccio conservativo, che nasce per evitare erosione e desertificazione, laddove le pratiche di cattura e stoccaggio dei nutrienti nel suolo sono il marchio di fabbrica della agricoltura rigenerativa.
L’interesse delle istituzioni prima per l’agricoltura conservativa e adesso per la rigenerativa deriva dall’osservazione che il 70% dei suoli è depauperato di nutrienti, ma soprattutto che il terreno è la grande spugna che regola la diffusione del carbonio, la sostanza che condiziona il cambiamento climatico. Catturarlo e tenerlo nel terreno diventa dunque prioritario per l’Europa, come lo è per gli agricoltori, atteso che il deserto avanza quando si va sotto l’1% di carbonio organico.
L’agricoltura conservativa e quella rigenerativa, come abbiamo visto, concorrono dunque al medesimo obiettivo, ma la prima punta innanzi tutto alla fertilità e la seconda allo stoccaggio del carbonio. Ma non è tutto qui. Se la prima si limita a contenere le arature, la seconda aggiunge molte altre azioni, come la valorizzazione della biodiversità. Questa preoccupazione sempre più diffusa non riguarda solo uccelli e roditori, come si crede. Esiste una biodiversità importantissima ed invisibile: la coltivazione delle cover crop, ad esempio, attraverso la prolungata presenza delle radici favorisce lo sviluppo di microbi di cui si sa ancora pochissimo. Tra le due agricolture vi sono anche altre differenze: la coltivazione di copertura comporta spesso l’aratura, perché per tesaurizzare i nutrienti le cover vanno sovesciate, ossia interrate.
Entrambe, comunque, restano utili a immagazzinare (ma ancora non è chiaro quanto) il carbonio organico nel suolo e su questo punto si stabilisce l’alleanza tra agricoltura e ambiente: il motivo per cui le istituzioni finanziano chi coltiva in questo modo è che trattenere carbonio nel terreno contrasta l’effetto serra, esattamente come gestire un allevamento seguendo i dettami del benessere animale – altro criterio aggiuntivo della rigenerativa – limita le emissioni di metano, che è un gas climalterante; in parallelo, l’avvicendamento delle cultivar e l’uso di cover crop, entrambe rigenerative, favoriscono la produttività aziendale, dal momento che, come detto, alcune colture di copertura fissano nella pianta l’azoto atmosferico e ciò permette di coltivare altre cultivar in seguito, ricorrendo in misura minore ai fertilizzanti, che rilasciano protossido di azoto, anch’esso climalterante.
Per tutte queste ragioni, ancorché non codificata e dagli effetti di carbon farming ancora tutti da misurare, l’agricoltura rigenerativa è una evoluzione delle pratiche volte a conservare la fertilità del suolo e svolge, in aggiunta, quei servizi ecosistemici che rappresentano ormai una seconda natura dell’agricoltura. Certamente, non è innovativo che si finanzi la minima lavorazione, come avviene da anni nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, che sussidiano l’agricoltura integrata, ma lo è – culturalmente e politicamente – che la politica di sequestro del carbonio si fondi su una agrotecnica che non esclude la chimica e la genetica.
Come ricorda il professor Amedeo Reyneri, tuttavia, quando si dice agricoltura rigenerativa ci si riferisce a un insieme di «pratiche scientifiche sperimentate» che non rappresentano ancora un corpus agrotecnico definito. «L’agricoltura rigenerativa – ha spiegato recentemente il docente torinese all’Accademia Italiana delle Scienze – è un approccio agricolo adattivo». Questo non è secondario, in quanto significa che le tecniche rigenerative possono mutare secondo le caratteristiche del suolo e delle colture.
Lo stesso Reyneri ha definito questa opzione «un’espressione aggiornata di un’agricoltura integrata che riprende l’approccio olistico dell’agricoltura biologica, senza introdurre limiti a priori all’adozione di innovazioni tecnologiche nel settore della nutrizione (fertilizzanti, biostimolanti di sintesi) e della difesa (prodotti fitosanitari di sintesi) o di tecniche di miglioramento genetico (Ogm, Tea, ecc.), incorporando gli obiettivi della carbon farming ma in una visione più vicina alle esigenze espresse dalla società e dal mercato».
In questo argomento troviamo un’altra specificità della rigenerativa, che è la variabilità delle scelte: partendo da una corretta analisi del suolo e del contesto rurale, chi la sceglie dovrà esser pronto a minimizzare il disturbo del terreno, ma anche a mantenerlo coperto con i residui delle coltivazioni, oppure a seminarvi colture da sovescio, tentare in ogni modo di ridurre l’impronta carbonica attraverso la scelta delle cultivar, aumentare la biodiversità e infine ad integrare l’allevamento. Si prospetta un ritorno all’agricoltura mista che potrebbe portarci, entro il 2050, secondo studi dell’Università di Padova, a dimezzare le emissioni agricole, portandole da 32,7 a 17,87 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente.
Ma a quali costi? Stando ai primi studi condotti, la produttività dell’agricoltura rigenerativa nei primi anni potrebbe essere più bassa di quella convenzionale. Sicuramente, il mercato non ripaga i rigenerativi, come fa con i produttori biologici. Soprattutto, la grande distribuzione esige continuità, volumi e standard dai fornitori agricoli: questo è un freno al decollo dell’approccio rigenerativo. Pressate dalle campagne mediatiche e dall’Europa che le vuole più green e da un mercato che le spinge all’uso intensivo dei suoli organici e a generare emissioni crescenti di protossido d’azoto e metano, attraverso l’utilizzo massiccio di fertilizzanti e la concentrazione del bestiame, le aziende agricole cercano perciò nei biostimolanti, prodotti di origine organica di nuova generazione, una mano per mantenere alti e costanti i parametri di produzione, senza dover rinunciare alle pratiche rigenerative del terreno.
Per contro, se l’agricoltura rigenerativa si affermasse avremmo delle conseguenze socioeconomiche non trascurabili. Potrebbe indurre il passaggio da un’agricoltura aziendale a una sovraziendale (cooperazione e reti) in un Paese che incontra sempre maggiori difficoltà a mantenere le aziende agricole in attività, per ragioni dimensionali ma anche perché la superficie agricola si riduce a vista d’occhio, per effetto della cementificazione, dell’erosione e della desertificazione. Dal 1982 al 2020 in Italia sono spariti 3,3 milioni di ettari coltivati.
Oggi, le scelte agronomiche che abbiamo accennato – lavorazioni ridotte, controllo del compattamento del suolo (modificando ruote dei mezzi e traffico sul terreno), scelta di colture più efficienti nell’uso di risorse e come impronta carbonica, uso dei residui (con strigliatori e strigliastocchi), avvicendamenti e adozione di cover crop e colture intercalari (associando anche la coltivazione di specie forestali) e preservazione di inerbimenti spontanei, sostituzione dei concimi minerali con fertilizzanti organici del territorio, gestione integrata di difesa e fertilità, tutela delle aree di pregio naturale, modificare i sistemi irrigui, integrare l’allevamento, creare cooperative, filiere corte e reti d’impresa – sono finanziate a vario titolo dall’Ue e dalle Regioni. Senza soldi pubblici, per adesso, i conti aziendali non tornano, anche se, come precisa Dario Frisio (Università di Milano), «non si dispone ancora di valutazioni economiche».
Concludendo il recente convegno sull’agricoltura rigenerativa dell’Accademia dei Italiana delle Scienze, Deborah Piovan, agricoltore e ricercatore, ha richiamato «l’esigenza imprescindibile di misurare gli obiettivi». Serve, dice, «un sistema che sia in grado di calcolare e valorizzare la capacità dell’agricoltura rigenerativa di sequestrare carbonio». Peccato che le istituzioni scientifiche europee siano ferme alla demonizzazione del settore primario: conducendo un’analisi critica dell’agricoltura rigenerativa, il consiglio delle accademie scientifiche europee (Easac) solo quale anno fa liquidava il tema affermando che «i sistemi di produzione agricola stanno minacciando gravemente la stabilità del clima e la resilienza degli ecosistemi». Questo genere di affermazioni ha condotto la Commissione Europea a formulare strategie “punitive”, come il Farm to Fork, oggi pesantemente contestate, perché hanno dimostrato di avere una base ideologica e non scientifica. «L’unica via alla transizione ecologica – commenta Piovan – è attraverso il mercato: va resa conveniente economicamente, usando gli strumenti del mercato e delle imprese. Questo però richiede garanzia della trasparenza del processo, strumenti di controllo e quindi basati su dati, metodo scientifico, misura dei risultati»
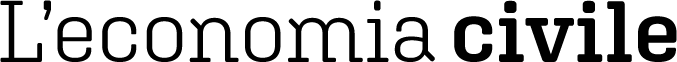




.jpg?dt=1714130568867&Width=300)
.jpg?dt=1714130568867&width=677)


.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)
.jpg?dt=1713949426548&Width=300)
.jpg?dt=1713949426548&width=677)

