Con Giacomo Leopardi la partita è sempre aperta, partita a scacchi, naturalmente, perché anche quando ti sembra di aver letto tutto e di aver capito quasi tutto, lui riesce sempre a sorprenderti con una mossa insospettata che ti costringe a non interrompere la partita che, lo sai già, vincerà ancora lui. Quindi, se ti capita in mano Il mappamondo di Giacomo di Gilberto Lonardi (Marsilio, pagine 276, euro 25,00) non puoi fare a meno di leggerlo. Lonardi, già ordinario di Storia della letteratura italiana e Critica dantesca, nonché di Storia della tradizione classica, nell'università di Verona, ha riunito e rielaborato suoi precedenti saggi leopardiani, consegnandoci un testo in cui dialoga con colleghi leopardisti non solo contemporanei, mettendo un po' in soggezione il lettore. Qui segnalo due punti che mi hanno particolarmente interessato. Il primo è il ragionamento di Lonardi sul perché Giacomo abbia scelto di chiamare “Canti” le sue poesie. Lonardi si appella a Rousseau per osservare che, all'inizio, non c'era differenza tra la parola e il canto: «C'è stata, all'origine, un'equivalenza tra “le vers, le chant, la parole” (tra il verso, il canto la parola). Una pienezza, questa, da opporre, per Jean-Jacques, grande ammiratore dell'oralità, alla perdita dell'“accent vif et passionné” (accento vivo e appassionato) che connota la lingua dell'origine». Il tutto in appoggio alla formidabile congiunzione leopardiana di lirica ed epos. Zibaldone 4359: «… vedesi insomma che l'epica si riduce per origine alla lirica, solo primitivo e solo vero genere di poesia». Inevitabile, dunque, la centralità del Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (Lonardi non dubita che si tratti di un pastore kirghiso) che si apre col verso a mio avviso più brutto della letteratura italiana: «Che fai tu, luna, in ciel?», che pronunciato senza virgole da qualche compagno di scuola meno portato alla lirica diventava: “Che fai Tuluna in ciel?”. E chi sarebbe questa Tuluna, forse una dea matrona dell'ultima Thule? Va dato atto, comunque, a Giacomo di aver scritto, nella Sera del dì di festa, anche il più bell'endecasillabo italiano: «Dolce e chiara è la notte e senza vento». Il secondo punto che mi ha incuriosito è la valorizzazione della traduzione di La feuille di Antoine-Vincent Arnault (1766-1834) che Giacomo ha incluso fra le sue poesie originali trattandosi propriamente di “Imitazione”, non di traduzione. Qui se sente l'eco della familiarità di Giacomo con le odi di Anacreonte, e siccome nessuno è indenne dallo strutturalismo, Lonardi analizza la ricorrenza della /V/ e della /F/ quando sono in gioco il Vento e la Foglia. Leggiamola per intero: «Lungi dal proprio ramo, / povera foglia frale, / dove vai tu? – Dal faggio / là dov'io nacqui, mi divise il vento. / Esso, tornando, a volo, / dal bosco alla campagna, / dalla valle mi porta alla montagna. / Seco perpetuamente / vo pellegrina, e tutto l'altro ignoro. / Vo dove ogni altra cosa, / dove naturalmente / va la foglia di rosa, / e la foglia d'alloro». Il tono è da minuetto, ma la sostanza è, pur sempre, «l'infinita vanità del tutto».
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI:
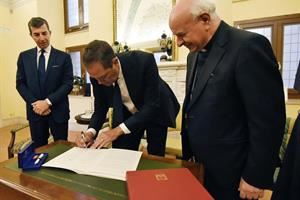
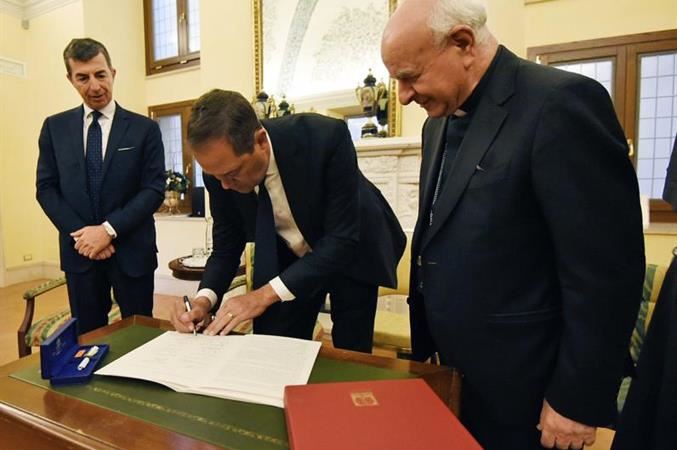
.jpg?dt=1713897716280&Width=300)
.jpg?dt=1713897716280&width=677)

