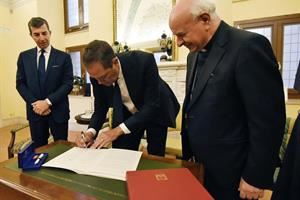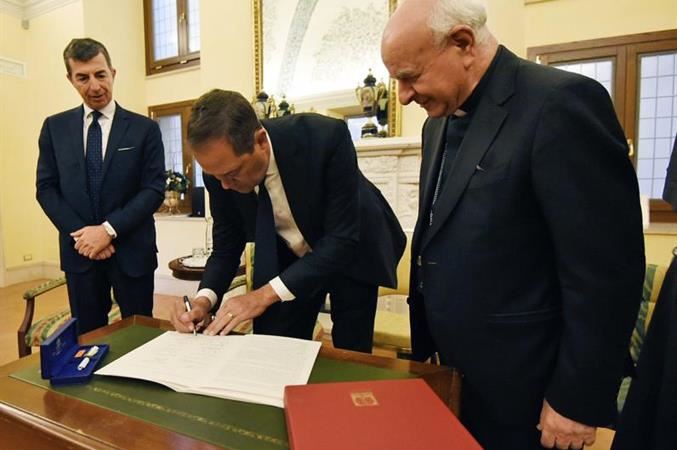nel dibattito sull’abuso della custodia cautelare è risuonato più volte anche il refrain sul «40% dei detenuti in attesa di giudizio», ripreso del resto dalla nota sentenza della Corte europea che ha, giustamente e severamente, censurato lo squallido stato di sovraffollamento e di degrado delle prigioni italiane. Quel ritornello riflette uno scrupoloso ossequio per il dettato dell’articolo 27 comma 2 della Costituzione («L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»). C’è però da porsi una domanda: lo sanno i cittadini italiani (e i giudici europei) che la statistica – a differenza di quelle relative alla generalità degli altri Paesi – comprende, tra i detenuti «in attesa di giudizio», pure chi sia stato condannato in primo e secondo grado e abbia fatto ricorso in Cassazione, magari soltanto per l’entità della pena inflitta? Più correttamente, nel recente 'messaggio' del presidente della Repubblica sul problema carcerario, si danno finalmente le percentuali disgiunte: da un lato, chi è «in attesa di primo giudizio» (al 30 settembre 2013, «circa il 19%»), dall’altro, i «condannati in primo e secondo grado» (a loro volta, «circa il 19%»); entrambe le categorie, poi, ovviamente contrapposte all’insieme di coloro che compongono il «restante 62%», vale a dire i «'definitivi' cioè raggiunti da una condanna irrevocabile». La distinzione non nasconde affatto una realtà che resta avvilente: anzi, forse, ancor più avvilente. È, infatti, sconcertante che un quinto dei detenuti siano persone tenute in carcere senza che un giudice abbia mai sentenziato, dopo un giudizio in contraddittorio, che sono colpevoli… E, questo, tanto più che da noi i detenuti in attesa di primo giudizio lo sono, molto spesso, non da qualche settimana o al più da qualche mese – come di solito avviene altrove – ma da interi anni. Cominciando a distinguere, però, si evita un’esagerazione demagogica e inutilmente masochistica e si induce, forse, a guardare finalmente a fondo alla dimensione più autentica (e più grave) di un intollerabile male della nostra giustizia e alle relative cause.
Mario ChiavarioProfessore emerito di diritto processuale penale dell’Università di Torino
Ha perfettamente ragione, gentile professor Chiavario, non c’è alcun bisogno di esagerare. E la realtà delle carceri è già così intollerabilmente forzata, da non sopportare ulteriori forzature. Noi di 'Avvenire', come sa, cerchiamo di stare alla larga dalle affermazioni a effetto nella consapevolezza che solo una buona dose di realismo e di umanità e uno sguardo sgombro possono aiutare a farla finita con lo scandalo di luoghi di detenzione classificabili come luoghi «di tortura». Questo ha sentenziato la Corte europea dei diritti dell’uomo, ma, prima ancora, questo hanno purtroppo verificato quanti – come lei e come noi – hanno a cuore una «giustizia giusta». Tesa, cioè, a sanzionare e a evitare il riproporsi del crimine e capace di puntare a ricostruire e riconciliare con sé e con la società la persona che viola la legge, l’integrità e il buon diritto altrui. Con una giustizia giusta è inconciliabile l’idea e la diffusa pratica di far scontare una pena preventiva, immediata eppure mai sentenziata (e mai totalmente risarcibile) a persone in attesa di giudizio, cioè a uomini e donne che per la nostra Costituzione sono solo 'presunti colpevoli' e non poche volte si rivelano, infine, innocenti. Ha proprio ragione, caro professore: la realtà degli istituti di pena avvilisce e indigna, non serve esagerare.