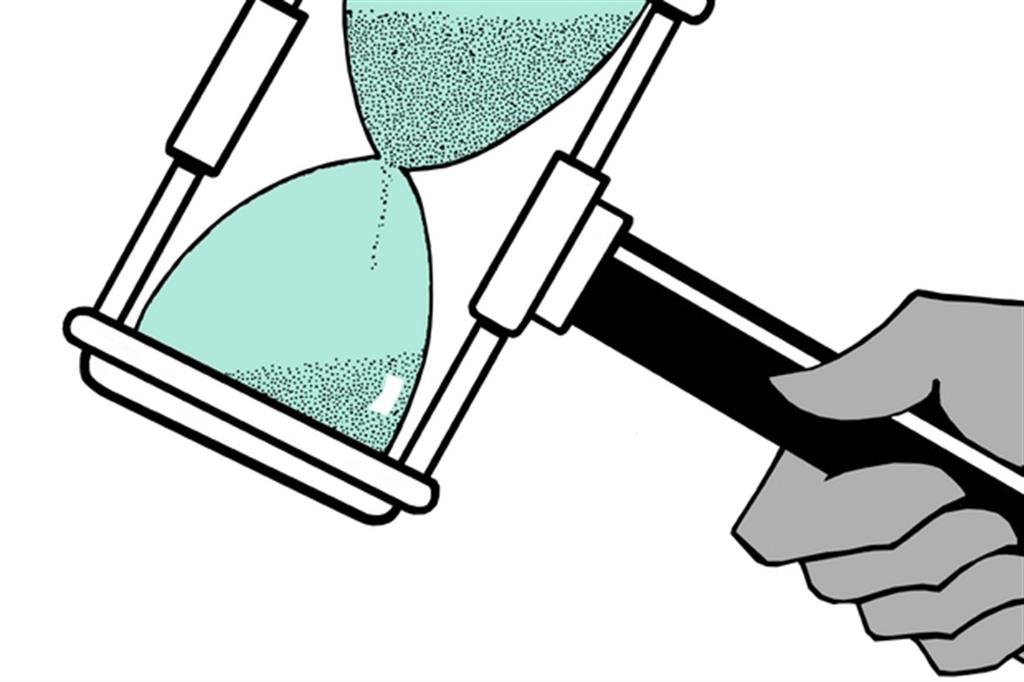
C’è una celebre pagina di Piero Calamandrei in cui, per definire l’habitus del giudice indipendente, il giurista fiorentino lo dipinge come un pretore di provincia che, seduto solitario al tavolino più appartato dell’unica trattoria del paese, ha «come unica commensale ammessa al suo desco, invisibile ma presente, la sua indipendenza». Quel modello di magistrato, se mai è esistito, ci ha lasciati definitivamente a partire dagli anni Sessanta. Perché al giudice dei giorni nostri si impongono orizzonti assai più ampi: egli deve applicare la legge non solo alla luce della Costituzione, ma anche tenendo conto dei trattati internazionali e delle sentenze delle Corti europee. Inoltre, quella tavola di trattoria di paese è oggi decisamente più affollata. E spesso – come abbiamo visto nei precedenti articoli – i mass media siedono tra i commensali abituali.
Anche da qui nascono nuove domande sulla legittimazione a giudicare: se quell’antico magistrato burocrate (che quasi meccanicamente applicava la legge) era legittimato dalla selezione tecnicogiuridica fondata su un concorso, può esserlo il magistrato di oggi, con i suoi nuovi compiti? I giuristi hanno una risposta precisa a questa domanda: proprio perché il lavoro del magistrato di oggi è più complesso e richiede un’alta professionalità, la legittimazione del giudice è 'mediata'. Viene dalla sua preparazione tecnica (valutata con la selezione del concorso) ma anche dal continuo aggiornamento, dal rigoroso rispetto delle procedure stabilite dal Legislatore, dalla sottoposizione del giudice al controllo critico dell’opinione pubblica. È una definizione articolata, che ci fa capire quanto questa legittimazione sia fragile: molto facilmente contestabile da chiunque abbia mezzi e potenza mediatica; come più volte è accaduto negli ultimi decenni. E infatti, tale definizione non placa l’ansia di una legittimazione più solida, la ricerca di un 'supplemento di legittimazione' di cui già vent’anni fa parlava Salvatore Mannuzzu.
Tale ansia può condurre a due opposte scorciatoie. La prima, più tradizionale e radicata in molti Paesi di antica democrazia, è quella di collegare le scelte discrezionali del magistrato al principio di sovranità popolare: ad esempio collegando al potere politico le scelte organizzative del pubblico ministero, che incidono vistosamente sul concreto esercizio dell’azione penale. La seconda scorciatoia è quella che vede il pubblico ministero andarsi a cercare un surrogato di 'legittimazione democratica' nel 'consenso dell’opinione pubblica'. Ovvero: nella popolarità. Ed è così che, di nuovo, si avanza lo strano soldato del 'populismo giudiziario': con la ricerca del 'processo esemplare' e mediatico, che abbiamo già descritto. Il passo successivo è l’investitura di questa popolarità nel campo della politica.
Chi oggi si scandalizza dell’impegno in politica di alcuni magistrati ha la memoria corta. Il fenomeno di magistrati che, ad un certo punto della loro carriera, si occupano di politica risale all’Unità d’Italia. Negli ultimi anni dell’Ottocento, l’8% dei senatori del Regno erano magistrati; come pure lo erano 21 sui 45 guardasigilli tra il 1848 e il 1899; mentre, tra i 43 primi presidenti di cassazione e d’appello, 27 furono parlamentari e 8 ministri; e, infine, su 8 capi della cassazione, 7 furono anche senatori (Antonella Meniconi, Storia della magistratura italiana, Il Mulino, 2012). La cosa non faceva scandalo perché, alla base di questi passaggi continui da una carriera all’altra, c’era una sintonia di fondo delle classi dirigenti: una forte omogeneità culturale e di classe tra ceto politico e magistrati, il cui cemento era costituito dalla medesima provenienza sociale. Semplicemente, in quell’epoca, la politica (governativa) attraeva nella propria orbita i magistrati, attingendo al loro sapere specialistico e utilizzandoli come 'tecnici'. La novità, che si verifica a partire dai primi anni 90, è radicale. Alcuni pubblici ministeri, diventati popolari per il loro lavoro giudiziario – grazie ad indagini su fenomeni criminali più o meno gravi, sempre accompagnate da una rumorosa attenzione della stampa – capitalizzano questa popolarità come base di consenso nella battaglia politica: per raccogliere voti, fondare partiti, diventare sindaci o governatori di Regioni.
Qui sta il salto rispetto al passato. C’è, a ben vedere, in questo tipo di operazione, un qualcosa di intimamente ed essenzialmente antidemocratico. Perché il consenso acquisito dal 'magistrato tribuno', e in nome di un’indipendenza che lo tiene al riparo dagli attacchi e dalle critiche cui è soggetto l’uomo politico, si fonda sull’esercizio di un potere che gli è stato conferito per applicare imparzialmente e senza mediazioni la Legge, in nome del popolo italiano. Confonderlo con il consenso che l’uomo politico si deve guadagnare dai cittadini elettori – nella battaglia sui programmi e sotto l’attacco degli avversari, nel costante tentativo di mediare tra desiderabile e necessario, tra moralità ed azione – intacca l’essenza della divisione dei poteri. Il magistrato che invade il campo della politica dovrà, prima o poi, misurarsi con la responsabilità che la politica richiede. Per questo, chi difende oggi il modello del 'magistrato tribuno' è il nemico più convincente dell’indipendenza della magistratura. Anche se, spesso, crede il contrario.
(4 - fine. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 10, 13 e 16 maggio)






.jpg?dt=1713897716280&Width=300)
.jpg?dt=1713897716280&width=677)









