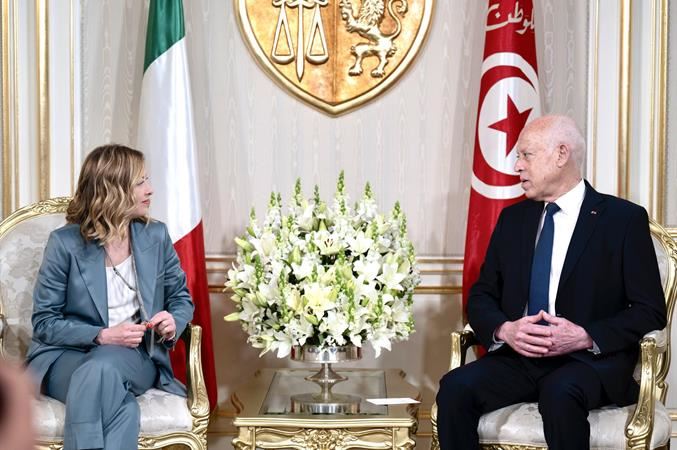Reuters
Dopo qualche anno ci hanno confessato che questa esperienza per loro era stata l’equivalente di una camminata in bilico, un crinale tra il sogno e lo shock culturale. Ma anche per noi, l’arrivo di tre ragazze afghane in redazione per un mese è stata una scommessa non da poco, in cui le resistenze da vincere erano tante, dalla barriera linguistica ai piccoli gesti di cameratesca confidenza che potevano essere fraintesi. Ma quel mese ha cambiato loro e ha cambiato noi. Quando Avvenire ha abbracciato il progetto di formazione «Attraverso i loro occhi » per allieve giornaliste dell’Università di Herat, finanziato dal 2009 al 2013 da Cooperazione ed Esercito italiani in collaborazione con il Master in giornalismo e il CeSi (Centro per la solidarietà internazionale) dell’Università Cattolica di Milano, l’Afghanistan, prima raccontato dagli inviati, è diventato quotidianità.
Le protagoniste di quelle vicende, le prime fonti degli inviati, ora erano sedute nella sedia adiacente, imparavano a impaginare, arricchivano il sito del giornale con contenuti video e fotografici originali. Si sentivano ed erano già giornaliste, attività che avrebbero continuato ad esercitare negli anni successivi ad Herat e Kabul per la Women News Agency e per altre emittenti/ siti/giornali locali. Alcuni di noi sono rimasti in contatto con loro. Dai social media era possibile seguire la loro storia: una ha continuato a fare radio, si è sposata con un collega, ha avuto dei bambini; un’altra si è impegnata a fianco del- l’organizzazione locale Rawa; una terza ha sperimentato il reporting televisivo mettendoci la faccia. Tutte non si sono tirate indietro quando hanno dovuto manifestare al funerale di Farkunda, la giovane assassinata con inaudita ferocia da una folla di uomini armati nel 2015, accusata di blasfemia per avere bruciato alcune pagine del Corano.
E da quel momento, tutto si è fatto più faticoso per loro. Perché essere giornaliste ha significato trovarsi in prima linea in ogni momento e in tutte le occasioni in cui era necessario ribadire che anche le donne hanno diritto ad esprimersi nello spazio pubblico e che continueranno a farlo, in ogni modo e forma, e che protesteranno se non ne sarà data loro la possibilità. S., S. e O. (non riveliamo i loro nomi per motivi di sicurezza) oggi, di questa scelta corroborata anche dall’esperienza nella redazione di Avvenire - fanno le spese, ognuna in forma diversa. S. ed S. sono bloccate a Kabul, nascoste in casa, per paura. S., che lavora con Rawa in difesa delle donne, non nasconde la preoccupazione: «Ho ridotto tutte le conversazioni on line, soprattutto tramite le app telefoniche: abbiamo paura dei controlli». S. non crede affatto nel make up promesso dai taleban di terza generazione: «Se a Kabul pare abbiano scelto di accreditarsi internazionalmente, ci arrivano cattive notizie dalle nostre colleghe nelle province rurali, da Jalalabad a Ghazni, da Khandahar a Bamyan».
Entrambe dieci anni fa si dicevano determinate a non lasciare il Paese. Due giorni fa hanno appena richiesto protezione e ricollocamento verso il Canada. Di certo, non è incoraggiante l’esperienza di O. che le ha precedute. Anche lei non aveva alcuna intenzione di lasciare il Paese finché, a causa della sua attività pubblica, il padre ha subìto un attentato da parte della milizia talebana nel 2015: è rimasto vivo, ma ha perso una gamba. E le minacce per O. si sono fatte sempre più pressanti. Per mesi, si è posta domande su che vita fare. Dopo essere incappata nelle maglie dei trafficanti on line, e avere trascorso mille notti insonni, O. è riuscita ad arrivare in Europa. Tramite una lettera di presentazione, siamo riusciti a ricollocarla per vie legali con l’aiuto del Cpj ( Committee to protect journalists) ed è entrata in Scandinavia. Da lì, è riuscita a muoversi verso la Germania dove si trovano altri afghani della sua famiglia estesa, ma i 5 anni di attesa del permesso di soggiorno sono stati durissimi.
Durissimo è stato soprattutto per lei il distacco dal marito e dalla figlia, ed è estremamente doloroso constatare che il ricongiungimento familiare somiglia più a una chimera che a una possibilità. S. ed S. hanno visto la luce negli occhi di O. spegnersi a poco a poco, mentre lei scivolava in una lenta ma profonda depressione: quella che accomuna migliaia di migranti, salvi nel corpo, finalmente, ma morti in spirito per lo sradicamento imposto da una guerra infinita. «Adesso – ci dice O., l’unica collega afghana che siamo riusciti a incontrare fisicamente 15 giorni fa – temo per mio marito, giornalista come me, e per mia figlia: riuscirò mai a riabbracciarli, quando tutte le ambasciate europee chiudono?». L’unica possibilità è sostenere O. con ogni azione possibile. Perché quel seme di giustizia e libertà tutto afghano cresciuto in lei e nelle sue colleghe, ha impregnato di orgoglio anche noi, fratelli nella comune umanità.








.jpeg?dt=1713358930417&Width=300)
.jpeg?dt=1713358930417&width=677)