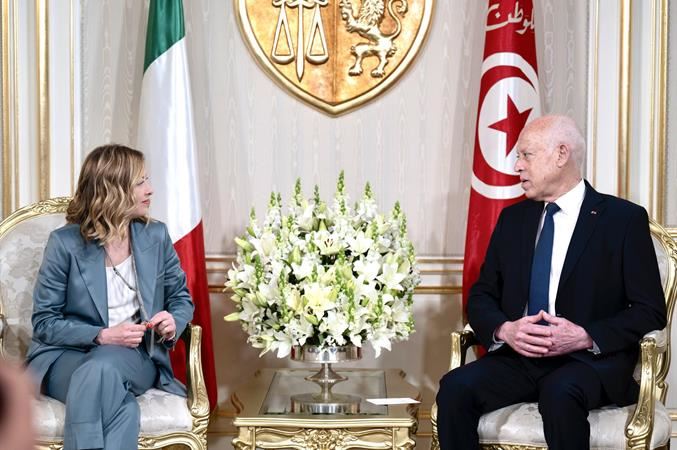«Le famiglie hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani». Sono sconfortanti le parole messe nero su bianco dal gip del Tribunale di Taranto, Rita Romano, nell’ordinanza con cui ha deciso che i due maggiorenni coinvolti nell’indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio Stano, il 66enne di Manduria morto il 23 aprile, dovranno restare in carcere, condividendo appieno il gravissimo quadro accusatorio della Procura (anche in relazione al reato di tortura) e confermando la decisione adottata dal gip minorile, che ha mandato in carcere anche i sei minorenni corresponsabili dei fatti. Intanto il quadro delle persecuzioni si arricchisce di particolari sempre più agghiaccianti: Antonio Stano «era braccato dai suoi aguzzini», era vittima di un «trattamento inumano e degradante», era «terrorizzato, dileggiato, insultato anche con sputi, spinto in uno stato di confusione e disorientamento» che lo costringeva «ad invocare aiuto per la paura e l’esasperazione di fronte ai continui attacchi subiti».
Di più: i video dei pestaggi che giravano su YouTube e sulle chat degli indagati e dei loro amici, ha evidenziato il giudice Romano, «erano divenuti merce di scambio tra i diversi giovani». Il tutto nel silenzio e nell’indifferenza generale, o addirittura con la complicità degli adulti: è il caso dello zio di uno degli aggressori, che avrebbe tentato di proteggere il nipote chiedendo di non fare il suo nome. O della madre di uno studente, che avvertita dalla professoressa di quanto stava accadendo (la docente aveva visionato i video) avrebbe detto che il marito aveva messo in punizione il figlio. Anche dalla scuola, d’altronde, non sarebbe mai partita alcuna segnalazione ai Servizi sociali.
La violenza dei piccoli, la sconfortante inadeguatezza dei grandi. In mezzo, il vuoto. Di dialogo, di ascolto, di senso. L’hanno vissuto nella propria carne, l’orrore di Manduria, Maria Luisa Iavarone e Paolo Picchio. Lei mamma coraggio di Arturo, il giovane accoltellato per le vie di Napoli da una baby gang nel dicembre del 2017; lui papà di Carolina, la ragazza che nel 2013 è arrivata a togliersi la vita per colpa dei bulli. Devastati, pieni di rabbia, questi genitori sono in campo, ogni giorno, accanto agli adolescenti e alle loro famiglie nel deserto dell’emergenza educativa. Tutto il contrario di quelli descritti dai fatti di cronaca degli ultimi giorni: «I nostri figli hanno sbagliato, ma qui ci sono solo bar» si è giustificata una mamma degli aguzzini che hanno rovinato al vita di Antonio Stano. «È vero, gli ho detto di buttare via il telefono per proteggerlo, ma non sapevo di quei video» gli fa eco uno dei papà degli stupratori di Viterbo. E ieri la donna di Lodi che entra a scuola e aggredisce la vicepreside, colpevole d’aver sospeso la figlia per motivi di condotta.
Cosa succede, prima che ai ragazzi, agli adulti? «Il male che dovrebbe immediatamente richiamare l’attenzione sistemica di tutte le agenzie educative: famiglie, scuola, istituzioni» spiega Iavarone. È un fiume in piena, divisa tra l’impegno costante nelle scuole con l’associazione Artur (Adulti responsabili per un territorio unito contro il rischio), fondata dopo l’aggressione a suo figlio, e un processo snervante, per cui uno degli aggressori di Arturo è già libero di scorrazzare per il quartiere, un altro si avvia al patteggiamento. Come se nulla fosse successo. «La verità è che di fronte a questi fatti non si può più stare fermi. E voglio proprio cominciare dai genitori, dalla mancanza di uno sguardo sui propri figli». Il ricordo corre al giorno che è scesa in strada per percorrere i 150 metri che separano la sua casa da quella della madre di uno di quei bulli: «Volevo parlarle, la porta è rimasta chiusa. Ripenso a lei tutte le volte che vedo genitori incapaci di riconoscere le colpe dei propri figli, perché riconoscerle significa anche ammettere che come adulti ne siamo responsabili».
Li chiama «alibi», Maria Luisa Iavarone: «È ciò con cui ci sentiamo tutti “coperti”, al sicuro. Come quello di non avere le password per guardare dentro ai loro telefonini. La password che ci manca in realtà è quella delle relazioni». Lo sguardo si allarga alla scuola, l’altro tasto dolente dell’emergenza educativa: «Otteniamo il ripristino dell’ora di educazione civica, e questa è una buona notizia, ma buttiamo via la Storia dalla maturità e diciamo ai nostri ragazzi che di storia, di storie, in fondo non c’è più bisogno. Così li lasciamo appiattiti sul presente delle chat, incapaci di proiettarsi in avanti o indietro e quindi anche nell’altro, del tutto insensibili». In una parola, disumani. «E ancora: togliamo la possibilità di mettere le note, di fatto azzerando quel poco di autorità rimasta agli insegnanti – continua Iavarone –. Questa settimana, a Napoli, è toccato a due ragazzi: accoltellati, per strada, da baby bulli. E io dico basta, dico che non possiamo più accettare questa deriva e che serve una rete, tra le agenzie educative, per invertire la rotta».
È lo stesso appello che lancia Paolo Picchio. La legge sul cyberbullismo – per cui ha lottato in prima linea dopo la morte di sua figlia, ad appena 16 anni, e che ha visto approvare dalla tribuna del Parlamento giusto due anni fa – non basta. Se ne è accorto tutte le volte che nell’ultimo anno ha incontrato i ragazzi, nelle scuole: «Più di 35mila, e penso a quelli che quando parlo scoppiano a piangere perché capiscono cosa vuol dire, che "le parole fanno più male delle botte", come diceva la mia Carolina».
Nel messaggio devastante che la ragazza ha lasciato ai suoi persecutori («mi sembra di rivederli, in questi ragazzi di Manduria, spietati e del tutto incoscienti» dice) lui ha trovato la forza per urlare il suo "non ci sto". «Ma siamo troppo pochi. Agli incontri che organizziamo con la nostra Fondazione i genitori mancano sempre. Non hanno ancora capito, quello che sta accadendo ai propri figli. E che bisogna tornare ad educarli».
A Fondazione Carolina – in prima linea anche nell’istituzione dell’Osservatorio internazionale sul cyberbullismo voluto da Papa Francesco – la chiamano con sconforto la “pastorale della salamella”: «Ci rendiamo conto che per far partecipare gli adulti dobbiamo sempre organizzare qualche evento più strutturato, che comprenda un aperitivo, un’occasione di convivialità» spiega l’educatore dell’associazione Pepita onlus, Ivano Zoppi. Come se mettersi in discussione nell’educazione dei propri figli, sedendosi ad ascoltare e basta, fosse già un’onta o un’ammissione di colpa. Il gruppo di esperti (15 tra psicologi ed educatori), che supporta Fondazione Carolina, è intervenuto nelle scuole tutte le volte che si sono verificati episodi come quello di Manduria: «Da Lecce a Varese fino a Lodi, nel caso di un suicidio avvenuto recentemente, abbiamo toccato con mano la solitudine dei docenti, la mancanza di tempo e di fondi per dare continuità ai progetti educativi pur meritoriamente messi in atto per accompagnare i ragazzi nel disagio» continua Zoppi.
Risultato: «Il ragazzo, che è sempre lo stesso coi suoi problemi e la sua richiesta di modelli, passa attraverso la scuola, la società sportiva, persino l’oratorio, senza che su di lui ci sia un patto di corresponsabilità educativa». E il più fragile diventa bullo, o vittima, che è lo stesso fallimento dal punto di vista educativo.
Sul nodo di un “patto” da rimettere in moto a cominciare dalla famiglia fino alla scuola e più su, alle istituzioni e allo Stato, insiste anche l’esperto di bullismo Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica Fatebenefratelli Sacco di Milano (l’unica struttura accreditata in Italia per la presa in cura del fenomeno) e responsabile del Coordinamento nazionale cyberbullismo presso il ministero dell’Istruzione. Oltre 1.200 i ragazzi presi in carico nel suo centro ogni anno, «nel 2019 drammaticamente in crescita – spiega –. Il nostro lavoro non a caso è quello di ricucire le relazioni che in ogni fenomeno di bullismo, sia ne caso di chi lo subisce che di chi lo agisce, sono compromesse».
Al centro del percorso di ricostruzione dei ragazzi ci sono proprio i genitori: «Penso a quelli di due dei ragazzi responsabili della morte di Carolina – racconta –. Hanno trascorso qui la loro messa in prova, che è durata due anni e mezzo su disposizione della Procura di Torino. Ogni giorno trascorso al centro lo hanno passato accompagnati dalle loro mamme e dai loro papà. Alla fine hanno preso coscienza di quello che hanno fatto». Educazione, rieducazione, «si può e si deve rimettere la questione in cima all’agenda del Paese».











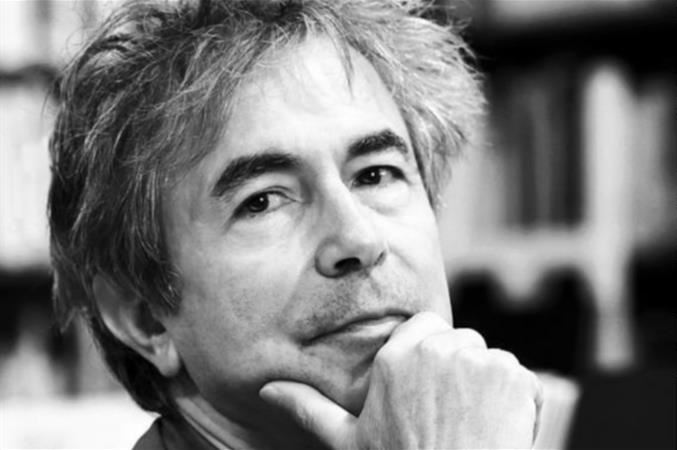


.jpeg?dt=1713358930417&Width=300)
.jpeg?dt=1713358930417&width=677)