
Qualcosa di primitivo e di viscerale si agita nella comunicazione politica ai tempi del populismo. È insieme un trionfo del politicamente scorretto, la rottura dei vecchi schemi delle campagne elettorali e l’uso sofisticato dei nuovi media, che in parte hanno sostituito i vecchi. «La vittoria inaspettata di Donald Trump è stata l’esaltazione massima della politica pop, che ha fatto centro e poi si è autodistrutta» sintetizza il sociologo Gianpietro Mazzoleni.
Si respira aria da anno zero nel mondo degli esperti del linguaggio politico, degli spin doctor, degli scienziati della comunicazione che stanno già facendo della corsa alla Casa Bianca 2016 un oggetto di studio. Molto di quello che da questa parte dell’Oceano era già conosciuto (e in qualche modo previsto) si è puntualmente verificato negli States: la forza dei leader cosiddetti outsider contro i simboli del potere che logora, la spettacolarizzazione anche volgare del confronto, l’abilità dei candidati di muoversi su più piattaforme, creando dal basso un palinsesto per parlare con i cittadini. Eppure tutto questo non basta per spiegare quanto spiazzante sia stato il “caso Trump” anche per chi aveva avuto assaggi simili in Europa. Alla fine non è stata la politica a determinare “una” visione del mondo, ma sono stati altri mondi a farlo, dall’economia alla Rete. E se nessuna concessione al fair play tra i candidati è mai avvenuta, è perché il leader populista (chiunque esso sia) vuole per definizione un contatto diretto con la “pancia” (il mood) del Paese, a costo di parlare come si parla al bar, tra allusioni, battute e frasi a metà. « I am your voice » diceva non a caso il presidente eletto nei suoi tour in giro per l’America.
«Michael Moore aveva ragione quando sosteneva che Hillary Clinton rischiava di essere la caricatura perbenista della donna – riflette Mario Rodriguez, già consulente di diversi politici italiani –. L’esito del duello è stata la vittoria degli animal spirits contro i guru del consenso. Non esiste nessun fact checking, nessuna verifica delle affermazioni fatte che tenga, di fronte al bisogno fideistico di credere in qualcosa. Gli strumenti della comunicazione contano meno di chi comunica, soprattutto se chi comunica si mette al livello, o anche più sotto, di chi lo sta ascoltando».
Secondo Sara Bentivegna, docente di Comunicazione politica all’Università La Sapienza di Roma, «c’è uno stile populista tout court, ormai condiviso da tanti, che ha fatto la differenza. Siamo di fronte a una nuova categoria della politica e del pensiero politico, propria di questa fase storica». Di più: se l’interlocutore al centro del palcoscenico conosce le regole della stampa e della televisione meglio di chi fa stampa e televisione, il rischio di essere strumentalizzati (senza accorgersene) da parte di questi ultimi è molto forte e Trump ha dimostrato di saper fare tutto questo molto bene, «prima incoraggiando l’attenzione dei vecchi mezzi di informazione nei confronti di un fenomeno nuovo, poi subendo e trasformando a suo favore il cosiddetto effetto underdog, il cane bastonato che va sostenuto dall’opinione pubblica contro l’establishment corrotto dell’informazione», osserva Mazzoleni. «È qui che Twitter e Facebook hanno avuto un peso decisivo nella scelta dell’elettorato, mentre i media tradizionali hanno perso posizioni » spiega Bentivegna. Così è potuto accadere, nella stessa notte, che mentre i sondaggi si soffermavano sul presunto successo della Clinton nei dibattiti televisivi («dove a Trump interessava soltanto non perdere e mostrare un volto presidenziale» annota la docente de La Sapienza) il nuovo presidente si rifugiasse nei 140 caratteri per mandare messaggi alle tre del mattino ai suoi milioni di followers. La tv veniva così di fatto scavalcata e la disintermediazione portava al dialogo diretto, vincente coi propri sostenitori sui social network.
La macchina dei consensi avanza anche così e lo fa a tutte le latitudini: annusando il vento, sfruttando le onde emotive che si creano nell’elettorato, accentuando alcune parole d’ordine piuttosto che altre. «La verità è che un candidato di rottura può fare cose che ad altri non sarebbero concesse, perché ha margini di movimento più grandi» sintetizza Donatella Campus, che insegna Scienza politica e Comunicazione politica all’Università di Bologna. Riempire la scena, anche fisicamente, portare la propria storia e i propri eccessi davanti al pubblico, senza infingimenti, sembra dunque pagare in una stagione in cui non si accettano più vie di mezzo.
«Un uomo che arriva dal mondo del business e della comunicazione, che ha alle spalle la forza di una carriera imprenditoriale “altro” dalla politica, ha avuto gioco facile nel descriversi come un alieno – sottolinea Mauro Calise, politologo dell’Università di Napoli –. Ciononostante, tutto era già scritto, da Ross Perot a Silvio Berlusconi. Prevale cioè il format dell’infotainment, che grazie al mix tra informazione e intrattenimento, consente ai candidati di bypassare il sistema dei media tradizionali».
È la figura del « social insider », secondo Campus, della « celebrity che fa parte dello stesso mondo di chi lo critica, ma sa muoversi abilmente nel confine labile che c’è tra realtà e finzione». Nel frattempo, si verifica quello che Calise definisce come «un disconnect, un distacco della cultura mediatica intorno a questi processi», per cui si va al traino del nuovo simbolo politico, si rilanciano slogan più o meno veritieri e si smette di analizzare con occhio critico quanto sta succedendo, anche nell’immediato. «Anche la crudezza del linguaggio è percepita come vera e finisce per essere più credibile chi accetta i propri simili per quello che sono» sintetizza Rodriguez. La pedagogia del leader, che dice ciò che andrebbe fatto ma lo dice mentre si eleva sul piedistallo, viene abbattuta all’istante, così come le chiavi di lettura intellettualistiche della realtà: conta il posto di lavoro che ho perso, non la spiegazione della crisi economica che ha portato alla mia disoccupazione.
Che ne sarà a questo punto della comunicazione politica? Per Mazzoleni, siamo ormai alla «politica trash, cugina della politica pop, che resta comunque la dimensione originaria, direi costituiva del dibattito pubblico odierno. La sfida adesso, nei confronti di Trump e degli altri leader populisti, sarà quella dell’accountability», della valutazione, passo dopo passo, dell’azione di governo, cosa diversa da una campagna elettorale. «Occorre innanzitutto uscire dalla bolla comunicativa in cui siamo finiti – evidenzia Bentivegna – che porta gli addetti ai lavori a parlarsi sempre più addosso senza andare a fondo di quel che succede». Adesso che il Big Bang è avvenuto, nulla sarà più come prima.



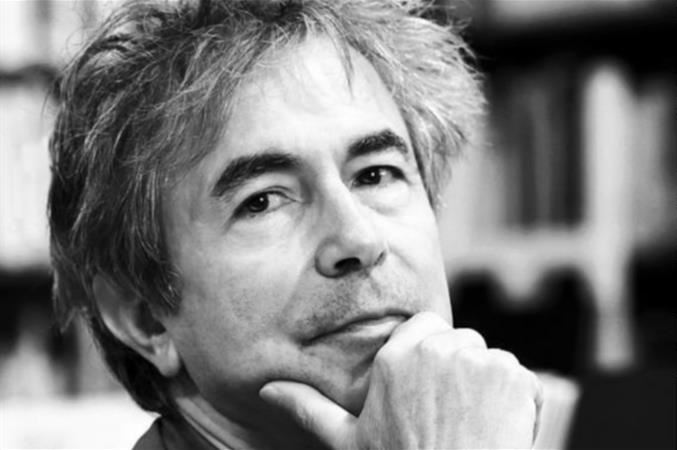






.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)





