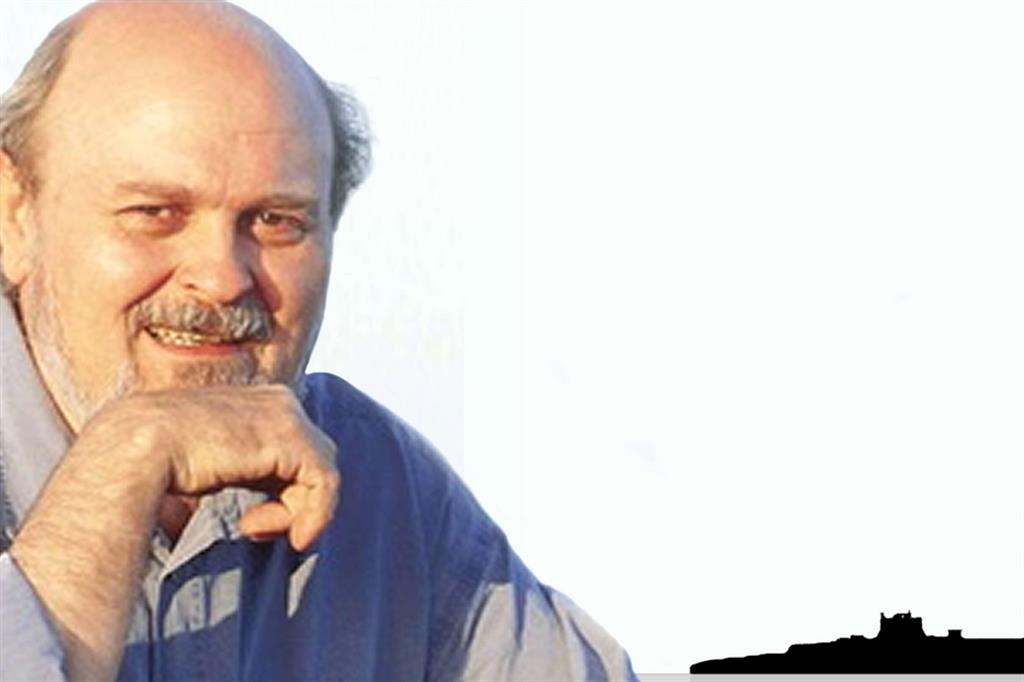
La copertina “Mai più triste né solitario” realizzata da Dino Oliva
Il Collettivo Soriano, fondato nel 2015 davanti al mare di Portopalo (Siracusa) dopo la biografia dedicata a Ricky Albertosi. Romanzo popolare di un portiere (Urbone) – vincitore del Premio Selezione Bancarella Sport 2020 – ora esce con Mai più triste né solitario (Urbone- La Fronda. Pagine 110. Euro 12,00). Un omaggio allo scrittore argentino Osvaldo Soriano, indagato in tutto il suo eclettismo. La linea sudamericana caratterizza i capitoli di Massimiliano Castellani (curatore) e Darwin Pastorin. Il critico letterario Massimo Raffaeli si concentra sul rapporto, anche epistolare, Soriano-Arpino. Sguardi da scrittori del nostro Meridione verso un Maestro del Sud del mondo sono quelli di Cosimo Argentina e Sergio Taccone. Direttamente da Buenos Aires i ribelli sognatori e fuggitivi sorianeschi si ritrovano nelle pagine di Paolo Galassi. Levinsky, nella prefazione sopra pubblicata, ricorda il legame tra il quotidiano “Il Manifesto” e Soriano, una collaborazione rivisitata da Pasquale Coccia. Infine, l’Osvaldo artistico e cinematografico, analizzato dai due critici Luigi Marsiglia e Renato Scatà.
Tra i tanti aspetti per i quali uno può amare la professione del giornalista, c’è l’avventura generata dalla possibilità di viaggiare, di conoscere altre città, culture, persone. E a proposito di Osvaldo Soriano, la mia relazione personale – lontana ma vicina, per l’affetto basato sulla mia ammirazione per lui e la sua opera – ha molto a che vedere con tutto questo. Una storia di stupende casualità, comparse col tempo. Come tanta gente della mia generazione – che sta arrivando o è già arrivata ai 60 anni – ho scoperto Soriano attraverso le sue brillanti colonne su Pagina 12, un giornale che negli anni ’80 fu assolutamente innovatore, che si dava il lusso dell’ironia in prima pagina, che poteva uscire in edicola con un’edizione integralmente gialla perché l’allora presidente Carlos Menem lo accusava di amarillismo, o integralmente bianca, quando lo stesso Menem annunciava l’indulto ai militari assassini dell’ultima dittatura.
Soriano aveva tutto: una grande prosa, raffinata ironia, idee strampalate e una creatività unica. E su quelle colonne di Pagina 12, in piena affermazione della democrazia, quando eravamo così giovani da poterci illudere di un’Argentina diversa, più inclusiva, con diritti per tutti, ma in particolare con “Giustizia”, Osvaldo aveva una rubrica fissa il cui nome era “Chiamata Internazionale”: un corrispondente in difficoltà economiche, in un paese che ha ereditato un debito col Fondo monetario internazionale sette volte superiore (da 6000 a 42 milioni di dollari) come conseguenza di una dittatura che ha fatto sparire 30.000 compatrioti e mandato a morire centinaia di loro (della mia generazione), in una guerra stupida e impari per le Isole Malvinas contro le inarrestabili truppe di Margareth Thatcher.
Soriano, in quei testi, è il personaggio che tenta di vendere da Buenos Aires, e in qualsiasi modo, qualsiasi informazione rilevante a un editore francese che non si fida di lui, sospettando che esageri le notizie per vederle pubblicate oltreoceano. Ogni articolo era una pennellata che mostrava come noi argentini ci fossimo ormai abituati alle questioni aberranti di tutti i giorni. Con i loro dialoghi surreali, l’editore diffidente, sfiduciato, convinto che tutto fosse assurdo (eppure utile a vendere di più), e il cronista che non sa più come fare perché chi sta dall’altra parte dell’Atlantico non diffidi dei suoi contenuti e non si creda ingannato, erano un’accoppiata perfetta.
Con l’ammirazione del lettore, del presunto e inesperto collega che si sentiva doppiamente attratto dal suo essere colto e futbolero, lessi poi alcuni libri geniali come Mai più pene né oblio (per me, il migliore), Triste solitario y final, Quartieri d’inverno o La resa del leone, che già nel titolo conteneva una sfida all’establishment, con il suo riprendere una parte dell’inno argen- tino (caduta in disuso) che alludeva all’Indipendenza dalla Spagna. Per queste cose della vita che ci portiamo dietro, per l’avventura che significa viaggiare, come parte del nostro lavoro, i nostri cammini cominciarono ad avvicinarsi, miracolosamente. Tutto cominciò tre anni dopo l’inizio dei sui articoli su Pagina 12, quando nemmeno immaginavo che durante i Mondiali del 1990 avrei avuto la fortuna di incontrarlo faccia a faccia e dialogare con lui.
E non in un’occasione qualsiasi, ma in una assai speciale come la finale tra Germania e Argentina all’Olimpico di Roma. Successe nell’intervallo, lontano dalle palpitazioni dei minuti precedenti, quando suonarono gli inni e Diego Armando Maradona guardò la camera della tv con quell’intuito bestiale che ha sempre avuto, focalizzando la devoluzione degli insulti che riceveva dalle tribune. A fine primo tempo mi sento addosso una strana freddezza, insolita per un argentino futbolero la cui nazionale sta giocando una finale, e per giunta pareggiando senza gol. Con questa sensazione strana mi dirigo al centro stampa per bere qualcosa, anche se in fondo lo faccio per verificare con alcuni colleghi se il pazzo sono io, per non sentire lo stesso che sentivo quattro anni prima contro lo stesso rivale. La stessa partita, ma nello stadio Azteca di Città del Messico.
Una cosa mi è rimasta in testa: uno di quelli che mi calmò, sostenendo che gli succedeva lo stesso, non era altri che Osvaldo Soriano. Che stava lì, parlando con altri giornalisti, bevendo un caffè in un bicchiere di plastica. Dopo aver visto il secondo tempo, e un finale triste e solitario come uno dei suoi libri, ho concluso che la cosa più memorabile di quella finale, per me, fu aver parlato di fútbol con il grande Soriano. Avrei voluto ascoltare cose del suo amato San Lorenzo, i suoi sogni di essere calciatore nel sud argentino, a Cipolletti, ma non era il momento, sebbene credo che in qualche modo immaginai un rincontro futuro, in una delle tante casualità della nostra professione. Cosa che purtroppo non successe, personalmente. E se parlo in questi termini, “personali”, è perché sì ci furono altri fatti che mi avvicinarono a Soriano.
Uno di questi fu grazie all’amicizia stretta con un giornalista de Il Manifesto, Alberto Piccinini, ormai non ricordo in quali dei tanti tornei che mi è toccato seguire. Forse durante una qualche partita all’Olimpico di Roma, al quale sono tornato abbastanza spesso dopo quella triste finale del 1990, con una squadra argentina senz’anima, che non giocava per nulla, e che solo correva, marcava, protestava, e che ebbe due espulsi. In uno dei miei tanti viaggi a Roma, tra i tanti banchetti, visite a musei e luoghi storici, andai a visitare Piccinini nella redazione del Manifesto, a pochi passi da Piazza di Spagna, e nell’entrare in quell’edificio antico mi trovai di fronte, con certa sorpresa, una certa quantità di poster di Soriano.
In qualcuno di questi, stava in posa con il suo ineffabile gatto. E fu lì che capii qualcosa di molto duro. Mi dissero che il Gordo, amato dai giornalisti di quella redazione, era morto di tristezza... Sì, di tristezza per quell’Argentina che voleva esporre nelle pagine di “Chiamata Internazionale”. Nemmeno lui ha potuto sopportare quell’ironia, la ridicolizzazione di quello che succedeva, e che era così normale per noi che vivevamo lì, così folle al punto di diventare incredibile, e persino ridicola, per eccesso, per quelli che si trovavano lontano, come quell’editore francese. Si poteva morire di tristezza per un paese allora? Soriano diventava per me molto più che uno scrittore, un giornalista di grande qualità, un raffinato espositore di fatti. Aggiungeva, per mia ammirazione, un elemento straripante, quello della passione.
Ma rimane ancora una cosa. A inizio del 2010 ricevo una telefonata con accento italiano. Si tratta di Lorenzo Garzella, che insieme a Filippo Macelloni è arrivato a Buenos Aires per filmare una specie di falso documentario, che lui chiama Mockumentary. Ci mettiamo d’accordo per un caffè. E lì ritornano misteriosamente le casualità, una dopo l’altra. La prima è accorgersi che, nel mezzo dell’enorme capitale argentina, viviamo nella stessa via, nello stesso isolato dello stesso quartiere di Palermo Chico. La seconda è una Sorpresa maiuscola: il documentario si basa su un racconto di Osvaldo Soriano, Il figlio di Butch Cassidy, cosa che ha risvegliato il mio interesse. La terza è che il protagonista principale della sceneggiatura è un giornalista che dovrebbe indagare su un presunto Mondiale di calcio giocato nel 1942 in Patagonia, che avrebbe sostituito quello saltato per la Seconda Guerra Mondiale.
Dopo avergli passato una serie di contatti e capire che idea hanno in testa, torno a casa soddisfatto, con l’idea di vedere un giorno come sarebbe stato questo documentario. Quando qualche ora più tardi torna a suonare il telefono è di nuovo Garzella, che mi dice che quel giornalista, il protagonista del documentario, sono io. «Senza dubbio. Sei tu». La proposta mi sembra ridicola. Cosa ho a che fare io, giornalista di carta e radio, con un lavoro che richiede dieci giorni di “filmazione”, con un gruppo di lavoro in un bus in Patagonia? Non ho mai recitato, non fa per me e le riprese cominciano due giorni prima di un viaggio in Europa programmato da tempo. Ma a mia moglie l’idea risulta interessante. Dice che è una forma di «destrutturarmi», spingendomi verso un secondo incontro, che in fondo «non costa nulla ».
Garzella mi fa passare da casa sua (meno male che non c’è troppo da camminare), mi dice che non devo nemmeno imparare a memoria la sceneggiatura, solo dire a modo mio i concetti principali in ogni scena. Mi fa salire su una scala, fingendo di cercare un video in uno scaffale. Una volta a terra mi dice, secco: «Non ci piove, sei tu e devi accettare». Il giorno dopo ho la costumista in casa, scendo le scale come un modello delle pubblicità, con mia moglie che alza o abbassa il pollice. E mi ritrovo viaggiando per la Patagonia, un’esperienza indimenticabile in tutti i sensi, con i ragazzi che sopportano la mia scarsa pazienza per ogni ciak ripetuto, promettendomi: «Questa sì, è l’ultima».
Mentre comincio a conoscere sempre più da vicino la trama dell’incredibile documentario che finirà per chiamarsi Il Mundial dimenticato, conosco gente della zona che in molti casi, presa dal mito, assicura di aver avuto un qualche familiare che aveva assistito a quella finale del 1942. Di cui effettivamente si sapeva poco e niente, ma che un Soriano geniale è riuscito a immaginare, per rimpiazzare il Mondiale che si sarebbe dovuto giocare davvero, e che aveva l’Argentina come sede riservata. La fortuna di essere giornalista finì per avvicinarmi a Soriano più di quanto avessi mai immaginato. E di questo, gli sarò per sempre grato.








.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)