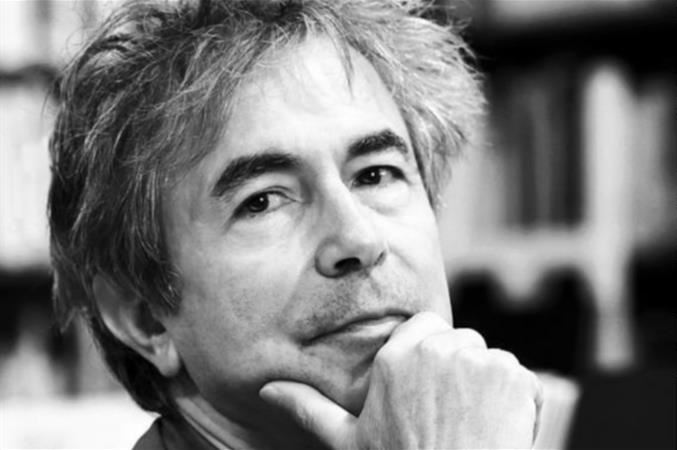In tempi in cui è di moda il “terzo paesaggio” una specie di ritorno all’idea del giardino all’inglese, che lascia crescere erbe spontanee e zizzania e ne fa una mitologia ( con buona pace di Gilles Clement, diventato il guru inevitabile del nuovo selvaggiume che copre come una peluria facciate di architetture e prati ben tenuti), è davvero coraggiosa la scelta del premio internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. Quest’anno il premio verrà consegnato il 10 e 11 maggio a Treviso ad una delegazione islandese per l’orto botanico di Skrudur (Skrúður) a Núpur, in Islanda. Si tratta però non di un giardino classico con fiori ed essenze, ma di un orto vero e proprio, con ortaggi e specie commestibili. Ed il suo significato è l’ostinazione di fare nascere in un paesaggio selvaggio e nordico, maestoso e al di là dell’umano, qualcosa che invece sia un segno forte di antropizzazione. L’orto che si staglia lungo un declivio di incomparabile bellezza è un hortus conclusus, un “paradiso” nell’accezione persiana originaria del termine. Proprio perché riuscire a far sopravvivere nel Grande Nord un giardino commestibile a temperature proibitive è un affare non da poco. Il giardino è arricchito da una scuola e da una chiesa sulla riva di un fiordo nella regione nord-occidentale dell’Islanda. Qui, come racconta il testo della fondazione Benetton Studi e Ricerche che promuove da ventiquattro anni il premio, un secolo fa il reverendo Sigtryggur Guðlaugsson, insieme al fratello Kristinn, aveva inaugurato una scuola e un programma di educazione volto al riscatto da condizioni agricole arretrate, ispirato alle idee del pastore danese Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) diffuse anche in Islanda. La metodologia di messa a coltura è particolarmente interessante date le condizioni di asperità climatica: «Tracciare un perimetro, in questo caso un rettangolo di meno di settanta metri di lunghezza per circa trentacinque metri di larghezza, dissodare il suolo ed elevare un recinto di protezione, educare e convogliare in questo piccolo mondo elementi utili, terra, acqua, molte diverse specie di ortaggi, che al di là di questo fragile confine verrebbero travolti dalle forze della natura».
Sigtryggur Guðlaugsson e sua moglie Hjaltlina hanno curato l’orto con un’attenzione quarantennale fino a farlo diventare non un tentativo, ma un ostinato giardino ritagliato, è la parola giusta, su un declivio che guarda a sud-ovest, verso la lingua d’acqua del Dýrafjörður, come un piccolo grumo di vegetazione, circondato alle spalle dalla cortina solenne di montagne dai fianchi mossi dall’erosione glaciale e a valle da un terreno brullo che digrada verso la riva del fiordo. Poi il giardino è stato abbandonato negli ultimi decenni del Novecento, per essere riscoperto e ripreso nel 1996 da un gruppo di uomini e donne che lo ha restituito alla coltivazione e ne ha fatto un luogo da visitare. Tutto ciò racconta lo spirito islandese che è sì l’ammirazione della grandiosità della natura, ma anche avventura pionieristica di chi ha colonizzato un luogo difficile e lo ha fatto diventare un posto abitabile. Siamo nella grande tradizione del senso della parola “giardino” che nel Sud d’Italia ha indicato dall’inizio del secolo gli agrumeti. Per quanto l’orto giardino di Skrudur sia piccolo segna un cambiamento importante nella valutazione estetica di un paesaggio. Per anni i paesaggi coltivati dei giardini hanno riflesso il bisogno molto forte nelle società urbane di avere dei pezzi di natura che sembrassero quasi selvatici, dal Giardino di Boboli alla Buttes-Chaumont di Parigi, al Central Park di New York: la natura come contraltare della società organizzata. Ovviamente era una finzione , perché per sembrare incontaminata e rupestre la natura deve essere inventata e curata.
Vi era inoltre l’idea forte di essersi lasciati alle spalle la società contadina, la natura come risorsa da intrattenere e su cui vivere e sopravvivere. Invece nell’orto islandese c’è questa ripresa del senso di coltivare, di “educare” che l’avere a che fare con la terra e con le sue possibilità dà. C’è la civiltà contadina, i tempi dell’agricoltura e l’agricoltura come fase di conquista rispetto ad una società di allevatori e di raccoglitori. Nell’avere riscoperto il valore dell’orticoltura c’è poi la rivoluzione di questi ultimi anni del chilometro zero di una agricoltura sana e locale. E tutto ciò ha a che fare con un cambiamento di paradigma che influisce oggi sui nostri criteri estetici.




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)


.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)