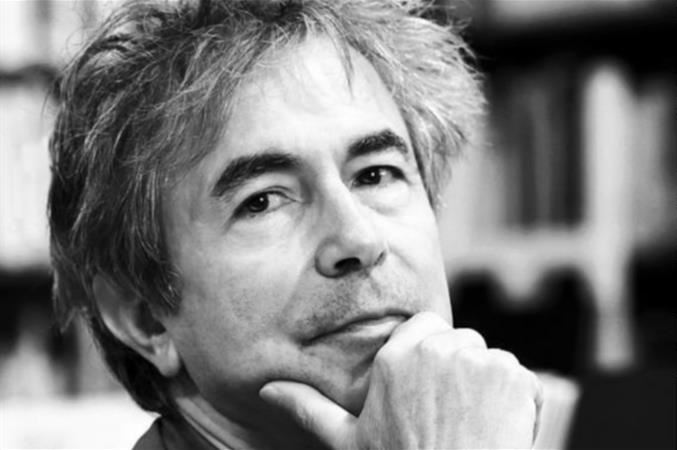Il contrasto maggiore si misura considerando la bellezza molteplice delle figure equestri che compongono la mostra degli antichi cavalli cinesi aperta da qualche giorno al Museo d’arte orientale di Torino – molteplice perché riferita non soltanto a epoche diverse della storia cinese, ma anche a una varietà formale che testimonia la progressione di questo vasto Paese verso una cultura del cavallo che, in fondo, gli era originariamente estranea –; è un contrasto che si percepisce proprio nell’evidenza “lontana” di queste opere realizzate nell’arco di due millenni, tra il XI secolo a.C. e il X secolo d.C.; una distanza che ci parla di un mondo ormai perduto; lo stesso che abbiamo visto riemergere dagli scavi della ormai famosissima sepoltura imperiale di Lintong (nello Shaanxi), che riportarono alla luce l’“esercito di terracotta” coi suoi settemila guerrieri, le quadrighe e, come ricorda Marco Guglielminotti Trivel nel lungo saggio che apre il catalogo della mostra (edito da Silvana), 116 unità di cavalleria.
Ma, nota Domenico Bergero nell’altro saggio in catalogo, la Cina di oggi mostra un calo d’interesse verso la cultura del cavallo (colpa anche della rivoluzione maoista che in questo animale vide un simbolo di sport aristocratici e dunque contrari al popolo). Se fin dagli inizi della sua storia la Cina fu grande importatrice di cavalli dalle stesse popolazioni nomadi che combatteva, oggi il cavallo è dimenticato anche nell’ambito sportivo, e questo spiega perché nella competizione olimpica di Pechino, nel 2008, la quadra equestre cinese ebbe scarsi risultati.
Non è qui il caso di perdersi in ricostruzioni storiche dettagliate, che il curatore della rassegna nel suo saggio d’apertura delinea bene, partendo dalla costatazione che la storia del cavallo in Cina è segnata dal confronto commerciale, ma anche bellico, con le popolazioni nomadi che, grazie all’agilità e alla simbiosi con il cavallo, riuscivano a mettere in difficoltà la stabilità dei confini cinesi su più fronti: popolazioni stanziali ed agricole, quelle del Paese asiatico che arriverà a una prima unificazione solo nel 221 a.C., contro etnie nomadico-pastorali che, a turno, insidiavano i confini da nord ma anche da sud per periodiche invasioni. Paradossalmente i “barbari” nomadi facevano coppia con l’animale che in ogni cultura è visto come espressione di eleganza, agilità e bellezza del portamento. È una storia molto antica che già in Europa risale alle invasioni kurganiche e alla scomparsa di quella cultura matriarcale che, come dimostrò Marija Gimbutas, venne spazzata via da popoli guerrieri che si accompagnavano nelle loro scorribande al cavallo.
Nonostante ripetuti tentativi i cinesi non riuscirono mai ad avere buoni e durevoli risultati nell’allevamento e nella selezione dei cavalli: così, come ricorda Guglielminotti, la Cina vendeva seta e comprava cavalli. Esiste persino un mito che congiunge l’essenza equina col baco da seta: il racconto parla di un padre che va lontano a combattere e lascia a casa la figlia e il suo stallone. La ragazza, forse scherzando, fa un voto: se il cavallo avesse riportato a casa il padre, lei lo avrebbe sposato. Il cavallo riuscì nell’impresa, ma il padre lo uccise e lo scuoiò. La pelle dell’animale, però, prese ad animarsi, avvolse la ragazza e la portò via; vennero ritrovati più tardi trasformati in bachi da seta su un albero di gelso. Come nota il curatore, il racconto si lega a certe mitologie sciamaniche, ma ha anche la forza di un mito dove la trasformazione incarna la sostanza soprannaturale del cavallo, simbolo di bellezza e potenza, di eleganza e furore. Non a caso, alcuni cavalli cinesi sembrano potersi mutare in ogni momento in drago e far uscire dalle loro froge fiamme infernali.
Un tema caro alla cultura cinese. E l’anno che sta finendo secondo il calendario cinese è proprio l’anno del cavallo. Da ciò prende pretesto la mostra, avvalendosi del prestito di una collezione privata e di alcune opere di proprietà del comune e di istituzioni torinesi come la Compagnia San Paolo. In tutto sono quarantacinque opere, raccolte sotto teche ed esposte in un unico salone al piano terra del museo. Per lo più di piccolo formato, queste sculture avrebbero meritato uno spazio espositivo più ampio e rarefatto, che esaltasse l’aspetto forse più paradossale che le connota: una monumentalità ieratica tanto più forte a dispetto delle dimensioni contenute.
Forma sacra, connaturata alla storia imperiale della Cina, che si avverte in ognuna di queste opere, anche in quelle meno intense. Sembra quasi che l’arte cinese voglia ricondurre il simbolo del dinamismo alla forma chiusa e statica che corrisponde all’origine stanziale del suo popolo. Che cerchi, insomma, d’imporre il giogo all’animale che non è mai riuscito a far diventare una parte di sé e che più incarnava la minaccia esterna ai propri confini.
Il Cavallo Celeste, che ha a che fare col soprannaturale, con una aristocrazia umana e divina insieme, che rimanda al sole e alla sua incarnazione politica nell’imperatore, domato e montato è il mezzo che stacca il cavaliere da terra e lo pone in contatto con le energie cosmiche che muovono il mondo. Le strepitose terrecotte grigie a ingobbio del II secolo a.C. o, dieci secoli dopo, le due sculturine del cavaliere con animale da caccia (un cane e un felino, nel caso specifico, ma venivano addestrati allo scopo anche uccelli rapaci), il gruppo dei cavalieri-suonatori, ecco, queste opere sono di una essenzialità raffinatissima che fa pensare a cose della nostra modernità. I due cavalieri che giocano a polo sono quasi dei guizzi di materia nello spazio, la rappresentazione stessa dell’eleganza equestre. Il cavallo bianco danzante, l’arciere invetriato e ingobbiato, la cavallerizza su cavallo grigio, il cavallo da parata e gli stilizzati cavalli in terracotta e bronzo che trasformano i caratteri somatici in forme decorative, ciascuna di queste opere vive in una luce che sembra lontanissima dalla Cina contemporanea che conosciamo, calata nella sintesi arrembante di capitalismo e comunismo, ovvero di due religioni prosaiche che hanno seccato o sepolto in una terra arida il seme di quell’aristocrazia di cui il cavallo celeste era l’araldo e il comunicatore.
Alcune di queste sculture sono riemerse da tombe o architetture funerarie. E lo stesso esercito di terracotta, anche se non può essere considerato un vertice dell’espressione artistica, nella sua imponente ampiezza ci ricorda questo essere pronti anche nella morte, perché la vita combatte la morte soltanto resistendo alla sua disgregazione delle forme. Nella cultura cinese antica questo senso del tempo, che incarna forza e bellezza in forme rituali, era scritto nell’ethos di un popolo che, dimenticando la cultura del cavallo che per due millenni cercò di integrare nella propria storia, ha perduto così anche una parte importante della sua stessa statura spirituale.
Torino, Museo d’arte Orientale
Cavalli celesti
Raffigurazioni equestri nella Cina antica
Fino al 22 febbraio 2015








.jpg?dt=1713510840835&Width=300)
.jpg?dt=1713510840835&width=677)


.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)