Tettucci scoscesi, come i sentieri sopra cui si ergono. Campaniletti svettanti, come le cime sotto cui parlano. Pietra, legno, olio di gomito per dar loro forma. Sublimarono il dolore e dispensarono speranza, le chiesette alpine della Grande Guerra: spesso edificate tra monti impervi, innalzate dai soldati là dove mai nessuno aveva prima d’allora osato combattere (sfidando vento e gelo, neve e valanghe: i rigori delle terre alte, prima ancora dell’impeto nemico). Molte continuano a esistere solo in qualche fotografia del tempo: vuoi perché nate in povera provvisorietà, vuoi perché distrutte – all’indomani della pace – nell’illusione di rimuovere anni di orrore. Ma diverse decine continuano a vivere nel tempo, dischiudendosi a chi, per raggiungerle, ha vinto la fatica del cammino. E non importa più se le braccia che le innalzarono fluttuavano in candidi camicioni (le nuove “mimetiche” pensate dal generale Luigi Cadorna per gli alpini d’alta quota) anziché in marziali divise grigioverdi (la tradizionale uniforme austroungarica): oggi, quei tempietti sono luoghi di preghiera e raccoglimento senza frontiere. E ricordo non solo dei caduti in guerra. Ma anche di chi, nelle circostanze più disparate, è stato successivamente “chiesto” alla montagna.Quando Caporetto (oggi in Slovenia) era un anonimo villaggio italiano, a un altrettanto anonimo sottotenente inquadrato nella valle dell’Isonzo fu ordinato di progettare una cappella da campo. Quel giovane fiorentino vantava una laurea in architettura, ma fino a poco tempo prima la guerra l’aveva impiegato solo come raccoglitore di cadaveri. Era il 1916: poco distante dal piccolo borgo di Casale Ladra, ai piedi del Monte Nero che già cantava la vittoria italiana del terzo reggimento alpini (giugno 1915), il venticinquenne Giovanni Michelucci firmò la sua prima opera. Oggi compie un secolo quella chiesetta, originale sintesi di pietra e legno: immagine di «sobrietà austera e perfino scontrosa», ricordano Claudia Conforti, Roberto Duilio e Marzia Marandola nel loro Giovanni Michelucci 1891-1990 (Electa).

Ed ecco la cappella quadrata, a fronte asimmetrico, con balconcino esterno nelle veci di pulpito e amplissima apertura davanti allo spiovente che protegge l’altare: in quelle linee essenziali – ma altrettanto eleganti e funzionali, davanti a cui i soldati ammassati nei prati circostanti, un poco più bassi della costruzione sacra, potevano seguire visivamente ogni rito della Messa festiva – già brillava in potenza il grande architetto del secolo scorso. Quello che a Firenze avrebbe concepito la stazione di Santa Maria Novella e la Chiesa dell’Autostrada. E che a Longarone (Belluno) – sono solo tre esempi tra i tanti – avrebbe ridato vita alla parrocchiale sepolta dal fango del Vajont. Fu Valido Capodarca a raccoglierne l’ultima intervista, quella in cui un Michelucci quasi centenario affidò alla storia uno tra i suoi più laceranti dispiaceri: «Oggi questa mia creatura esiste ancora, ma non più in Italia – si legge a proposito della chiesetta di Casale Ladra in
Ultime voci dalla Grande Guerra (1915-1918) (Brancat) –. Qualcuno, oltre due decenni più tardi, ebbe la balorda idea di lanciare il nostro Paese in una nuova folle guerra, vanificando gran parte del sangue versato dai ragazzi della mia generazione».
La chiesetta al rifugio Corsi, a Cevedale (foto Pietro Baldrighi)Accadde invece il contrario, ben più in alto, sulle pendici nord del Cevedale. Lì, ai 2265 metri del rifugio “Nino Corsi”, la cappella di guerra sorse su suolo austriaco. Ma ben presto l’armistizio l’avvolse nel tricolore. Oggi quel tempietto di sola pietra s’innalza in provincia di Bolzano, incastonato là dove l’alta Val Martello quasi abbraccia il confine trentino. Entri, e subito capisci come sofferenza e speranza accompagnano la storia ben oltre i confini della guerra. È vero: il quadro elevato a semplice pala d’altare rappresenta Cristo che consola un soldato ferito. Ma la mensa eucaristica è divenuta uno spontaneo sacrario dei nostri giorni: decine di foto, nomi, cartoncini ricordo e lettere tengono viva la memoria di chi ha da poco lasciato questa terra. Lì, a rinnovare il legame con quei volti, qualcuno è salito di recente. Ed evidentemente attrezzato per gelo e neve, dinanzi a loro ha acceso due ceri. È il più alto dell’Alto Adige, quel luogo di memoria. Ma non il più elevato tra le chiesette della Grande Guerra.
.jpg?width=620)
Adamello, 2460 metri: la cappella “regina” svetta sotto le pendici occidentali del Carè Alto, icona dell’omonimo rifugio adagiato qualche decina di passi più a nord. La innalzarono nel 1917 i prigionieri russi, la dedicarono il 17 luglio – alla Madonna di Lourdes, in memoria dei caduti – i “padroni” austroungarici. Ma correvano tempi grami, per i soldati imperiali: sul corno di Cavento svettavano le penne degli alpini. E la perdita austroungarica di quella tattica vetta, trentadue giorni prima, aveva segnato la morte (anche) di Felix Hecht von Eleda: il ventitreenne tenente che amava il nemico italiano tanto quanto quelle montagne, quello stesso comandante dei kaiserjäger il cui diario – ora custodito a Spiazzo Rendena nel Museo della guerra bianca adamellina – è insieme abbandono fiducioso al volere di Dio e ferma condanna di chi volle la guerra. Il padre, nobile di Vienna e generale dell’esercito, fece di tutto per cercare il suo corpo. Poi si rassegnò. Suggestiva ipotesi, quella che Dante Ongari ha formulato ne
La guerra attorno al monte Carè Alto (Rendena): «È probabile che proprio il generale Hecht, deluso dalla vasta quanto vana ricerca della salma dal suo unico figlio, estesa anche al Vaticano e alla Croce Rossa, abbia infine sollecitato, a suo spirituale conforto, il comando del Carè alto a erigervi la bella cappella lignea». Storia struggente. Eppure solo una delle tante raccontate da questi segni di sacro e sangue, incastonati nell’arco alpino tra Slovenia e Alto Adige. Basti pensare alle memorie custodite dalle chiesette di Pal Piccolo e Pal Grande sulle Alpi carniche friulane, piuttosto che dalla cappella sul monte Lozze in Veneto o dal piccolo luogo di culto presso il rifugio “Garibaldi” sull’Adamello lombardo. E senza contare le centinaia di croci, capitelli, sacrari e chiesette innalzate successivamente, a ricordo di quella carneficina. Ma questa è tutta un’altra storia.

%20(2).jpg?width=620)
.jpg?width=620)





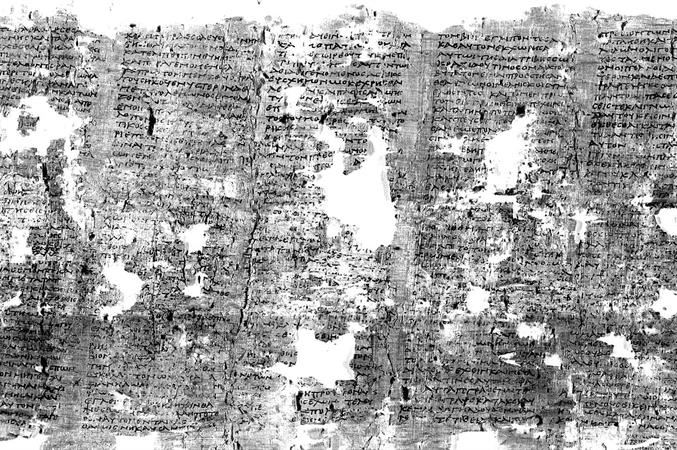
.jpg?dt=1713897716280&Width=300)
.jpg?dt=1713897716280&width=677)









