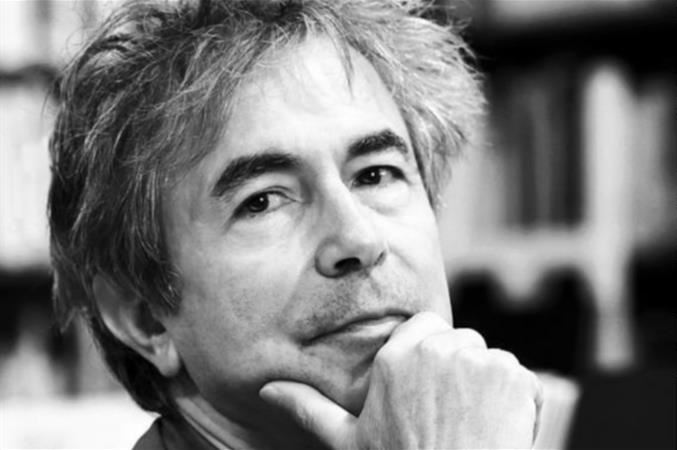È già tutto detto per immagine nella prima stanza della mostra che si tiene alla Fondazione Magnani Rocca, a cura di Laura D’Angelo e Stefano Roffi, con una coda nel titolo che invita a guardare i due protagonisti come «ultimi moderni». I due sono Marino Marini e Giacomo Manzù, e prima ancora che entrino in scena le opere il terreno è preparato da due gigantografie che li mostrano accanto a una loro opera emblematica. Manzù è vicino al busto della moglie Inge, Marino accanto a un suo cavaliere degli anni Cinquanta con quella forma equina che si prolunga nel collo teso come un simbolo di forza, una specie di forma itifallica si potrebbe dire che guarda all’antico più arcaico, o primitivo, quello dove il rapporto con la vita si esprime come transfert sulla forma di un erotismo che è, di solito, uno degli elementi fondativi dell’arte plastica, non solo moderna. È, dicevo, tutto in quelle due foto, perché, se dobbiamo considerarle due ritratti dei protagonisti, quali effettivamente sono, allora non c’è dubbio che quella vicinanza con le loro sculture è anche una sorta di confessione della poetica che le ha formate. Per me Manzù resta uno scultore a due dimensioni: il bassorilievo è la sua via maestra, la via lirica, attraverso la quale riesce a incidere sulla superficie la forma, la scava, ma sempre con un valore allusivo dello spazio che viene da lontano, dallo “stiacciato” di Donatello, ma non ha, come in certi rilievi marmorei classici, l’ambivalenza di materia ed erosione luminosa, nella ricerca dell’impalpabile visivo. Lo vediamo nei bassorilievi esposti – il più intenso e anche il più “antico” resta lo Studio per la Porta di San Pietro del 1949 –, laddove il fondo, quasi alla maniera di un negativo fotografico, si rivela anzitutto come spazio “nero” sul quale va a depositarsi il segno che l’artista gli impone (figure esili come l’alberello o le iscrizioni latine non sono semplici elementi “narrativi”, ma vere e proprie strutture che rendono profonda la superficie caricandosi di energia luminosa). Manzù è famoso ancora oggi per i suoi Cardinali, e anche per aver fatto il ritratto a Giovanni XXIII nel 1963. In realtà, vent’anni prima, quando eseguì il bassorilievo della Deposizione esposto a Milano nel 1941, fu aspramente criticato da parte cattolica: nel contrasto fra il Cristo sofferente e la protervia fisica del soldato che lo tortura, si vide una interpretazione umiliante della Passione. Inutile dire, dati gli anni, che cosa poteva trasfigurare Manzù in quel bassorilievo (ci fu molta sofferenza nel Ventennio, e la protervia dei torturatori era sottintesa a livello metaforico). Nel 1946, Manzù venne iscritto dal Sant’Uffizio nella lista degli artisti “indegni” e trovò conforto, come viene ricordato nel catalogo della mostra (Silvana), da don Giuseppe De Luca, che l’anno dopo mediò la pacificazione fra l’artista e Pio XII. Venne poi il concorso per la porta di San Pietro, anche questo tormentato per Manzù, che non riusciva a sentire il tema scelto, quello del «trionfo dei santi e dei martiri della Chiesa» e soltanto in seguito, parlando con Giovanni XXIII per le sedute di posa del pontefice, riuscì a far modificare il tema in quello della morte, che, come si dice in catalogo, esprime «in tutto il suo significato terreno». Ma diventato, per così dire, uno scultore del Papa, Manzù dà l’impressione di accontentarsi, di chiudersi in un linguaggio che è piuttosto la maniera di se stesso: lo “stacciato” moderno degli anni Cinquanta diventa l’arte di tagliare nello spazio tridimensionale delle silhouettes che possono avere anche una valenza plastica, ma sono, sostanzialmente, dei disegni che incidono nel vuoto delle figure totemiche, i Cardinali per esempio: chiusi nel piviale, hanno sempre una forma a cuspide che sembra l’estensione simbolica della mitria che portano sul capo e con cui s’identificano (dunque, l’emblema della loro potere ecclesiale). La conferma di questo “appiattimento” formale – che denota però un impoverimento dell’intensità plastica – si trova nella scultura, ai limiti del caricaturale (involontario?), dei Due attori nel mio studio (1968). Dello stesso anno è anche il bassorilievo Studio per la pace, con la madre distesa che solleva nell’aria il figlio, ma ormai è evidente che quel che Manzù doveva dire l’aveva detto tra gli anni Quaranta e Cinquanta e il seguito segnò una perdita di peso specifico, come si vede anche nel Busto di Inge del 1966, singolare innesto, al limite del kitsch, di un ritratto più o meno reale su un corpo che sembra un vaso sul quale siano stati incisi i segni dell’abito. Marino Marini ha, rispetto a Manzù, il vantaggio di essere stato capace di cambiare più volte nella vita, raggiungendo sempre un limite estremo di tensione tragica. Dopo la fase etrusca e classica (in mostra non documentata, ma forse anche per una giusta limitazione dettata dall’assunto degli «ultimi moderni»), e la definizione di un universo più vicino alla realtà coi ritratti degli anni Cinquanta e Sessanta (straordinari sempre, ma in particolare quelli di Stravinskij, di Chagall e Mies Van Der Rohe), ecco che il tema “cavalli e cavalieri” prende il sopravvento. E Raffaele Carrieri scrisse un articolo intitolato, appunto, «Ossessione equina di Marino». È da notare che lo scultore viene sempre indicato col nome di battesimo, come accade di solito ai grandi dell’arte. È la percezione di un talento supremo che, con Martini, indubbiamente sta al vertice nel Novecento in una graduatoria degli scultori puri italiani. Marino è davvero l’ultimo moderno, perché ha portato la scultura a esprimere il vitalismo della forma in una costruzione classica, sostanzialmente “ferma”: torsione, esplosione, tensione si giocano dentro un diapason formale che tiene a freno le energie in conflitto non tanto nella materia, ma nella “storia”. Il cavaliere che apre le braccia e le gambe come in un gioco d’acrobazia, seduto sul cavallo che si tende come se volesse liberarsi dal freno che l’uomo gl’impone (pensiamo al cavallo imbestialito di Guernica che è anche un conio da uno dei cavalli di Piero nella Leggenda della Vera Croce) è davvero una metafora del Novecento e dei suoi tremendi conflitti. Il cavallo s’impenna, cade, quasi stramazza al suolo, frena improvvisamente la sua corsa per disarcionare il cavaliere; ma l’uomo sembra resistere alla sua cavalcatura. Finché – ed è una riflessione sulla distruzione estrema, quella che cancella la forma umana –, la serie dei guerrieri alla fine degli anni Cinquanta dichiara anche la sfiducia di Marino nella capacità umana di risorgere (la guerra era finita, in fondo, da troppo poco per dimenticarsene), e il Grido del 1962 è l’ultima metamorfosi di cavallo e cavaliere, ormai entrambi ridotti a terra e prossimi a una di quelle figure pompeiane rese eterne dalla lava del Vesuvio. Ma il vulcano, questa volta, minacciava il mondo intero. Mamiano (Parma), Fondazione Magnani Rocca. Gli ultimi moderni Fino all’8 dicembre. Sopra a sinistra: Marino Marini, «Ritratto di Carl Georg Heise» (1962); a destra, Giacomo Manzù, «Sedia con frutta» (1960). Sotto la scultura di Marino Marini, «Cavallo e cavaliere» (1950); a sinistra, il «Grande cardinale» di Giacomo Manzù del 1960.










.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)
.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)