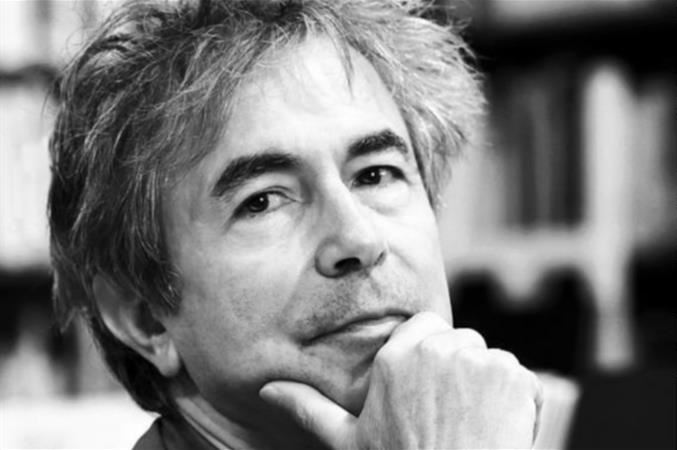Dal 1949 al 1955 sono stati oltre 30.000 i deportati nei campi di concentramento di Goli Otok e del vicino arcipelago di Arbe, in Croazia. Di questi, 4.000 non sono più tornati a casa (i corpi sono stati ammassati in fosse comuni) e molti di quelli che l’hanno potuto fare si sono tolti la vita o sono impazziti. Comunisti perseguitati da comunisti, sottoposti ad atroci torture e a raffinati "lavaggi del cervello" finalizzati a un ravvedimento dimostrabile solo rendendosi carnefici o delatori dei propri compagni di prigionia. Si trattava soprattutto di partigiani, ex combattenti della guerra di Spagna, dirigenti e militanti del partito comunista jugoslavo rimasti fedeli a Stalin dopo lo "strappo" titino da Mosca del giugno 1948, "traditori" che avendo aderito al Cominform (l’Internazionale dei Paesi filosovietici) dovevano essere "rieducati" in un gulag per capire dove sorgesse davvero il "Sol dell’avvenir": non all’ombra del Cremlino, cioè, ma sotto la guida del maresciallo Tito. Goli Otok, l’Isola Calva in cui la gelida bora e il sole cocente hanno pelato nei secoli le chiome di un colle svelandone tutta la sua aridità, è stato un lager tra i più terribili della storia, dove la ferocia degli aguzzini è stata uguale a quella nazista. Quattordici baracche, brande nella sporcizia, dodici ore di lavoro al giorno nella cava di pietra o in officina, quattro fagioli quattro dentro la gamella, acqua poca o niente, umilizioni tante, condite da sputi, calci, sevizie e la condanna finale al disprezzo collettivo. E ancora bastonate a chi si lamentasse, botte fino a morirne. Tra i prigionieri che sopravvissero a quell’inferno senza piegarsi mai, un antifascista fiumano, Aldo Juretich, uno dei pochi a voler raccontare, anni dopo, l’agghiacciante esperienza nel gulag durata 22 mesi. «Perché, in casi come questi, il testimone vive un conflitto interiore lancinante, tra il dovere di far conoscere agli altri quella orribile realtà e la consapevolezza che ciò è destinato a trasformarsi in incubi spaventosi come quelli che hanno tormentato il sonno di Aldo per quarant’anni» spiega Renato Sarti, il drammaturgo triestino fondatore del Teatro della Cooperativa di Milano che ha raccolto la storia dell’ex deportato traducendola in un testo teatrale (vedi box). «Sapevo che viveva a Monza e lo cercai dopo aver letto Goli Otok (il libro del giornalista istriano Giacomo Scotti che descrive la barbarie del gulag titino, ndr) nel quale si parlava di lui: raccontava cose che mi sconvolsero e che quasi nessuno sapeva» ricorda Sarti. E così i due, dopo essersi incontrati, divennero molto amici. «No, di più – precisa l’autore della piéce –, perché Aldo è stato per me come un padre adottivo, mi ha insegnato il rigore etico, il vero valore della libertà e della giustizia, la fede nelle capacità umane e persino l’ironia che pesca nel profondo dell’animo: era (è morto nel 2011, ndr) un uomo di grande cultura, amava Dante, conosceva a memoria passi della Divina Commedia e dell’Eneide, citava il Cyrano di Rostand, cantava brani della Traviata... Ma aveva come un’ossessione, temeva cioè che la sua sofferenza a Goli Otok fosse stata inutile e che altri, in futuro, avrebbero potuto vivere una simile condizione di disumanità». È proprio per questo che Sarti ha deciso di scrivere un’opera teatrale sull’"isola dei dannati" tramutandola però, nel sottotitolo, in un’"isola della libertà": «Perché Juretich è l’emblema di una speranza contro la ferocia di cui è capace l’uomo, anche se, beninteso, con questo testo non vogliamo santificarlo...». Nemmeno di fronte alle macerie del comunismo la dignità di Juretich è stata spezzata. Riassumeva così la sua grande delusione per un’ideologia travolta dalla Storia: «Abbiamo vinto una volta sola nella nostra vita, quando ci hanno messo in galera». Anche il regista e attore Elio De Capitani, direttore artistico dell’Elfo-Puccini di Milano, si è gettato a capofitto nel progetto del quale cura, insieme con Sarti, produzione, regia e interpretazione. Sarà lui, infatti, a dare voce e corpo sul palcoscenico alle sofferenze e al grido di libertà di Aldo: «Un’adesione totale, la mia – commenta – perché sin dall’inizio di questa avventura teatrale, magicamente, non ho mai guardato il copione, è accaduto tutto senza diaframmi come fosse un miracolo della parola: merito di Aldo che ha saputo raccontarsi facendo trasparire l’anima, ma c’è qualcosa di misterioso in questo, come un parallelismo con il "Verbo che si è fatto carne"...». Non è, insomma, teatro e basta. «Stavolta non indosso l’anima del personaggio, mi sembra di averlo davanti mentre mi sollecita stravolgimenti interiori: mi emozionano, mi sollevano la sua grandiosa dignità – conclude De Capitani – e le cinque o sei note della musica di Carlo Boccadoro che distilla la storia, che mi entrano dentro dandomi l’energia necessaria a sostenere la "parte"». Ma la chiave di tutto sta, forse, nel finale struggente, quando Aldo, parlando con un ex compagno di prigionia gli dice, guadando fuori dalla finestra: «Ecco, vedi, ci hanno tolto tutto, ma quel meraviglioso tramonto nessuno ce lo potrà levare mai».








.jpg?dt=1713510840835&Width=300)
.jpg?dt=1713510840835&width=677)


.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)