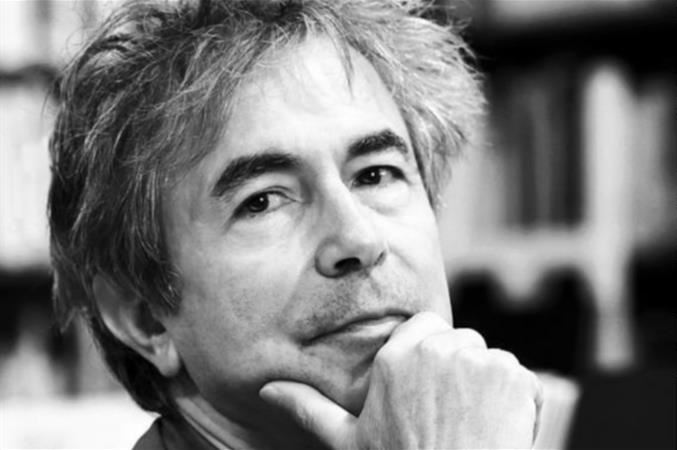L’oratorio aveva una squadra di calcio iscritta al torneo di terza categoria; tutto il paese sognava di vincere il campionato per passare nella categoria superiore. Avvenne solo una volta di passare in seconda categoria e tutto il paese si riversò in strada a far festa come quando l’Italia vinse il campionato del mondo. Quella sera il don, tra un brindisi e l’altro, dichiarò che si puntava almeno alla serie B, il sindaco si trovò d’accordo e promise di far costruire le docce nuove negli spogliatoi. Il don, che ufficialmente non era il mister, si comportava come fanno certi presidenti di calcio: scelgono i giocatori, suggeriscono chi deve giocare, indicano il modulo tattico. Il credo tattico di don Giancarlo era: non si gioca per divertirsi ma per vincere, bisogna essere miti e caritatevoli, ma non quando c’è il derby contro il Busto Garolfo. Aveva un suo decalogo comportamentale: chi bestemmiava non veniva convocato per la partita della domenica, e chi veniva beccato al cinema a baciarsi con una ragazza saltava almeno due partite. Come tutti i presidenti, il don aveva i suoi pupilli. Un anno fece giocare un centravanti solo perché sapeva a memoria tutti i vizi capitali e le virtù teologali. Solo che non segnava nemmeno a porta vuota. Per tre anni di fila la squadra è arrivata in fondo alla classifica perché il don si era fissato di far giocare Marberti.
Marberti da piccolino aveva avuto la poliomielite, e come conseguenza si ritrovava una specie di protesi contenitiva per la gamba, fatta di quattro ferri. Come tutti i bambini, amava il calcio e, fin da bambino, il suo sogno era fare il portiere. Il don lo fece schierare come titolare nel campionato 1964-65, perché, come spiegò negli spogliatoi, «a calcio devono poter giocare tutti», perché bisognava «credere nei miracoli» e, soprattutto, perché «Marberti, da fermo, è dotato di un colpo di reni eccezionale». In quella stagione calcistica non avvennero miracoli, e a furia di colpi di reni (perché gli avversari, maligni, tiravano tutti all’incrocio dei pali) al povero Marberti venne il mal di schiena. Il mio oratorio aveva anche un teatro, dove la domenica pomeriggio don Giancarlo proiettava un film: I dieci comandamenti, Ben Hur o Quo vadis; il massimo della trasgressione era un western. Una volta all’anno, don Giancarlo convocava nel suo ufficio tre o quattro bambini e gli faceva leggere dei copioni teatrali. Io mi ricordo che ridevamo a crepapelle senza riuscire a fermarci, proprio come quando succedeva durante la messa; allora don Giancarlo doveva darci qualche scappellotto per farci smettere, proprio come faceva in chiesa. Dopo una settimana passata a ridere e a prendere scappellotti, il don ci portava in teatro e ci faceva salire sul palco, dove recitavamo a memoria quello che avevamo letto. A recitare assieme a noi c’erano anche diversi adulti, uomini e donne, che tanto per cambiare ridevano anche loro a crepapelle, e il don doveva guardarli negli occhi per farli smettere. Dopo due giorni di prove, la domenica sera si faceva lo spettacolo a cui assisteva tutto il paese, con il sindaco e il parroco seduti in prima fila. In ogni recita c’era sempre un bambino o un adulto che si fermava in mezzo al palco e diventava tutto rosso. Allora il don entrava in scena, accolto da un applauso, diceva qualcosa all’orecchio di quello che non ricordava la parte, e questi ripartiva sollevato e baldanzoso.




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)


.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)