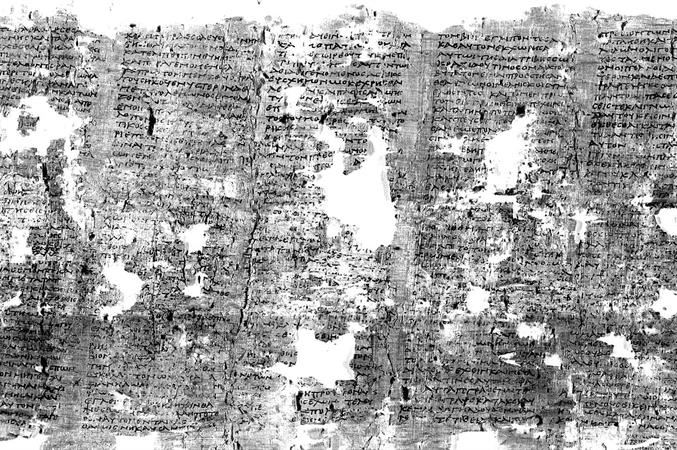Gianmarco Pozzecco, 48 anni, oggi allenatore della Dinamo Sassari - Ansa
Chi ama e si intende del basket italiano, riconoscerà che la lunga estate calda della pallacanestro azzurra è finita ad Atene, Olimpiadi del 2004. E il massimo giocoliere di quella Nazionale di coach Charlie Recalcati, il quintetto che ci regalò il primo e unico argento olimpico, era lui: Gianmarco Pozzecco, per brevità artistica chiamato il Poz. Il pazzo Poz, triestino classe 1972, che da quando 19enne si presentò sul palcoscenico della Serie A (Rex Udine) fino all’ultima sirena suonata nel palazzetto di Capo d’Orlando, nel 2010 (Upea, serie C) non ha mai smesso di essere «un pagliaccio, con un obiettivo dichiarato: diventare il più ammirato del circo». Parola del clown Poz che anche in copertina alla sua autobiografia, Clamoroso (Mondadori, pagine 271, euro 18), scritta con la complicità di Filippo Venturi (baskettaro e autore di chicche gastrosofiche come Il tortellino muore nel brodo) mostra un volto beffardo alla Robin Williams, prima di truccarsi da Patch Adams. Già, il medico–clown di Washington che, vestito da pagliaccio, donava il sorriso ai bambini ricoverati nei reparti dell’oncologia pediatrica. «L’humour è l’antidoto per tutti i mali. Credo che il divertimento sia importante quanto l’amore», scrive Patch Adams, e quei due ingredienti, humour e divertimento, sono i fondamentali del nostro artista della palla a spicchi, e anche gli accessori che il Poz non ha mai tolto dalla sua sacca umana e sportiva. Uno che dal basso dei suoi 180 centimetri, un “nano” per il basket a tutte le latitudini, ha «vissuto per buttare la palla in un canestro» e sfidare i giganti. Una piccola rockstar in campo e fuori il Poz, capace di cambiare ritmo alla partita, in virtù di quella miscela di genio e sregolatezza che lo contraddistingue da quando era un ragazzino del campionato Propaganda: «Da bambino una notte mi buttai dalla finestra e poi continuai a dormire».
Uno così, era destinato a giocarsela alla pari, anche sul terreno impervio dell’aurea follia con “Sugar Ray” Michael Richardson, «un vero numero uno» con il quale condivise la stagione di Livorno. Per ogni annata, fin dagli inizi all’Inter 1904 di Trieste, con il suo primo maestro Tullio Micol, Pozzecco ha una storia intrigante da raccontare che si lega sempre agli amici di una vita. Ed è solo per dire «grazie» di esserci sempre stati che in fondo il Poz ha messo nero su bianco i suoi ricordi da eterno Peter Pan. Da coach quale è diventato (ora allena a Sassari) schiera tutti sullo stesso parquet per ricambiargli di cuore il “cinque”. Un abbraccio ideale che va da Ricky Metal, che «dai 10 ai 17 anni non c’è stata una volta che sia uscito dal condominio di via Capodistria senza passare a chiamarlo», fino al saluto triste al suo amato “Joker” Chicco Ravaglia, volato via per sempre – in un incidente stradale – alla vigilia del Natale del 1999. Aveva 23 anni Ravaglia, playmaker di Cantù che con il Poz aveva condiviso la parentesi, per lui unica e irripetibile della Pallacanestro Varese. La squadra che per la prima volta Pozzecco aveva potuto «prendere per mano» – grazie a coach Marco Calamai – e trascinare, con il fraterno figlio d’arte Andrea Meneghin, a quel suo unico scudetto vinto in carriera, stagione 1998– ’99. «Se fossi stato più professionale e meno farfallone avrei potuto fare molto di meglio», è il bilancio del 48enne nevroromantico, perdutamente innamorato della pallacanestro – «che ho respirato sempre a pieni polmoni» – , ma anche delle zingarate e delle folli sbornie postpartita di chi confessa: «Non c’è stata una domenica sera in cui io non abbia fatto l’alba con un drink in mano».
Senza quelle notti brave, magari avrebbe potuto vincere di più il “mago della transizione” («specialità in cui sono stato il migliore») ma il rimpianto viene stoppato dalla favola del Re per una notte. Quella del 3 agosto 2004, amichevole preolimpica contro gli Stati Uniti. La piccola grande Italia era riuscita nell’impresa impossibile per qualsiasi quintetto terrestre: aveva sconfitto i marziani del Dream Team di mister Larry Brown, fresco vincitore dell’Nba alla guida dei Detroit Pistons. Gli americani, i veri giganti del basket, Tim Duncan, Dwyane Wade, LeBron James, Carmelo Anthony e Allen Iverson, erano atterrati a Colonia con lo stesso spirito virtuoso con cui Keith Jarrett affrontò al pianoforte il leggendario The Köln Concert del ‘75. Per il Dream Team doveva essere una normale esibizione, la sfida, sulla carta impari, tra i fenomeni del jazz cestistico contro dei bravi mandolinari italiani, che però dinanzi ai 14mila spettatori dell’Arena tedesca a un certo punto, trascinati dal Poz, misero in scena il più inedito dei melodrammi. All’alba vincerò!, alla fine coprì l’iniziale «Iu–Es–Sei» che «mentre lo ascoltavamo – ricorda Pozzecco – scommettevamo su quanti ne avremmo presi. Qualcuno buttò lì un meno sessanta... Poi salimmo e la favola cominciò».
La favola del Re per una notte da raccontare ai nipoti, quella di «Galanda che fece 12 punti di fila in faccia a Amar e Stoudemire, Basile che segnò 5 triple consecutive, Marconato che giganteggiò contro Lamar Odom – scrive il Poz – . E verso il finale, l’apoteosi: un certo Gianmarco Pozzecco penetrò, finse lo scarico e segnò subendo il fallo di Iverson, che a occhio e croce doveva essere il suo idolo di sempre. Quindi si inchinò verso il pubblico in delirio ». Il tabellone alla sirena lampeggiava sbalordito, quanto Larry Brown in panchina, Italia– Usa 95–78. «Fino a quel momento la peggiore sconfitta di sempre per un Usa Dream Team». Per il Poz, semplicemente, Clamoroso!