
Lo scrittore Ferdinando Camon - Giorgio Boato
Sono passati cinquant’anni, ma Ferdinando Camon non ha cambiato idea. «Noi abbiamo avuto in Italia una sinistra che sapeva tutto degli operai ma non sapeva niente dei contadini», si legge in A ottant’anni se non muori t’ammazzano (Apogeo, pagine 92, euro 12,00), il pamphlet nel quale lo scrittore padovano traccia un bilancio personale, e molto amaro, dell’emergenza coronavirus. Contemporaneamente torna in libreria Il quinto stato (Garzanti, pagine 144, euro 12,00), che di Camon rappresentò l’esordio nel 1970. Cinquant’anni fa, appunto, mezzo secolo esatto durante il quale la civiltà contadina ha definitivamente ceduto il passo alla società borghese. La quale, a sua volta, si trova adesso sull’orlo di una trasformazione del tutto imprevedibile. «Dopo la pandemia il mondo non sarà più lo stesso, questo lo abbiamo capito – commenta lo scrittore, che compirà 85 anni il prossimo 14 novembre –. Nessuno, però, è in grado di dire che cosa ci aspetta. Di sicuro, quello che è accaduto negli ultimi mesi ha pugnalato al cuore quel che restava della civiltà contadina».
Perché?
Perché ha sancito la fine di un sistema di valori che rimpiango sempre di più. La campagna in cui sono nato e cresciuto era una realtà ancora più povera, ancora più bassa rispetto a quella della fabbrica, ma capace di grande generosità. Quando si faceva una processione, per esempio, era normale che il percorso si allungasse fino alle case in cui c’era un malato. Chi era in difficoltà non si sentiva escluso: fosse pure uno sconosciuto, gli si trovava un posto per dormire sotto il portico, gli si rimediava qualcosa da mangiare. Allo stesso modo, non era raro che dal pulpito il parroco predicasse contro l’esosità del padrone, che teneva per sé la maggior parte dei prodotti coltivati dai contadini. Inoltre, era una civiltà che riconosceva l’autorità degli anziani. I vecchi sedevano a capotavola, a loro ci si rivolgeva con il vu.
Con il voi, intende.
No, il vu ha un’altra intonazione, ancora più rispettosa. Sa che cosa trovo più strano, a ripensarci?
Che cosa?
Che l’anziano era il primo a essere servito. Gli si chiedeva che cosa desiderasse, si cercava di soddisfare ogni sua richiesta. Ora come ora ci si comporta in modo diametralmente opposto: sono i più giovani a dover essere accontentati, sono loro ad avere la precedenza, anche quando è questione di vita o di morte.
Non è un giudizio troppo severo?
Guardi quello che è accaduto nel periodo di maggior diffusione del contagio. Negli ospedali medici e infermieri hanno fatto più del massimo, con punte di eroismo che rendono incontestabile la loro abnegazione. Ma se si studiano le linee-guida dei vari Paesi, come ho cercato di fare io, ci si rende conto che la mentalità prevalente è un’altra. Il caso più chiaro è quello della Francia, che distingue apertamente tra morti “ammissibili” e “inammissibili”. Queste ultime sono quelle delle persone più giovani e prive di patologie, mentre l’ammissibilità, se così vogliamo chiamarla, aumenta inesorabilmente con l’età e con la presenza di altre malattie. Ecco, una distinzione del genere sarebbe stata inconcepibile per il mondo contadino.
Dove la morte era accettata?
Al contrario, era inaccettabile, sempre e comunque. La si subiva perché faceva parte dell’esperienza comune ed era proprio questa dimensione collettiva a dare conforto, anche sul piano religioso. Non si moriva da soli e nessuno era lasciato solo a morire. Anche un vecchio pieno di acciacchi, come l’Anchise dell’Eneide, poteva contare sul fatto che il figlio se lo sarebbe preso in spalla, magari mentre teneva un nipotino per mano. La pandemia, invece, ci ha privato dell’esperienza fondamentale, che è quella della morte del padre alla presenza del figlio.
Eppure lei stesso è stato spesso critico nei confronti di quel mondo.
Sì, ma solo per denunciarne le debolezze, che in fondo si riducono a un unico elemento.
Quale?
In campagna non circolava denaro. È questa l’origine della sconfitta di una civiltà ricca di valori morali, ma povera di risorse economiche, delle quali la società borghese disponeva abbondantemente. Vede, nel ’70 Il quinto stato uscì con una prefazione di Pier Paolo Pasolini. Molto lusinghiera, ma che a mio avviso non coglieva il punto. In sostanza, Pasolini mi accusava di tradimento: anziché immaginare una permanenza della società contadina, sosteneva, io avrei auspicato una sua evoluzione verso un “destino neocapitalistico”. Ma già allora i contadini si erano stancati della povertà. Sognavano l’acqua corrente, il riscaldamento, non ne potevano più di avere le mani spaccate dai geloni. Per loro diventare borghesi significava essenzialmente emanciparsi dal bisogno.
Qual era, secondo lei, l’essenza della civiltà contadina?
Il continuo contatto fra il mondo di qua e il mondo di là. Tra i vivi e i morti, tra il visibile e l’invisibile rimaneva sempre aperto un varco attraverso il quale potevano passare le figure del sacro: angeli, demoni, fantasmi, lo stesso Padreterno. Ne derivava una religiosità in parte ancora impastata di paganesimo, ma profondamente cattolica. La mia infanzia è stata popolata da questi racconti meravigliosi, di cui spesso circolava più di una versione. Non che una fosse vera e l’altra falsa. Erano tutte vere, piuttosto, anche se in ambienti e in momenti diversi.
Sono queste storie che hanno fatto di lei uno scrittore?
Queste storie e la seduzione della lingua italiana, che avevo scoperto a scuola, lasciandomi conquistare dal suono, dal timbro, dal ritmo delle parole. Se ho studiato, e se sono diventato scrittore, è stato grazie alla maestra e al prete del mio paese.



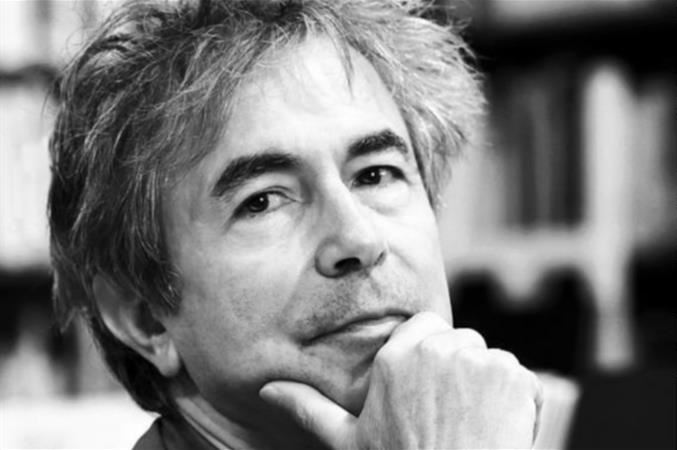








.jpg?dt=1713547429965&Width=300)
.jpg?dt=1713547429965&width=677)



