
«Uccisero i miei compagni senza alcuna pietà, perché all’epoca eravamo giovani, famosi e la nostra musica rappresentava una speranza di pace e di riconciliazione per il nostro Paese». Nel 1975 Stephen Travers era il bassista più famoso di tutta l’Irlanda e faceva parte della Miami Showband, il gruppo rock più amato di tutta l’isola, un quintetto di musicisti straordinari nel quale spiccava la stella del cantante Fran O’Toole. Ogni sera migliaia di persone si assiepavano nei locali per assistere ai loro concerti, e grazie alle loro canzoni riuscivano a evadere dalla violenza quotidiana del conflitto che stava insanguinando l’Irlanda del Nord. Almeno un paio di volte a settimana, la Miami Showband attraversava il confine che divideva in due il Paese "riunificandolo" idealmente con i suoi affollatissimi spettacoli. Fino a quella notte maledetta del 31 luglio 1975.
Di ritorno da un concerto a Banbridge, nei pressi del confine con la Repubblica d’Irlanda, e diretti a Dublino, i musicisti furono fermati a un posto di blocco in aperta campagna. «Pensavamo che fosse un normale controllo di routine, d’altra parte in quegli anni ci accadeva spesso di imbatterci nei militari», ci spiega Travers. «Non appena ci riconoscevano ci stringevano la mano lasciandoci passare subito, magari dicendo che apprezzavano i nostri dischi». Ma quella sera furono fermati da uomini del gruppo paramilitare lealista Ulster Volunteer Force e della controversa milizia britannica denominata Ulster Defence Regiment. Li avevano fatti scendere dal furgone e allineare poco più avanti, sul bordo di un fossato. Poi due di loro avevano iniziato a rovistare dentro al veicolo. All’improvviso una terribile esplosione ridusse il furgone in mille pezzi, e uccise sul colpo i due paramilitari. Oggi Stephen Travers vive a Cork, nell’Irlanda meridionale, dove l’abbiamo incontrato per questa intervista, e a oltre quarant’anni di distanza da quella notte rivede ancora quegli istanti al rallentatore.
«La potenza dell’esplosione ci gettò nel campo oltre il fossato, feriti ma ancora vivi. Poi gli altri membri del posto di blocco iniziarono a sparare all’impazzata contro di noi. Io fui colpito a un’anca e rimasi a terra, sanguinante. Finsi di essere morto, per questo sono riuscito a salvarmi. I miei compagni furono invece massacrati senza pietà». Per l’Irlanda, che pure in quegli anni era tristemente abituata al susseguirsi di gravi fatti di cronaca, fu uno choc terribile, aggravato dalla dinamica dell’attentato, che emerse qualche giorno più tardi. Si capì che non volevano semplicemente spegnere per sempre il messaggio di pace di un gruppo di musicisti, ma avevano ordito un piano diabolico per sigillare definitivamente il confine che divideva il Paese. «Le inchieste – racconta Travers – hanno dimostrato inequivocabilmente che i due parami-litari saltati in aria stavano piazzando una bomba sotto al nostro furgone. L’ordigno sarebbe dovuto esplodere circa un’ora più tardi, uccidendoci mentre eravamo in viaggio. Volevano far credere che fossimo corrieri dell’Ira, che i nostri concerti erano solo una copertura e che in realtà stavamo trasportando armi ed esplosivi da una parte all’altra del confine. Per fortuna almeno il piano fallì altrimenti, oltre a ucciderci, avrebbero anche infangato la nostra memoria per sempre».
Il terribile movente della strage sarebbe stato scoperto tanti anni dopo. Far passare per terroristi i più famosi e rispettati pendolari che attraversavano regolarmente quel confine doveva servire a mettere pressione sul governo irlandese, costringendolo a chiudere la frontiera. «Adesso – prosegue l’ex bassista – sappiamo per certo che quella strage non fu né casuale, né opera soltanto dei paramilitari lealisti, ma venne pianificata dalla squadra politica della polizia e dai servizi segreti britannici MI5». Per questo, Travers continua a lottare non solo per conservare la memoria dei suoi compagni uccisi ma anche per ottenere giustizia, e insieme ai familiari delle vittime ha intentato un’azione legale nei confronti del Ministero della difesa britannico e della polizia dell’Irlanda del Nord. Il suo librotestimonianza The Miami Showband Massacre. A Survivor’s Search for the Truth, da poco ristampato in edizione aggiornata, ha spinto nelle scorse settimane l’Alta corte di Belfast a chiedere la declassificazione di documenti riservati in vista di una riapertura del caso.
Perché ha atteso tanto tempo per confrontarsi con quello che vi è accaduto?
«All’inizio ho cercato di mettermi tutto alle spalle, di riavere indietro la mia vita. Ho vissuto per tanti anni a Londra, dove nessuno sapeva chi ero, cercando di dimenticare. Nel 2005, in occasione del trentesimo anniversario, ci ritrovammo con i familiari e capimmo che il Paese aveva quasi rimosso quella storia, che è ancora del tutto ignota in Inghilterra. C’era dunque la necessità di lottare contro l’oblio. Inoltre, già durante il processo di pace avevo maturato l’idea che dietro la strage ci fosse qualcosa di terribile. Col tempo è emerso che fu una delle vicende che videro la collusione tra i paramilitari lealisti e le forze di sicurezza britanniche. Nel frattempo c’è chi è finito in carcere per la strage e non è mia intenzione arrivare a nuove condanne. Non voglio alcuna vendetta, vorrei soltanto che un sistema fosse riconosciuto responsabile della morte di tanti innocenti».
Lei ha cercato di incontrare i due uomini che sono stati condannati per la strage, e che anni fa sono tornati liberi. Qual è per lei il significato della parola "perdono"?
«Se quegli uomini fossero oggi seduti qui con noi, non avrei alcun problema a prendere un caffè con loro. Non provo alcun rancore nei loro confronti, credo che tutte le persone coinvolte in quel massacro, le vittime, i loro familiari e persino chi ha compiuto la strage, siano vittime, poiché tutti abbiamo avuto la vita segnata da quello che è accaduto quella notte. Nel frattempo uno di loro è morto, a quanto sappiamo senza aver espresso alcun rimorso, ma credo che nessuna persona sana di mente potrebbe affermare di essere contento di ciò che è accaduto quella notte».
Nel centro di Dublino c’è un monumento che ricorda la strage della Miami Showband, invece nel tratto di strada dov’è avvenuta la strage non c’è né un cippo, né una targa commemorativa. Perché?
«Perché quella è una zona ancora profondamente lealista e quando le persone passando di là lasciano dei fiori, dei pensieri, tutto viene portato via nel giro di poche ore. La gente della zona vuole rimuovere l’orrore che è accaduto lì, e che è stato perpetrato in loro nome. Forse col tempo sarà possibile mettere qualcosa che ricordi la strage, ma il rischio di atti vandalici rimane ancora alto».
Eppure l’anno prossimo saranno vent’anni dall’accordo di pace in Irlanda del Nord.
«È triste, ma purtroppo c’è ancora tanto odio, lo stesso che c’era durante il conflitto, anche se non si manifesta più con atti violenti. Un odio che io ho visto con i miei occhi, quella notte. Ripensando a quegli uomini che continuavano a sparare sui cadaveri dei miei amici, accanendosi sui loro corpi, penso che un odio tale possa essere sconfitto solo con l’educazione. Anche per questo ho deciso di impegnarmi per diffondere la consapevolezza e la memoria di quella strage. E credo che il giorno in cui sarà possibile collocare una targa o un monumento commemorativo sul luogo dove fu stroncato il sogno della Miami Showband sarà un segnale che finalmente quest’odio è finito».



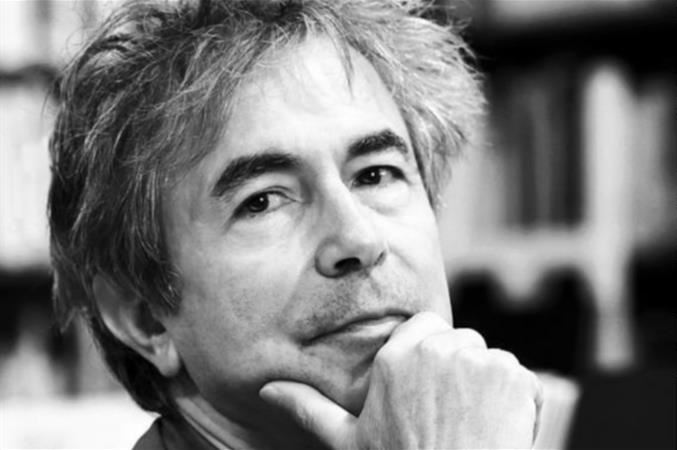




.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)