
Carlo Ossola - archivio
Codice dantesco, articolo unico: «Se uno esce dalla Commediacom’era quando vi è entrato, vuol dire che non l’ha letta». A fissare la regola è uno dei maggiori critici letterari europei, Carlo Ossola, nel saggio introduttivo all’edizione dalla Divina Commediada lui allestita per Marsilio (pagine XCII+1.092, euro 45,00). Il volume esce a ridosso della pubblicazione in Francia della nuova versione del poema nella “Pléiade” di Gallimard: la traduzione è quella di Jacqueline Risset, la grande italianista morta nel 2014, il commento è di nuovo curato da Ossola in collaborazione con Luca Fiorentini, Ilaria Gallinaro e Pasquale Porro, che ritroviamo in sua compagnia nel robusto tomo italiano. Rispetto al gemello transalpino, il volume nostrano rivendica una maggiore ampiezza dell’apparato di note, che resta comunque al servizio di un lettore non necessariamente specialista, ma interessato uscire dalla Commedia diverso da come vi era entrato. Più che di erudizione (la quale pure non fa difetto), è questione di esperienza, condizione che Ossola eleva a principale criterio interpretativo facendo leva sugli indizi, di per sé numerosissimi, presenti all’interno del testo dantesco. Non è irrilevante, da questo punto di vista, che il “nuovissimo commento” sia impresa collettiva, alla quale Ossola sovrintende preoccupandosi di esaltare le competenze specifiche di ciascuno degli altri studiosi che gli si affiancano: Fiorentini conosce bene il modo in cui la Commedia fu recepita dai contemporanei di Dante e dalla generazione immediatamente successiva, nella quale spicca la figura di Giovanni Boccaccio; Gallinaro sa come mettere a frutto in ambito letterario la sua formazione musicale; Porro è un’autorità nel campo della filosofia medievale, e in particolare del pensiero di san Tommaso d’Aquino. Quanto a Ossola, fino allo scorso anno professore al Collège de France e oggi collaboratore assiduo di Avvenire, risulta abbastanza difficile delimitare il suo settore di specializzazione. La definizione stessa della cattedra di cui è stato titolare, Letteratura moderne dell’Europa neolatina, dischiude un ventaglio amplissimo di possibilità, del quale dà subito un’idea la citazione scelta come epigrafe al già ricordato saggio d’apertura, intitolato Il poema degli universali. È u- na manciata di versi dello spagnolo Pedro Salinas, nei quali l’apertura al futuro è così insistita e fiduciosa da costituirsi in metodo. Istintivo, d’accordo, ma proprio per questo indiscutibile. Per Ossola Dante è il poeta dell’esperienza, abbiamo detto, ed è di conseguenza il poeta del futuro, perché ogni volta che ci avviciniamo alla Commedia non siamo solo sospinti da quanti prima di noi hanno accettato di correre la stessa avventura. A partire dall’autore, che non per niente, come ha insegnato Gianfranco Contini, non è solamente autore, ma «personaggio- poeta», testimone di sé e portavoce di ognuno (giustamente Ossola individua in questa umanità esemplare la nozione portante del dantismo di Ezra Pound). Nella Commedia i rimandi e addirittura gli ammiccamenti al contesto dell’epoca abbondano, eppure non si sfugge all’impressione che il fuoco prospettico stia fuori da un tempo specifico. Nello sguardo di Dio, senza dubbio, ma anche in quello delle generazioni che negli ultimi sette secoli si sono misurate con il «poema sacro» e con esso si si misureranno d’ora in poi. Si tratta di una prospettiva rovesciata, che Dante è abilissimo a dissimulare, adottando uno stratagemma che sembra anticipare quello fissato da Edgar Allan Poe nella Lettera rubata: collocare un oggetto in evidenza equivale a renderlo invisibile, più ancora che a nasconderlo. Riordinando gli indizi di interpreti eccellenti come Mandel’štam e Borges, Ossola individua il dispositivo che, una volta riconosciuto, permette di ripercorrere il poema «da la cima»: come resoconto dettato dal pellegrino tornato dal Paradiso e non come lenta risalita dall’abisso dell’Inferno. Non fosse stato in cielo, Dante non potrebbe raccontare che cosa c’è sottoterra. La constatazione è di una semplicità disarmante, ma proprio la semplicità è il principio ermeneutico che, insieme con il rimando agli universali, sostiene il commento patrocinato da Ossola. In un caso come nell’altro, i termini usati suonano familiari da un lato e dall’altro poggiano su una stratificazione di significati che risale alla concordante discordia della teologia medievale. Da ultimo, infatti, il semplice è nel divino ciò che l’universale nell’umano, ossia l’irriducibile e l’imparagonabile. Le metafore di cui Dante fa uso così abbondante nel poema sono la conferma di questo tentativo continuo di accedere all’essenziale, che coincide con l’ineffabile di cui dà conto il canto finale del Paradiso. Può bastare una sola parola a denunciare l’enormità e la necessità del cimento. Tra i vari esempi suggeriti da Ossola, resta impressa con particolare vivacità l’analisi del verbo “trapelare” che, nel canto XXX del Purgatorio, descrive lo sciogliersi della neve fra le travi del tetto. Un evento minimo, semplicissimo, che subito viene investito di una forza cosmica, universale. Dante sta qui, nell’invisibile punto di contatto tra l’infinitesimo e l’incommensurabile. E aspetta ancora i suoi lettori di domani. Nell’attesa, oggi quei lettori potremmo essere noi.



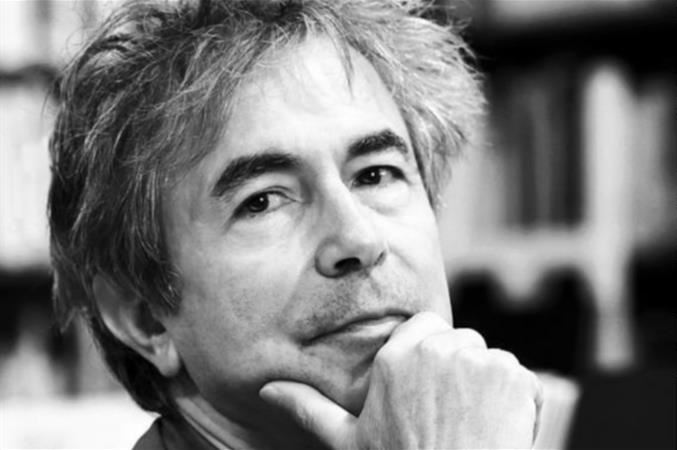




.jpg?dt=1713458074885&Width=300)
.jpg?dt=1713458074885&width=677)




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)