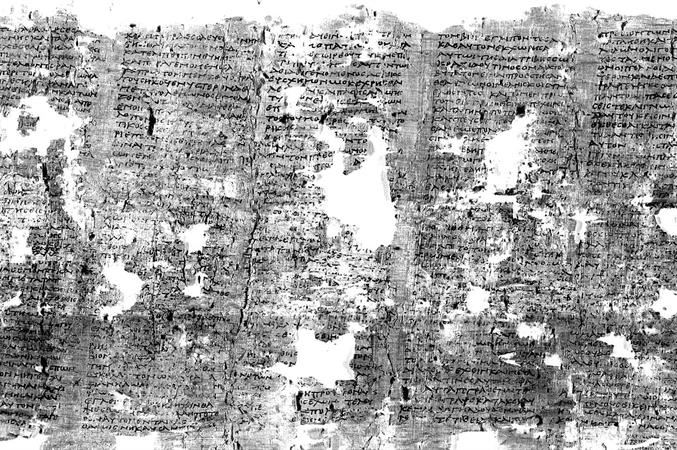Felice Gimondi in una foto del 2016 (Ansa)
Quando si è giovani il traguardo dei settanta anni sembra lontanissimo, come la cima dello Stelvio visto dal fondo valle. Poi, improvvisamente, ti ritrovi in vetta, come al termine di una tappa del Giro d’Italia. Stanco ma felice. Felice come Gimondi. E non è solo un gioco di parole con il nome dell’ex campione bergamasco.
«Mi sento un privilegiato - afferma con il tono serio -. Sono un uomo corretto che ha avuto la fortuna di scegliere il suo lavoro». Felice ma, anche, frastornato per il gran baccano che il suo compleanno ha creato. Gli amici hanno organizzato una grande festa con i rivali di un tempo che, stasera, andrà addirittura in diretta televisiva. Poi, c’è il Giro di Lombardia: domani, il giorno del suo compleanno, partirà da Bergamo per rendergli omaggio. Un privilegio riservato a pochi. Ai “grandi”.
«Ero abituato a festeggiare i compleanni in famiglia, con mia moglie, le nostre due figlie e il nipotino». L’età è da pensionato, ma Gimondi in pensione non ci vuole proprio andare. «Poi cosa faccio tutto il giorno?». Allora, ogni mattina si presenta nell’agenzia di assicurazioni che porta il suo nome. Nell’ufficio tutto parla della sua carriera: foto, trofei, libri, cimeli di corse. «A casa, invece, non c’è niente. Nessuno, entrando, deve capire che ho fatto il corridore. I ricordi li ho raccolti nella torre. Uno spazio che è solo mio».
E fra i ricordi aleggia, silenzioso ma ingombrante, l’alone di Eddy Merckx, il “cannibale”. L’atleta che gli ha tolto sonno e gloria. L’uomo al quale ha legato il suo nome in un binomio entrato nell’immaginario collettivo. Gimondi è stato l’ombra di Merckx, ma non è vissuto alla sua ombra. Il belga scatenava il diavolo a quattro, poi si voltava e trovava sempre la solita sagoma incollata alle sue spalle. Dietro il vuoto. Felice restava lì, con la mascella serrata per resistere alla fatica. «Tanto che, a volte, restava indolenzita anche dopo essere sceso di bici». Si è trovato di fronte Merckx, il corridore che ha vinto più di tutti, ma non ha fatto la figura dell’eterno secondo: Gimondi ha vinto 143 gare, le più belle e difficili, ed è arrivato 56 volte secondo, «diciannove solo nel ’69», precisa con un po’ di disappunto. Merckx diventa un incubo che lo perseguita anche in casa. Un giorno si ritrova la figlia con addosso una t-shirt con la foto del rivale. «L’indossava, davanti alla tv, anche il giorno che vinsi il Mondiale».
La rivalità è forte, ma sempre sui binari della correttezza. «In bici ci scannavamo ma alla sera guardavamo la partita insieme, con un boccale di birra in mano. Però, ho impiegato due anni per accettare il fatto che era più forte di me. Eddy mi aveva battuto in una cronometro al Giro di Catalogna del ’68. Fino a quel giorno, nelle crono, avevo sempre vinto io. Ho trascorso la notte a interrogarmi, a ripassare ogni metro della gara. Eppure ero andato forte. La risposta l’ho trovata solo dopo due tormentatissime stagioni».
Ma non si rassegna all’evidenza. Riconnette grinta e gambe e accetta la sfida. «Ho dovuto cambiare il mio modo di correre. Eddy mi ha tolto l’istinto, quello che mi aveva fatto vincere molto all’inizio della carriera. La prima cosa era non “prenderle”, quindi restavo ad aspettare che partisse lui. Poi, anche se sapevo che ero battuto facevo la mia parte per andare all’arrivo. Come al Mondiale di Mendrisio: ho fatto l’ultima salita in testa, poi, mi ha superato in volata».
Merckx è il Cannibale, Gimondi la formichina che cerca di raccogliere le briciole. Ma una formica che può mettere a dieta l’insaziabile. Come nel Mondiale di Barcellona. «L’unica volta in cui sono venuto meno all’impegno di tirare. Eravamo in fuga in quattro. A cinque chilometri dal traguardo mi sono incollato alla ruota di Merckx e ho vinto la volata». Inevitabile chiedersi cosa sarebbe stato Felice senza Eddy. «Sicuramente avrei vinto di più. Ma, oggi, sono molto più contento che sia andata così. Mi sento più gratificato. Poi, sarei diventato così popolare se non ci fosse stato lui?».
La rivalità ha radici lontane, quando i due erano ancora dilettanti: in una corsa in Belgio l’azzurro Gimondi si ritrova in fuga con Merckx, poi lo stacca in salita e vince. Ma il futuro “Cannibale” ha solo 18 anni e ancora i denti da latte. Gimondi è un predestinato. Inizia a correre nel ’60,e nel ’64 è già sul gradino più alto del podio al Tour de l’Avenir. L’anno dopo, passa professionista e arriva a Parigi in maglia gialla. Nei primi tre anni vince quasi tutto. Inevitabile l’accostamento con Coppi, in un Paese ancora orfano del Campionissimo. Gimondi ha le spalle tanto larghe da accollarsi la pesante eredità. Poi, arriva il belga ad alleggerirlo.
La rivalità è la linfa dello sport. Gimondi è l’alter ego di Merckx, ma in Italia deve confrontarsi con la classe e la brillantezza di Motta e l’eleganza e l’eloquio di Adorni. Un inferno per lui “musone” e di poche parole, un “regolarista” anche nella vita privata. «Non ho mai amato la confusione. Avevo bisogno dei miei spazi, di stare in casa, da solo». Nel viaggio nella memoria affiorano anche momenti dolorosi. «La morte di Tommy Simpson: sul Ventoux eravamo rimasti in quattro o cinque, lui era dietro di me. Poi, non l’ho più visto. Alla sera, mentre stavo facendo i massaggi ho sentito alla radio che era morto. Ho avuto voglia di fare le valigie». Fra i ricordi c’è spazio anche per il rammarico per quello che poteva essere e non è stato. «Al Tour del 1967 avrei potuto fare la doppietta con il Giro, ma una dissenteria sui Pirenei mi ha mandato fuori classifica». Gimondi è sempre rimasto nel ciclismo e ha visto passare intere generazioni di corridori. Con Pantani ha avuto uno stretto rapporto.
«Mi confrontavo con Marco, ma in modo sbagliato. Eravamo di generazioni troppo lontane. Ai miei tempi la radio l’avevano in pochi e la droga non sapevamo cos’era. Quando ho saputo della sua morte sono stato male». L’argomento doping accostato al ciclismo gli fa ritrovare la verve del corridore. «Abbiamo sicuramente le nostre colpe, ma la vicenda è diventata una buffonata. Il ciclismo è l’anello più debole, economicamente parlando. Perché nessuno ha mai fatto controlli a sorpresa prima di una partita del Milan o dell’Inter?». Anche lui era caduto nella rete dell’antidoping. «Alla fine del Giro del ’68, ero terzo a 8’ da Merckx impossibile recuperarli. Perché avrei dovuto prendere qualcosa? Due medici dimostrarono che ero pulito».
Poi c’è stato il trauma di Merckx, trovato positivo al Giro del 1969, affrontato con la consueta umanità. «Dietro all’atleta c’è l’uomo, e dietro all’uomo c’è la famiglia. Ho cercato di consolarlo e quel giorno non indossai la maglia rosa. Ho ancora dubbi su quella vicenda».
Al ciclismo italiano di oggi guarda con distaccato rammarico: «Vive un momento di transizione. Nibali ha dato segnali di temperamento, ma non è ancora un leader. Poi, c’è da vedere Moreno Moser. Con l’arrivo dei corridori da ogni parte del mondo vincere è diventato più difficile. Serve un progetto per il futuro, come hanno fatto gli inglesi». La prima squadra di Gimondi è stata quella dell’oratorio, la Csi Sedrinese, e lì è rimasto fino al passaggio al professionismo, 14 anni nella stessa società. «Sono un tradizionalista. Non mi sono mai messo sul mercato. Nemmeno dopo aver vinto il Tour, nonostante guadagnassi appena un milione e 800mila lire all’anno». E all’oratorio è tornato per dare vita a una squadra per bambini: a Sombreno c’è la Scuola di mountain bike Felice Gimondi, presieduta da don Mansueto Callioni. Non cerca il suo erede, vuole solo regalare le emozioni e il senso di libertà che la bici sa dare.






.jpg?dt=1713897716280&Width=300)
.jpg?dt=1713897716280&width=677)