
Una donna migrante imprigionata in un campo di detenzione in LIbia. Foto d'archivio - Ansa
Unni Wikan, settantasei anni, lunghi capelli biondi, mi apre la porta della sua casa nel centro di Oslo. Li porta sciolti e mentre camminiamo verso il ristorante dove ha prenotato un tavolo per cena, li vedo ondeggiare con lo stesso ritmo delle pieghe della sua gonna plissettata che non arriva a coprire le ginocchia. Ha il passo di una fanciulla, scanzonato, sereno.
Sono a Oslo per incontrare questa antropologa, pressoché sconosciuta in Italia, prima di iniziare a tradurre uno dei suoi libri più ambiziosi, Resonance, Beyond the Words (Risonanze, al di là delle parole) per la collana Fieldwork dell’editore Milieu di Milano. Unni Wikan si è occupata di donne in contesti molto distanti dal proprio, quelle dei quartieri poveri al Cairo, le donne velate in Oman, le giovani musulmane a Bali, le monache in Buthan.
Tutto il lavoro sul campo svolto dalla fine degli anni 60, Wikan lo ha portato a casa, in Scandinavia, in Europa, dove ha lavorato nell’ambito dell’antropologia sociale e giuridica a stretto contatto con giudici e tribunali mettendo a disposizione la propria professionalità e competenza durante casi giudiziari che affrontavano circostanze molto complicate: uno fra tutti il delitto d’onore.
Su questo tema la società scandinava si è lungamente interrogata nei primi anni 2000 dopo il caso di Fadime Sahandal, nata nel Kurdistan turco e cresciuta in Svezia, uccisa dal padre a 27 anni per aver disonorato la propria famiglia scegliendo in modo indipendente l’uomo che voleva amare.
Unni Wikan, chiamata a testimoniare in qualità di esperta nel primo caso di delitto d’onore giunto davanti a una corte svedese durante l’aprile del 2005, ci esorta a prendere coscienza di come questi temi difficili «sono una realtà dell’Europa di oggi, dell’Occidente» e «che non possiamo continuare a chiudere i nostri occhi di fronte a certi crimini con il pretesto che essi avvengono in paesi “meno sviluppati” o presso società patriarcali oltre in nostri confini».
L’antropologia per Wikan deve essere quindi scritta, letta da persone comuni e i suoi contenuti devono essere accessibili perché non sono quelli di una letteratura esotica bensì chiavi fondamentali per poter comprendere i nostri contesti.
Fermamente convinta che lo scopo dell’antropologia, non sia l’accademia, la speculazione intellettuale o la ricerca puramente teorica, bensì raccontare le esperienze con il vocabolario del quotidiano, usando i termini propri dell’esperienza stessa: «se gli antropologi devono aiutare a rendere il mondo migliore, devono essere in grado di comunicare con quel mondo», osserva.
Le donne di cui si occupa Unni Wikan sono donne che si trovano a fare scelte complicate, contrastate, da compiere per vivere la vita a proprio modo, per essere fedeli a se stesse. Donne le cui storie ci fanno confrontare con questioni fondamentali, come il diritto alla vita, alla libertà di espressione e di movimento. Nel lavoro di Unni Wikan si trova l’urgenza alla pluralità delle voci e a praticare l’antropologia come azione nel mondo.
Il giorno successivo mi invita ad andare con lei a visitare la casa in cui ha vissuto per molti anni con il marito, l’antropologo Fredrik Barth, mancato nel 2016. La loro casa è piena di oggetti straordinari raccolti durante una vita di viaggi tra i luoghi di ricerca di lui e di lei. Una luce stupenda invade il salotto, è tardo pomeriggio.
Unni mi racconta che la figura chiave della sua infanzia è stata la nonna: coraggiosa, insegnante di scuola elementare nelle remote isole dell’arcipelago delle Lofoten, che all’inizio del secolo scorso erano luoghi raggiungibili solo con traversate in mare aperto su barche di pescatori. È stata lei, la nonna, a insegnarle l’importanza dell’essere coraggiosi e diretti, del dire e fare ciò che si pensa giusto. Questi insegnamenti non avvenivano attraverso le parole ma con l’esempio: la loro era l’unica casa che accoglieva coloro che all’epoca erano i rappresentanti della società marginalizzata, i nativi Sami.
Alla nonna, Unni dedica uno dei propri libri più controversi Generous Betrayal: Politics of Culture in the New Europe ( Tradimenti generosi: Politiche culturali della nuova Europa) dove muove una serrata accusa al sistema di Welfare dello Stato norvegese, ed esorta il governo a ripensare le sue politiche sull’immigrazione.
Wikan rivendica un modello dove i diritti e le scelte dell’individuo siano più tutelati, dove ai migranti vengano date vere opportunità di lavoro e di integrazione e non solo le agevolazioni e i sussidi che uno stato ricco può permettersi.
Denuncia la mentalità dei nostri modelli democratici che giustificano in nome del concetto di cultura d’origine drammi individuali e crimini come i rapimenti di giovani donne per farle sposare nel paese della famiglia d’origine.
Sostiene che la “cultura” è un concetto, un’astrazione, mentre sono le persone a essere reali. Per queste posizioni è stata accusata di essere reazionaria e anti migranti. Nel 2004 però ha ricevuto il Norwegian Fritt Ord Award, il più importante riconoscimento norvegese per coloro che si sono distinti per essere voci fuori dal coro ed per essere stati capaci di sostenere le proprie opinioni di anche quando queste venivano male interpretate o non ricadevano nell’idea corrente di politicamente corretto, nè in quelle delle autorità e dell’Accademia.



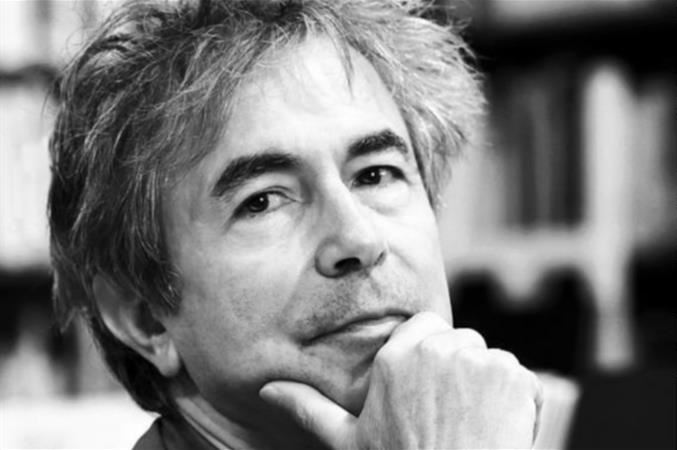




.jpg?dt=1713510840835&Width=300)
.jpg?dt=1713510840835&width=677)







