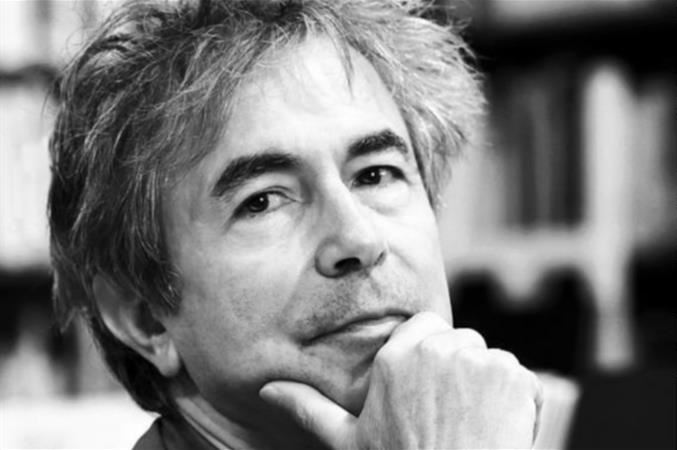Tony Oursler, Red “Love Hurts” Laboratory, 2007. Alluminio, acrilico, schermo lcd, lettore dvd. Particolare - Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York-Hong Kong-Seoul.
Vedere un cammello in una nuvola, un profilo in una montagna, una donna in una radice di mandragora... Si chiama pareidolia ed è la tendenza a riconoscere forme note in conformazioni casuali e irregolari (non solo naturali, spesso ad esempio scatta con fotografie, dove appaiono fantasmi, santi e volti su Marte...). È l’applicazione subcosciente di schemi interpretativi per orientarci nella realtà. La psicologia ne ha fatto uno strumento di indagine con le macchie del test di Rorschach.
Senza questo fraintendimento non avremmo l’arte: linee e colori non potrebbero rapprendersi in rappresentazione. Adolfo Tura ha dedicato alla “storia delle macchie sui muri” l'interessante saggio Breve storia delle macchie sui muri. Veggenza e anti–veggenza in Jean Dubuffet e altro Novecento (Joahn&Levi, pagine 112, euro 13,00), la cui pietra angolare è un ciottolo di diaspro, trovato nel 1925 in una grotta in Sudafrica, nel quale è difficile non riconoscere i lineamenti di un cranio. Eppure i segni sono interamente naturali: fu la sua natura di immagine che convinse un australopiteco milioni di anni a raccoglierla, dando vita così a una catena ininterrotta di gesti analoghi? Per quanto impossibile da provare l’ipotesi non è implausbile: «Fino a quel momento l’universo era stato privo di immagini» scrive Tura: «L’australopiteco si muoveva in un mondo nel quale ogni cosa era concreta. Vide il ciottolo, vi riconobbe una testa e l’omogenea concretezza del mondo attorno a lui s’infranse. Dovremmo considerare la nascita delle immagini un avvenimento esplosivo e indeducibile quanto la nascita della vita».
Dal riconoscimento alla produzione di immagini passò molto tempo – bisogna attendere il paleolitico e i Sapiens delle grotte di Altamira e Lascaux – ma il meccanismo alla base è lo stesso. La pratica “attiva” dalla pareidolia è ampiamente documentata nella storia dell’arte (nelle chiese bizantine le lastre di marmo erano scelte e composte in modo tale da favorire l’individuazione di figure nelle venature, Dürer disegnava i volti trovati nei cuscini, Leonardo invitava a studiare le macchie sui muri per le composizioni di battaglie) e diviene sistematica nel Novecento, ad esempio in un artista come Ernst. La celebre testa di toro creata da Picasso con un sellino e un manubrio di bicicletta opera esattamente in questo senso.
Salvador Dalí, chiamava questa capacità “facoltà paranoica” e, diceva, è in grado di sottoporre il reale a una metamorfosi, così che l’allucinazione diventi la percezione di tutti: non soltanto vedere ma anche far vedere. L’operazione sovvertitrice di Dalì, osserva Tura, consiste «nel superamento del principio d’identità». Essere l’una e l’altra cosa contemporaneamente. Si può chiosare che lo sguardo paranoico fa proprio il meccanismo della metafora, annullando però la distanza tra i due termini.
È il principio delle più elementari illusioni ottiche, ma per l’artista catalano se portato a un livello estetico– percettivo sofisticato diventa «attitudine a vedere nelle cose altro da ciò che sono»: per farlo serve uno sguardo interstiziale, Dalì chiedeva una “fissità distratta”. Se per Dalì è sguardo paranoico, Jean Dubuffet definisce questa capacità “veggenza”. L’artista francese era affascinato in particolare dalla possibilità delle texture, sulle quali fonda i cicli delle Empreintes e poi dei Phénomènes.
Le immagini per Dubuffet sono rivelatrici e cangianti. Portarle alla luce è una operazione mantica e insieme maieutica. L’artista sembra un medium, il suo sguardo è in grado di captare e fare uscire l’immagine dall’indistinto, chiamarla alla vita e renderla visibile da tutti. Dubuffet chiede all’osservatore di esercitare in autonomia e paritariamente la propria veggenza e allo stesso tempo dà dei titoli alle singole immagini trovate: «Era istruttivo – scrive – verificare a che punto la funzione dell’artista consiste nel nominare le immagini non meno che nel crearle. Credo persino che questa funzione di leggere in ogni immagine date, di dotarla di associazioni d’idee (…) è molto più importante per un artista che l’elaborazione delle immagini stesse».
Lo sguardo paranoico o veggente fa proprio il fraintendimento come metodo. Un approccio ermeneutico che rende palese l’arbitrarietà di ogni operazione classificatoria nei confronti della realtà: «Una macchina per mettere in scacco ogni ragione e rimettere tutte le cose nell’equivoco e nella confusione », diceva Dubuffet. Osserva Tura: «Nel fare ricorso alla veggenza, Dalì e Dubuffet perseguono il discredito delle nostre categorie non svuotando la realtà di ogni sensatezza ma attraverso un’inflazione di senso».
Nella seconda parte del libro Tura riavvolge il nastro e racconta la stessa storia da un altro punto di vista: da macchie che generano immagini a immagini che degenerano in macchie.
In direzione contraria alla veggenza, nel Novecento si pone un moto di “anti–veggenza”. È Nietzsche a dubitare per primo della tendenza a semplificare e categorizzare, a equiparare oggetti diversi e infine all’astrazione da cui nasce il linguaggio: i fondamenti logici del pensiero sarebbero evolutivamente più efficaci in termini di sopravvivenza ma non in termini di conoscenza. La veggenza dello sguardo paranoico che vede ciò che non c’è ne è uno degli esiti estremi. Il sospetto nitzschiano ha generato una avversione nei confronti della lingua, colpevole di irrigidire la realtà contro la sua naturale fluidità. Il moto contro questa idolatria della lingua ha prodotto una ricerca estetica che procede per privazione di senso, quanto la precedente lavorava per eccesso di senso.
Il protagonista di Watt di Samuel Beckett è un esempio letterario di chi è sfuggito alla tirannia della semplificazione nominatrice. Nomi e cose si scollano, le seconde (ri)acquistano autonomia e diventano irriconoscibili. Secondo Tura, se Watt fosse un artista dipingerebbe come Pierre Bonnard, pittore del quotidiano privo di eventi e gerarchie, «antitragico, antisurrealista, anticontemplativo, anti–veggente».
L’arte di Bonnard è non– aneddotica, è costituita di immagini di “niente”, così come di “avvenimenti di niente” è costituita la giornata di Watt. Dipingere come se si vedesse tutto e niente alla volta, diceva Bonnard. L’uso frequente che il pittore fa del primo piano come spazio fuori fuoco è «in qualche modo un’esperienza prelinguistica, nella quale le cose non si dichiarano». Altrettanto spesso Bonnard dipinge «persone come se fossero macchie» e le fa «percepire come se stessimo facendo uso della nostra veggenza»: è un «percorrere all’inverso la via della posizione di senso, forzare lo sguardo in una sorta di esercizio di anti–veggenza».
Maestro dell’indecidibilità, Jean Dubuffet diventa anche il campione dell’anti–veggenza. Nel 1954 presenta opere composte con materiale tipicamente soggetto alla pareidolia: l’antropomorfismo grossolano dà l’impressione che si tratti di immagini trovate; le texture delle Tables paysagées nella lettura di Tura sono «il travestimento in termini visivi di un’esperienza innescata da un senso x, non umano e pertanto non logicizzato »; infine la glossolalia dell’Hourloupe, la cui fruizione autentica «non consiste nel confrontarvisi fisicamente, ma nel semplice sapere che esiste». Qualcosa che a Tura appare come compimento della “profezia” di Carl Einstein: «Le opere d’arte non vanno considerate come fenomeni estetici, bensì come forze biologiche. Attraverso il crescere delle forme aumentiamo la diversità contro ogni identificazione logica».






.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)
.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)