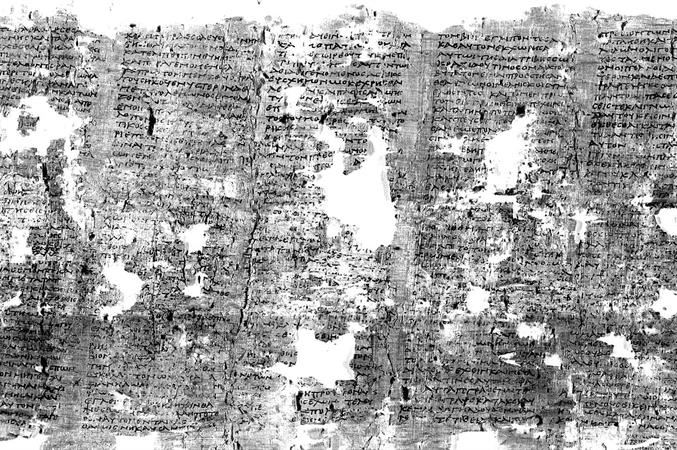Un’opera di Federica Matta nella mostra di Rochefort - federicamatta.com
«La pandemia ci dà l’impressione di navigare sul Titanic, forse solo per permetterci di trovare le nostre scialuppe di salvataggio nella poesia». Fra continue metafore e analogie, così parla l’artista franco-cilena Federica Matta, figlia d’arte del pittore surrealista Roberto Sebastián Matta (1911-2002). Fra sculture proteiformi e murali, di sogno sono pure imbevute le sue opere, permettendo all’osservatore di viaggiare di continuo fra un’immagine e l’altra. A Rochefort, sull’Atlantico, s’intitola proprio Viaggi degli immaginari l’ultima mostra dell’artista, nella storica e prestigiosa cornice della Corderia Reale, in dialogo col vicino percorso sensoriale notturno Oceana Lumina. Da «artista pubblica», come si definisce, la scultrice approfondisce da oltre 30 anni una poetica al servizio delle città e delle comunità che ha fatto il giro del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.
Lei ha creato sculture e murali all’aperto in diversi continenti, ma un momento chiave è stato il ritorno nel suo Cile...
«Sono cresciuta in un’epoca segnata dall’idea di un’arte al servizio della società e capace di giungere dappertutto. Sono tornata in Cile subito dopo l’uscita di Pinochet dal potere e ho compreso che avremmo riportato la gente in strada con l’arte. Ho quindi realizzato le sculture della Plaza Brasil a Santiago, inaugurate nel 1993, alle quali tengo molto. Da allora, sviluppo l’idea dell’agopuntura urbana, cioè mettere dell’arte in città per risvegliare gli immaginari e facilitare le relazioni».
Cosa vuol pungere?
«Il grigiore del cemento, prima di tutto. A Santiago, ho cercato a lungo il luogo ideale per imprimere una svolta in una città che appariva allora molto grigia. Plaza Brasil era stata abbandonata e mi è sembrata uno specchio dei danni della dittatura. Lì, ho capito che per risvegliare un luogo non occorrono sforzi portentosi, ma può bastare molto poco. Un fiore o dei totem variopinti nel punto giusto. Plaza Brasil è divenuta un luogo d’incontro e di protesta abitato da un’energia sociale. Con leggerezza, ho poi cercato di fare lo stesso dappertutto».
Ciò riguarda pure la memoria collettiva d’una nazione e d’una città?
«Sì. Talora, si tratta d’una memoria drammatica, con la qua- le le coscienze compiono un lavoro doloroso. Ma ogni società resta viva anche divenendo consapevole di certe paure collettive. In generale, per me, fare arte pubblica significa lavorare sempre assieme ad almeno una cinquantina di persone, in mezzo a una comunità. Mi sento una traduttrice al servizio d’u- na collettività. L’arte pubblica comincia con l’incontro e con la disponibilità verso l’altro. Inoltre, per me, dev’essere sempre diretta prioritariamente verso i bambini. Sono loro i nostri archeologi, nel senso che ci osservano e scavano in noi».
Quali tradizioni artistiche la ispirano?
«Soprattutto l’arte ancestrale, come quella polinesiana, delle altre isole del Pacifico, o dei popoli d’America Latina. Mi interessa molto il momento in cui quest’arte detta primitiva si salda all’artigianato, perché pure nell’artigianato esiste una dimensione sacra».
Cosa le hanno lasciato le Antille in cui ha passato in parte la sua giovinezza?
«L’idea che ogni forma culturale e artistica può sempre creolizzarsi, grazie agli scambi e a ogni incontro. Dopo 15 giorni passati in Messico, non posso più sentirmi la stessa persona. Siamo sempre trasformati da quanto ci accade».
Ogni forma d’umanesimo ha dunque radici multiple?
«Sì, ma questo non significa scadere in un relativismo assoluto. Portiamo in noi l’Europa, è chiaro, nel senso che il mondo funziona ancora su modelli nati storicamente in Europa. Sarebbe assurdo negare la forza di questi modelli, così come è giusto denunciarne le derive: dal colonialismo fino al capitalismo sfrenato. Personalmente, avverto un bisogno diffuso, nella nostra epoca, di riconquistare spazi dell’immaginario per superare un razionalismo divenuto estremo. Possiamo lasciarci trasformare da una sensibilità più spirituale. Proprio in Europa, parlando con la gente, ritrovo dappertutto i segni d’una stanchezza da ultra-organizzazione, per così dire, e la voglia di cambiare, uscendo dagli steccati rigidi».
I suoi Viaggi degli immaginari a Rochefort coniugano sculture, disegni e murali. Un invito a non restare fermi?
«Ho cercato d’instaurare un clima simbolico diverso rispetto a quello architettonico della Corderia Reale, immergendo il visitatore in acque profonde, per fargli perdere i riferimenti usuali. Ho concepito la mostra come un percorso, sperando che i bambini possano mettersi alla fine a colorare sui fogli messi a disposizione o altrove».
Al centro del più grande murale, c’è un’evocazione del dramma dei migranti nel Mediterraneo…
«Sì, perché penso che oggi non possiamo voltarci dall’altra parte per non pensare a chi attraversa il Mediterraneo. Infatti, non si tratta solo di drammi individuali. Si tratta d’uno specchio di ciò che è il nostro mondo. Del resto, analoghe traversate drammatiche costellano ogni continente. Accettare l’altro non è mai qualcosa di facile e immediato, perché dobbiamo innanzitutto accettarne l’opacità, prima d’accoglierlo. Oggi, vivere con i piedi per terra, significa accettare che una parte di noi sia già collegata con queste persone che soffrono in modo insopportabile».
Ci hanno già consegnato un messaggio?
«Certo, perché sono esseri umani come noi. Occorre tornare alla riflessione di Primo Levi. Quando ci troviamo di fronte a esseri umani e non di fronte a cose, possiamo capire che l’altro può sempre darci più di quanto noi potremmo dargli. Un altro essere umano è un tesoro pronto a schiudersi in noi. Per questo, ogni traversata umana è necessariamente un nuovo viaggio d’Ulisse. Persino quando stiamo in attesa, anche noi facciamo già parte di quel viaggio. Perché chi viaggia, rischiando la vita, sta già costruendo la coscienza collettiva del nostro tempo, anche quando ostinatamente non vogliamo ammetterlo, rifiutandoci d’accompagnare il dolore altrui».