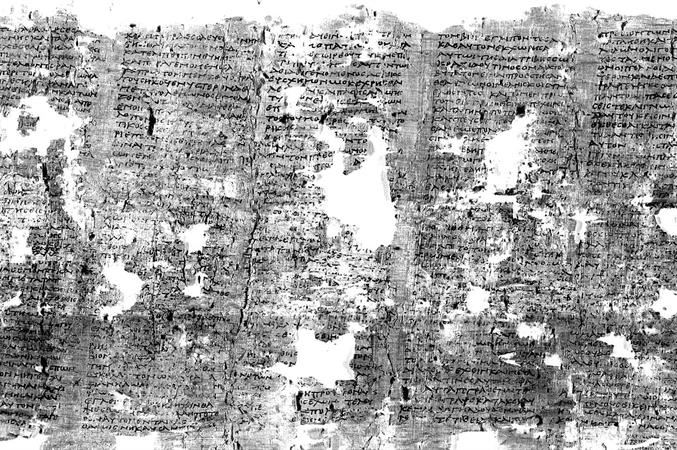Uno dei saggi più illuminanti che abbia letto sull’opera di Henry Moore è quello che Herbert Read scrisse negli anni Sessanta per accompagnare un volumetto dedicato al tema della “Madre con bambino” nell’opera dello scultore inglese. Read, appoggiandosi ad alcune considerazioni di Carl Gustav Jung, metteva in guardia dall’abitudine a cercare il significato dell’arte nelle parole dell’artista: l’artista è indipendente dalla sua opera, «dandole forma, l’artista ha fatto il massimo che poteva, e deve lasciarne l’interpretazione agli altri e al futuro». Read ricordava – e questo è forse la fonte più segreta dell’intera opera di Moore – «il misterioso pathos che si lega alla vitalità dell’inorganico». In realtà, il discorso di Read tendeva a mettere in luce come in Moore il tema dell’archetipo (in senso junghiano) trovasse compiuta espressione nella scultura Madonna col Bambino eseguita in bronzo per la chiesa di San Matteo a Northampton. Moore mira all’universale, a qualcosa che esiste da sempre e sempre esisterà anche se si rivela nella storia con modi e significati che possono essere diversi e persino opposti. E questo si sposa bene con l’idea dell’archetipo junghiano come eredità, memoria, sepolta nella mente dell’uomo e pronta a riemergere di volta in volta in figurazioni che hanno una valenza mitica.
In questo sta anche la vocazione monumentale di Moore; è qualcosa che gli appartiene inconsciamente, non è l’espressione di una volontà retorica (anche se da giovane viaggiò per alcuni mesi in Italia visitando i luoghi della classicità, studiando Giotto, Giovanni Pisano, Masaccio, Donatello); è ciò che va oltre la bellezza: cerca la vitalità imperitura di una forma. Si potrebbe notare – con Walter Benjamin – che l’inorganico esercita sull’uomo moderno un “sex appeal” insidioso: come il mito del ritorno all’origine, regressus ad uterum, che dal Faust di Goethe al “Fiore nero” di Felix Duque, è, in realtà, un mito mortifero. Read dopo aver evocato Jung, poco oltre chiama a testimoniare anche Freud e il suo istinto di morte come riduzione di ciò che ha vita organica allo stato inanimato. E commenta: a thanatos si oppone eros procedendo da questa immobilità inanimata per portare la mente di nuovo verso quella vitalità che sembrerebbe negata dall’inorganico. Non è quello che ha fatto Moore ogni volta che si è accinto a lavorare a una scultura?
Esiste una simbolicità che va oltre le nostre affezioni particolari e culmina nell’universalità delle forme. Ma – alla fine – questa universalità sembra ignorare la presenza umana reale, dispone totem antropomorfi in uno spazio che può essere aperto paesaggio oppure perimetro murario. È questo il caso della mostra di Moore che si è da poco aperta alle Terme di Diocleziano a Roma. Moore mancava dall’Italia ormai da un po’ di anni, una ventina circa. È ancora avvolta in un’aura di leggenda la grande mostra del 1972 al Forte del Belvedere a Firenze, curata da Giovanni Carandente. Fu l’apoteosi di Moore alla prova in uno scenario per lui ideale: natura e architettura, finalmente, testimoniavano insieme la capacità della scultura di Moore di rendersi “antica”, ovvero “naturale”.
Anche quando ha le forme più astratte, abbiamo l’impressione che la sua scultura sia il catalizzatore dello spazio dove viene collocata. La qualità metamorfica con cui si adatta al contesto, la rende al tempo stesso eroica e silenziosa, calma e imponente. Introducendo il catalogo della mostra (edito da Electa), Chris Stephens non ha remore ad affermare che se per moltissimi anni Moore è stato il più importante scultore del XX secolo, questo primato ancora gli appartiene «perché ha saputo catturare nella sua arte i temi e l’indole di un secolo inquieto e violento». Si può discuterne, e magari fare graduatorie e confronti. Ma certamente Moore ha saputo costruire un linguaggio che lo rende riconoscibile senza incertezze. È persino troppo “completo” nella sua classicità eterodossa.
Henri Bergson scrive, in Pensiero e movimento, che quando si evoca il tempo, è lo spazio che risponde all’appello. Moore è forse lo scultore occidentale che ha maggiormente sfidato il tempo su questo terreno. Ha realizzato opere che sono rocce, massi erratici, tronchi centenari induriti come pietre. E ha riflesso l’immagine umana in queste forme “inorganiche”. Nel Cristo crocifisso di Grünevald a Colmar, Testori vide la coesistenza del mondo minerale, vegetale e animale, eppure umano e divino, che si manifesta in un corpo torturato, cosparso di pustole e di spine, ritorto come un albero secolare. Ecco, Moore non arriverà mai a questo limite patetico, ma la sua “ricomposizione” del mondo è vicina a quella colta poeticamente da Testori in Grünewald.
Il tragico di Moore non è “cristiano” in senso proprio, è cosmico, aurorale o crepuscolare (come il regno delle antiche madri); la potenza plastica della sua scultura sta proprio nella fedeltà alla materia di cui è fatto il mondo.
Era stato affascinato, fin da giovane, dall’arte precolombiana: la figura del Chac Mool rivive nelle sue figure distese. Ma quelle antiche testimonianze di arte arcaica, presenti soprattutto nel Messico e nello Yucatan, svolgevano una funzione nel rito sacrificale e nel nome indicavano l’artiglio veloce del fato e della morte. Non si deve dimenticare questo retroterra “pagano”, perché la scultura di Moore, sebbene l’artista inglese avesse una coscienza del male e del dolore molto contemporanea (come testimoniano i suoi stupendi disegni eseguiti nei rifugi antiaerei londinesi durante i bombardamenti), vola oltre il presente per ritrovare la pace che regna nel paesaggio silenzioso dominato solo dalle ombre del mondo inanimato.
Si è parlato spesso di surrealismo per Moore; il surrealista inglese più importante, come argomenta in catalogo Sileno Salvagnini. Indubbiamente le forme fluide, l’immagine biomorfica delle sue figure umane che si elevano dai loro basamenti con la solenne indifferenza delle rocce marine levigate dai venti nei secoli, diventando architetture immaginarie e impreviste, è in realtà una sorta di solidificazione nello spazio di quella linfa vitale che trasforma il mondo. L’istante segreto della creazione, come nella scultura Three Points che sembra un omaggio alla Creazione dell’uomo di Michelangelo ma in realtà, facendo intervenire il terzo aculeo, sembra piuttosto evocare il mistero insondabile di quella scintilla originaria da cui tutto è nato.
Il mondo sotterraneo dei rifugi antiaerei trasfigura quel destino di seriale, ripetitiva, antitragica mortalità che può riguardare tutti e ciascuno, distesi a terra, come cadaveri dopo una mattanza o anonimi resti in un ossario; l’uomo che si specchia nella forma inorganica, ne salva l’immagine negandogli però l’identità individuale.
Nelle grandi architetture delle Terme di Diocleziano, la scultura di Moore sta come se si trovasse a casa propria. Non soffre minimamente la competizione con le antiche pietre. È una di esse, in mezzo a esse, accanto a ciascuna e senza ostentazione di modernità. È moderna, certo, inconfondibilmente moderna, ma anche misteriosamente antica. Pensiamo a una figura distesa di Moore e al Grido o al Guerriero di Marino Marini: tanto la prima sembra confondersi con le antiche vestigia, quanto la scultura più tarda di Marino si porrebbe in esplicita dissonanza, gesto esistenziale contro il tempo del nichilismo. Ed è ancora Herbert Read a trarre le conclusioni: «Moore accetta come naturale il miracolo della creazione, come se non richiedesse un sacrificio alla potenza divina, ma piuttosto una preghiera di ringraziamento».
Roma, Terme di Diocleziano
Henry Moore
Fino al 10 gennaio 2016