Quell’anno, era il 1957, l’aula era particolarmente triste e scalcinata. Una delle tante di un vecchio fabbricato malamente rimesso in sesto cent’anni prima, nel centro del paese, a Vho di Piadena. Era grande, umida e buia quella classe: l’unica finestra affacciava sui tetti delle case del vicolo che chiudevano l’orizzonte e accorciavano lo sguardo di chiunque avesse voluto divagare guardando fuori. Il cielo era ridotto a una striscia. «Eppure – ricorda il maestro Mario Lodi – in quel breve e triste spazio l’occhio attento dei miei ragazzi non era distratto come il mio. Tutto accadde durante una delle nostre solite conversazioni». Un giorno come tanti in una prima elementare: il maestro in mezzo ai bambini ascolta e fa domande, organizza quelle voci che parlano di storie concrete e di vita vera. Improvvisamente un bambino si alza e va alla finestra, con un fare di sorpresa che richiama di colpo tutti gli altri. Il maestro non li sgrida, lascia fare. Non è così che gli hanno insegnato ai corsi di formazione ma lui sa che lì più che le teorie valgono le esigenze dei bambini veri. Alla finestra, nel grigiore diffuso, tutti gli occhi inseguono il passo felpato di un gatto che ha puntato una preda che nessuno vede. «Un topo, no. Forse un uccellino. Poverino, chissà che dispiacere avrà la sua mamma se il gatto se lo piglia…». La storia di Cipì è nata così, da una sequela di giorni di trambusto in classe, dai pensieri dei bambini che si intrecciano ansiosi e curiosi sul destino di un passero che fa il nido, cova le uova, fa un mucchio di sacrifici per allevare i piccini poi arriva il gatto o il gufo di notte e zaf! Se lo piglia… L’argomento tiene banco per giorni, gli occhi osservano e frugano, in quella fetta di cielo, altri indizi e ciascuno dice la sua finché, condita di continui riferimenti alla vita vera e di fantasie poetiche, prende corpo la storia semplice di Cipì, il passero coraggioso che lotta per sopravvivere ai pericoli della natura, amorevolmente protegge i figli e insegna loro a stare al mondo. Stampata in classe con un rudimentale armamentario tipografico, la storia scritta diventa un libro uscito per la prima volta negli Struzzi Einaudi. È il 1961. Con la freschezza e la modernità di un classico, cinquant’anni dopo (e ventidue ristampe) la favola vera di Cipì torna in un’edizione speciale da anniversario per Einaudi ragazzi (pagine 84, euro 14,00) con un testo inedito di Mario Lodi e i disegni originali dei bambini di allora. «Cipì è una storia infinita – spiega il maestro –, è la metafora dell’esistenza di ogni bambino. Nella semplice vita di quegli animali i bambini rivedevano la propria. Perciò erano tanto coinvolti». Cipì era vita e anche scuola; e, cosa straordinaria, i due mondi non erano separati. Alla Drizzona, due passi da Piadena, Mario Lodi ci accoglie nella bella cascina, casa di famiglia, dove da oltre vent’anni con l’aiuto della figlia Cosetta dirige il Centro delle arti e del gioco. Anche Vho, dove il maestro – classe 1922, novant’anni a febbraio – è nato e ha insegnato per una vita, è a una manciata di chilometri. Bassa padana sterminata, tra Cremona e Mantova, costellata di cascine semiabbandonate, un tempo fulcro dinamico della vita agricola. Qui, agli inizi degli anni Cinquanta, maestro alle prime armi, Mario Lodi deve inventare un nuovo modo di fare scuola. «Sono nato l’anno della marcia su Roma e mi sono diplomato il giorno in cui il Duce dal balcone di piazza Venezia portava l’Italia in guerra, ma quando ho cominciato a fare il maestro il Paese era cambiato. La guerra era finita, avevamo perduto tutto e bisognava ricostruire. Però erano nate la Repubblica e la Costituzione, la democrazia della parola. Noi maestri avvertivamo che si parlava un linguaggio nuovo ma eravamo spaesati, confusi. Arrivavamo da una scuola fascista, autoritaria che ci aveva insegnato a obbedire, a ritagliare le foto del Duce e attaccarle sul quaderno. Eravamo impreparati».
Bisognava cambiare una società, insegnare in modo nuovo. Istruire e insieme educare. Formare persone e cittadini che sapessero parlare il linguaggio della democrazia. Ma come? «La mia maestra era stata severa e molto astuta. Si definiva una maga. Diceva di avere gli occhi anche dietro. Si metteva alla finestra dove ci vedeva riflessi nei vetri e così, con la prova dei nostri movimenti, poteva castigarci. Era una donna autoritaria che accettava le intromissioni della disciplina militare. Ci portava in cortile dove c’era un’armeria e noi potevamo familiarizzare con i fucilini giocattolo». Per i maestri che non si rassegnavano a replicare una pedagogia autoritaria dentro una scuola impegnata unicamente a trasmettere contenuti quelli furono anni di ricerca, di studio, di scambio di esperienze. «Eravamo convinti che l’educazione toccava a maestri e genitori. Ma anche loro della scuola vedevano il lato punitivo. Mi affidavano il figlio sulla porta dell’aula e mi dicevano: “È uno zuccone e un lavativo, gliele suoni quando occorre!”».
Non erano bambini facili. Figli di contadini, abituati alla campagna, a muoversi, correre, saltare. All’insegnante maschio poi appioppavano la quota maggiore di pluribocciati, quelli dell’ultimo banco, rumorosi, invadenti. «La scuola per loro era un sacrificio, una specie di prigione». Lo spaesamento era grande ma l’intelligenza, la fantasia e soprattutto il cuore aiutavano il maestro. «Quando i bambini arrivano a scuola hanno già una loro cultura; non sanno scrivere, ma parlare ed esprimere se stessi sì. Io cominciavo ascoltando i racconti della loro vita, le loro esperienze. E qui, dalle prime discussioni, dalla necessità di darsi delle regole che evitassero il caos (chi deve parlare per primo?), iniziava la scuola di democrazia. Che continuava con il problema dei voti (chi li dà?), da cui si apriva il capitolo della partecipazione». Nascevano così il metodo dell’alzata di mano e dell’autovalutazione che i bambini imparavano presto a maneggiare con serietà, talvolta persino esagerata. «Del resto – si chiede il maestro – come si può valutare gli altri se prima non c’è conoscenza di sé?». La scuola delle regole di Mario Lodi, quelle necessarie alla vita comunitaria, riusciva a essere anche scuola di libertà che partiva dai bambini e non dai libri. «I programmi sono dentro i bambini, sono le loro esperienze che suggeriscono un problema di matematica, un’analisi scientifica, una ricostruzione storica. Un testo da scrivere in modo collettivo, un disegno da realizzare esprimendo tutto il proprio mondo». Era un scuola ordinata spontaneamente quella di Mario Lodi, dove ai bambini era riconosciuto il diritto a un’esperienza di formazione e di crescita. E il risultato era che senza voti e senza bocciature, con molti più libri del solo sussidiario quei bambini alle medie grazie alla loro preparazione erano i migliori.



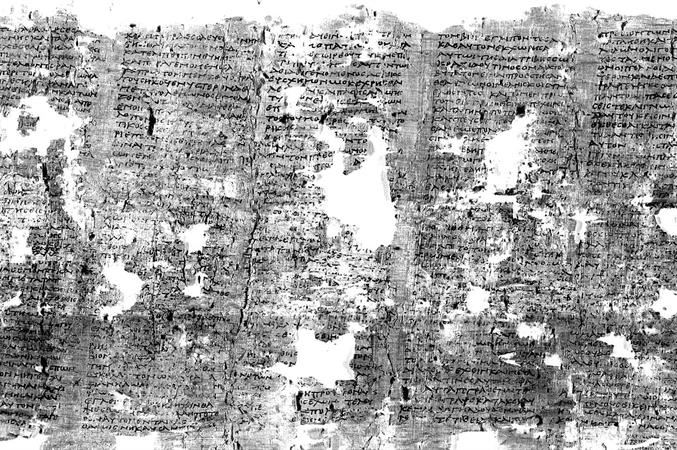


.jpg?dt=1713897716280&Width=300)
.jpg?dt=1713897716280&width=677)









