La logica del merito è stata sempre molto potente. Noi esseri umani abbiamo una esigenza profonda di credere che esista un rapporto logico e giusto tra i nostri talenti, azioni, impegno e i nostri risultati. Ci piace pensare che il nostro stipendio sia il frutto della nostra qualità e del nostro impegno, che il voto a scuola dipenda dal nostro studio, che ci siamo guadagnati i nostri premi (meritum) viene da mereri: guadagnare). È naturale, è una esigenza vera. Il vero problema non sta tanto o solo nell’idea di merito in sé, ma nelle risposte che diamo alle domande sul riconoscimento del merito nostro e soprattutto di quello degli altri. Qohelet questo lo sa molto bene: «E ancora vidi sotto il sole che non è dei veloci la corsa, né dei guerrieri la guerra, né dei sapienti il pane, né dei più abili la ricchezza, né dei più sensibili la compassione» (9,11).
Gli uomini hanno sempre cercato di reagire a questo scenario che ci appare come un grande spettacolo di ingiustizia. Nelle civiltà antiche, la principale soluzione all’ingiustizia del mondo era immaginare un Dio diverso da noi che seguiva una giusta politica di ricompense e pene. Si prendeva il dato storico dell’ineguaglianze e delle ingiustizie, e si conferiva alla realtà un crisma religioso. Si trasformava l’apparente ingiustizia in una giustizia invisibile e più profonda, e si ordinava il mondo trovando un senso religioso nelle ricchezze e nelle disgrazie proprie e degli altri.
Così al ricco e potente gli veniva conferito lo status di "benedetto" senza chiamarlo a nessuna conversione; e il povero e sventurato era condannato due volte: dalle sciagure della vita e da Dio. Il bisogno morale di riconoscere il merito produceva nei più poveri e sventurati un immenso senso di colpa per le proprie disgrazie.
Altri umanesimi religiosi hanno invece reagito immaginando che le ingiustizie "sotto il sole" sarebbero state eliminate in altre vite "sopra il sole", dove il povero ma giusto sarebbe stato premiato e il ricco ma empio punito. La terra è ingiusta, il paradiso no. La logica economico-retributiva restava, ma l’orizzonte della sua applicazione usciva dal tempo storico per estendersi all’eternità o almeno ad un’altra vita. Le teorie del merito hanno bisogno di un umanesimo di individui moralmente diversi tra di loro, dove ognuno ha la propria "scheda" personalizzata di azioni/ricompense. Le società olistiche non sono meritocratiche.
Per questa sua anima umanistica e personalista, l’ideologia meritocratica, che fa del merito il criterio per valutare, classificare e ordinare persone e organizzazioni, è molto affascinante, seducente e cattura molti. La ritroviamo al centro della cultura delle grandi società e banche multinazionali. La sua tecnologia simbolica è duale. Da una parte, le grandi imprese costruiscono un sistema sofisticato di incentivi disegnati con l’obiettivo di individuare e premiare il merito, concepito in funzione degli obiettivi aziendali. Dall’altra, il lavoratore che si ritrova dentro questo meccanismo premiale, legge il proprio stipendio e i benefit come un segnale della propria meritorietà. Un contratto perfetto, continuamente alimentato da entrambe le parti perché appare mutuamente vantaggioso: l’impresa soddisfa il suo bisogno di razionalità e di ordinare la realtà ai propri fini, e il lavoratore soddisfa il proprio bisogno di sentirsi meritevole e valorizzato.
È una ideologia cresciuta come erba rampicante sull’albero retributivo nel giardino della fede biblica, che sta conoscendo un successo incredibile e crescente nell’epoca del capitalismo individualistico. Come ci ha mostrato oltre un secolo fa Max Weber, nell’umanesimo ebraico-cristiano c’è una linea che ha interpretato il successo economico come un segnale di elezione e di salvezza. L’attuale cultura economica ha radicalizzato e universalizzato quel meccanismo religioso-psicologico. Lo ha secolarizzato ed esteso dall’imprenditore all’intero sistema economico, produttivo, finanziario, dei consumi. La quantità e qualità degli stipendi e degli incentivi (e dei consumi) diventano i nuovi indicatori di elezione e di predestinazione per il "paradiso" dei meritevoli. La dimensione simbolico-religiosa del denaro e del successo si è così amplificata, radicalizzata, generalizzata.
Ma il tarlo di questo e di tutti i sistemi religiosi retributivi compare chiaramente quando lasciamo il paradiso e scendiamo verso i gironi del purgatorio e dell’inferno. Il merito ha un bisogno necessario del demerito. È una realtà posizionale e relativa: il mondo dei meritevoli funziona se il merito può essere definito, ordinato, gerarchizzato, misurato, messo in rapporto con il demerito. Al di sopra un meritevole ci deve essere qualcuno più meritevole, e uno meno meritevole al di sotto. È un sistema castale perfetto, dove i bramini hanno bisogno dei paria, ma non li possono toccare per non lasciarsi contaminare dal loro demerito.
La gestione più semplice del demerito consiste nel presentarlo come un passaggio obbligato verso il merito, come una tappa del cammino. Questa gestione funziona molto bene con i giovani, ai quali viene mostrato il "diletto monte", dicendo loro che lo potranno scalare solo se sapranno "crescere", anche se chi propone questo scenario sa benissimo che nella casa del merito non ci sono abbastanza posti. E così, quando arrivano i primi fallimenti e il merito sperato non fiorisce secondo gli obiettivi prefissati, il miracolo si compie: il lavoratore è stato educato a interpretare il proprio fallimento come demerito, e così, docile, accetta il proprio triste destino. Il culto è perfetto: il "credente" interiorizza questa "religione" e la implementa autonomamente. E la produzione di massa di sensi di colpa diventa la grande scoria della nostra economia, alimentata dall’aggressività, superbia e spocchia che accompagnano i laudatores della meritocrazia.
Qohelet ci dice allora qualcosa di molto importante: leggere la nostra vita e quella degli altri come una contabilità meriti/premi, demeriti/punizioni è una soluzione vana e ingannatrice alla domanda di giustizia sotto il sole, perché il meccanismo del merito non può rispondere alle domande più profonde sulla giustizia, neanche su quella economica. È vanitas. E soprattutto non ha nessuna risposta quando la sventura fa la sua comparsa sulla scena: «L’uomo non sa quando il suo tempo verrà, come pesci acchiappati dalla rete, come uccelli invischiati, così sono ghermiti i figli dell’uomo nell’ora maligna, che improvvisa si abbatte su di lui» (9,12). Quando vediamo uno sventurato non possiamo dire nulla sulla sua vita. Può essere un buono o un cattivo, intelligente o stolto, la sua sventura e la sua fortuna non ci consentono di articolare nessun discorso sul suo merito. Le parole delle nostre sventure sono mute, da sole sono incapaci di parlare della moralità nostro passato e del nostro futuro. Le brillanti carriere si incrociano con separazioni, depressioni, malattie, eventi che il sistema degli incentivi semplicemente espelle. La democratica casualità dell’«ora maligna» scardina la macchina meritocratica della nostra economia. Niente come le malattie serie e le morti premature sono estranee alla nostra cultura capitalistica. Non c’è posto per i tempi e i momenti della sventura, che sono visti come attriti, sabbia negli ingranaggi, e ancor meno c’è posto per il tempo della morte – sono troppo pochi i colleghi presenti ai funerali, o accanto ai capezzali delle nostre lunghe agonie.
Ma partendo da Qohelet possiamo spingerci ancora oltre. Prendendo sul serio lo spirito delle sue antiche parole, possiamo dire che il merito è una parola ambigua, raramente amica della gente e dei poveri – e ancora di più lo è la meritocrazia. La logica "dell’operaio dell’ultima ora", una delle più belle pagine mai scritte, è una critica all’idea di merito non meno radicale di quella di Qohelet (o di Giobbe), che per essere compresa va letta dentro la polemica dei primi cristiani verso la religione retributiva del loro tempo. La critica di Qohelet al merito è fondamentale per capire i pericoli insiti in una intera vita sociale costruita a partire dalla logica del merito come viene concepito e promosso dalle imprese. Potevamo immaginare un altro capitalismo meno ancorato alla religione retributiva, e quasi certamente avremmo avuto un pianeta meno malato e relazioni sociali più sane; ma oggi dobbiamo almeno evitare che la sua logica diventi <+CORSIVOIDEE_BAND>la <+TONDOIDEE_BAND>cultura dell’intera vita sociale. E invece incentivi e meritocrazia stanno occupando progressivamente molti ambiti non-economici.
<+CAP2IDEE>L<+TONDOIDEE_BAND>a ragione di questo straordinario successo è facile da capire. Tutti sappiamo che i meriti e i demeriti sono molti. Ci sono ottimi lavoratori che sono cattivi genitori, e viceversa, e normalmente conviviamo con meriti e demeriti di cui non siamo consapevoli, che si rivelano solo in alcuni passaggi decisivi, a volte negli ultimi giorni quando scopriamo di aver vissuto una vita con pochi meriti apparenti, ma che ci ha meritato un buon abbraccio dell’angelo della morte. L’insidia che si nasconde dentro l’ideologia meritocratica è dunque sottile, e in genere invisibile. Le imprese riescono a presentarsi come luoghi capaci di remunerare il merito perché riducono la pluralità dei meriti soltanto a quelli funzionali ai propri obiettivi: un artista che lavora in una catena di montaggio non è meritevole per la sua mano che sa dipingere, ma per quella che sa avvitare bulloni. Il merito dell’economia è allora facile da premiare perché è un merito/demerito semplice, troppo semplice da vedere e quindi da misurare e premiare. Gli altri meriti in ambiti non economici sono invece molto più difficili da vedere, e ancor più da misurare. Ecco allora che si svela il grande rischio: data la sua facile misurabilità, il merito nelle imprese diventa l’unico merito "visto", misurato e premiato nella società tutta. Con due effetti: si incentivano troppo i meriti quantitativi e misurabili, e si fanno atrofizzare quelli qualitativi e non produttivi. E aumenta la distruzione delle virtù non economiche ma essenziali per vivere bene (mitezza, compassione, misericordia, umiltà …). La grande operazione dell’umanesimo cristiano è stata la liberazione dalla cultura retributiva che dominava il mondo antico, e dalla colpevolizzazione degli sconfitti. Non dobbiamo rassegnarci alla sua svendita per il piatto di lenticchie del merito. Noi valiamo molto di più.
<+CORSIVOIDEE_BAND>Dedicato a Pier Luigi Porta, caro amico e maestro di pensiero e di vita.<+QUALIFIDEE>l.bruni@lumsa.it<+RIPRODUZ_RIS>









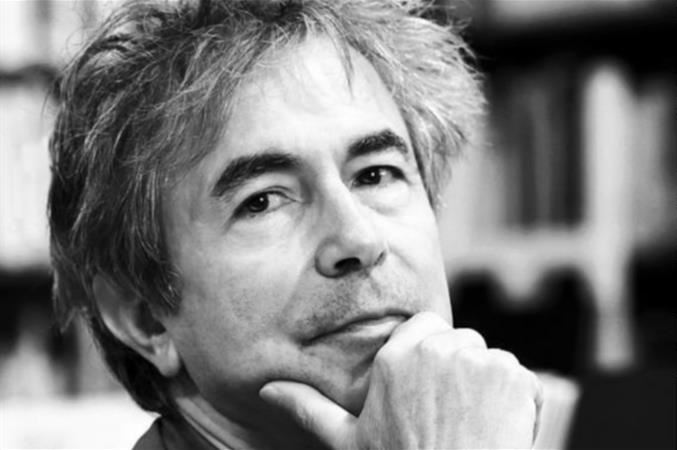




.jpg?Width=300)
.jpg?width=677)